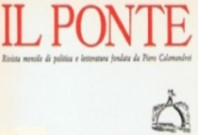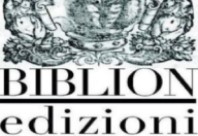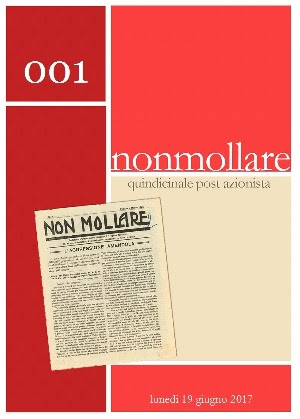HIROSHIMA E GLI ARSENALI NUCLEARI di Salvatore Rondello
di Salvatore Rondello
23-09-2025 - UNO SGUARDO SUL MONDO di Salvatore Rondello
Ottanta anni fa, le due bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki hanno segnato la storia e messo in ginocchio l’umanità.
Allora, un “ragazzino” e un “grassone” rivelarono al mondo l’inizio dell’era atomica. La prima bomba era stata chiamata in codice Little Boy, la seconda Fat Man. Vennero sganciate il 6 agosto 1945 su Hiroshima e il 9 agosto su Nagasaki. Non ne occorse una terza, perché il Giappone che aveva rifiutato di capitolare sulle condizioni dell’ultimatum consegnato durante la Conferenza di Potsdam stavolta chinò il capo e si arrese. Quel duplice attacco doveva dimostrare la potenza distruttrice degli Stati Uniti e impedire lo stillicidio di soldati nei continui sbarchi con la tattica del “salto della rana” di isola in isola che aveva dimostrato solo l’irriducibilità nipponica a chiudere quella guerra.
Le vittime di Hiroshima e Nagasaki, incenerite dall’esplosione di un’arma apocalittica o uccise a distanza dalla radioattività, oscillano tra le centomila e le duecentomila, civili in schiacciante maggioranza. I problemi morali innescati da quella decisione e da quel gesto, che furono allo stesso tempo militari e politici, allora come oggi continuano a stendere la loro ombra sulla discussione su quanto la storia ha registrato. Si è trattato dell’unico utilizzo di ordigni nucleari in guerra. Allora li avevano solo gli Stati Uniti, oggi le nazioni con arsenale atomico sono nove, oltre agli Usa, la Russia già erede dell’Urss, Regno Unito, Francia, Cina, Pakistan, India, Corea del Nord e Israele, e altri hanno tentato di crearlo, come l’Iran.
Era la mattina del 6 agosto 1945 quando un B-29 Superfortezza volante, con un nome dipinto sulla fusoliera solo il giorno prima, si affacciò sulla città di Hiroshima. Il nome, entrato nella storia, era Enola Gay, la madre del colonnello Paul Warfield Tibbets Jr., 30 anni, pilota del quadrimotore in cui si trovavano il capitano copilota Robert A. Lewis, che aveva ceduto la cloche al superiore non senza celare il proprio malumore, l’addetto all’armamento della bomba e comandante della missione capitano William Parsons, il suo assistente sottotenente Morris Jeppson, il navigatore capitano Theodore Van Kirk, il bombardiere maggiore Thomas Ferebee, gli operatori radar e radio sergente Joe S. Stiborik e l’aviere scelto Richard Nelson, l’addetto alle contromisure radar tenente Jacob Beser, gli ingegneri di volo sergenti Wyatt Duzenbury e Robert Shumard, il mitragliere di coda sergente George Caron. La ricognizione aveva assicurato che le nubi dei giorni precedenti non coprivano più l’area urbana. Tutto era stato studiato a tavolino, tutti i calcoli fatti, rifatti e riverificati.
Alle 8.15 la pancia del B-29 si aprì lasciando precipitare verso terra un’unica bomba, con 60 chili di uranio 235. Anche Hiroshima era stata raggiunta dall’allarme aereo diramata dai radar giapponesi che avevano intercettato prima una grossa formazione di bombardieri americani ad alta quota, poi solo tre: Enola Gay, The Great Artiste e un terzo che solo dopo verrà macabramente chiamato Necessary Evil, col solo compito di scattare fotografie su quanto sarebbe accaduto. Questo particolare aveva frenato sull’invio massiccio di caccia intercettori, per risparmiare la preziosissima benzina di cui il Giappone scarseggiava.
Little Boy, come programmato, esplose a circa 600 metri dal suolo, con effetti tecnicamente equivalenti allo scoppio di 16.000 tonnellate di tritolo. In un attimo, in una luce accecante, vennero cancellate almeno settantamila vite e la quasi totalità di Hiroshima. Seguì un uragano atomico. Di alcuni civili restò solo la sagoma nera come fosse stata dipinta su un muro. Fu un’apocalisse, e non era un’iperbole. I risparmiati dalla morte immediata, vivranno in un inferno per il resto della loro vita segnata dalla contaminazione e dalle sofferenze per le quali non esisteva cura.
Il 6 agosto 1945 la Germania nazista era già capitolata da tre mesi e la bandiera dell'Urss sventolava sui territori dell'Europa orientale al posto di quella del Terzo Reich. Il Giappone imperiale, nonostante le enormi perdite e i bombardamenti incendiari che avevano ridotto in cenere Tokyo e altre grandi città, aveva però continuato a combattere. Fu sia per avere ragione di un nemico irriducibile che per mandare un eloquente messaggio a Mosca, alleato già trasformatosi in avversario, che quel giorno il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, ordinò il lancio di una bomba nucleare sulla città di Hiroshima, seguita tre giorni dopo dall'ordigno che colpì Nagasaki, secondo e ultimo impiego dell'arma atomica in un conflitto.
Era stato stabilito che il 9 agosto il secondo ordigno, Fat Man, sarebbe stato sganciato sulla città di Kokura. Ma uno strato di nubi fece cambiare la rotta del B-29 dopo tre inutili giri per effettuare il puntamento e il corso della storia. Il carburante ancora nei serbatoi del quadrimotore che scintillava alla luce del sole consentiva di raggiungere l’obiettivo secondario, che era Nagasaki. Le sirene dell’allarme aereo erano risuonate quel mattino per 40 minuti, e alle 08.30 smisero. Quando poco prima delle 11 si materializzarono due sagome all’orizzonte gli osservatori radar giapponesi pensarono fossero semplici ricognitori. E poi c’erano nuvole anche su Nagasaki, difficile ipotizzare il bombardamento. Ma Fat Man non poteva essere riportato alla base, ed era escluso che nel caso di mancanza di benzina si potesse tentare una manovra di ammaraggio.
Il comandante Charles W. Sweeney, che ai suoi ordini aveva l’equipaggio del B-29 The Great Artiste, non ancora pronto nelle modifiche per quella missione e utilizzato come ricognitore da affiancamento, contravvenendo alle disposizioni ricevute accese allora la strumentazione radar e da essa pervenne l’indicazione dell’obiettivo. E così il B-29 chiamato Bockscar sganciò la bomba al plutonio (poco meno di sei chili e mezzo) che esplose a un’altezza di meno di mezzo chilometro dalla zona dove sorgevano le industrie belliche, a pochissimi chilometri (4,5 o 6) da Nagasaki, parzialmente protetta da alcune colline. Non abbastanza protetta da poter impedire circa ottantamila vittime tra morti all’istante e feriti contaminati. Il Bockscar dopo la missione riuscirà fortunosamente ad atterrare a Okinawa con i serbatoi praticamente a secco.
Viene ritenuto che il duplice bombardamento atomico abbreviò la guerra e risparmiò agli americani la perdita di decine di migliaia di soldati. Altri ritengono che il Giappone, ormai stremato, stesse per chiedere all’Unione Sovietica di intercedere con gli Alleati per giungere a un armistizio. Ma due giorni dopo l’olocausto nucleare di Hiroshima Stalin aveva dichiarato guerra al Giappone per prendersi una parte di bottino sul fronte del Pacifico e quindi nessuna altra strada era praticabile se non la resa incondizionata. Che il Giappone dichiarò unilateralmente il 15 agosto con un discorso alla radio dell’imperatore Hirohito. Era la prima volta che i giapponesi udivano la voce di colui che ritenevano un dio in terra, e quella voce valeva molto più di quella dei militari che avevano voluto una guerra chiusa nel disastro dei due funghi atomici.
Nel dopoguerra furono in molti a sostenere che l'ecatombe radioattiva abbia evitato la carneficina ancora più immane che sarebbe stata comportata da uno sbarco alleato in Giappone. Sono calcoli che significano ben poco per i sopravvissuti, molti dei quali hanno dovuto affrontare conseguenze fisiche e psicologiche pesantissime, oltre allo stigma di essere 'hibakusha', esposti a radiazioni e dunque oggetto di pregiudizi. Proprio gli 'hibakusha' sono però diventati la voce più importante che possa levarsi contro l'utilizzo di armi atomiche, e quelli ancora in vita sono stati incontrati da numerosi leader mondiali e hanno fatto così valere al massimo la loro forza simbolica. Nel 2019 papa Francesco incontrò numerosi sopravvissuti durante la visita apostolica a Hiroshima e Nagasaki, quando ricordò l'inspiegabile orrore subito dalle vittime degli attacchi. Tre anni prima Barack Obama era stato il primo presidente degli Stati Uniti in carica a visitare Hiroshima: non chiese scusa ma abbracciò i superstiti e lanciò un appello per un mondo senza bombe nucleari. Nel 2023 una delegazione di hibakusha incontrò poi i leader del G7, riuniti, sotto la presidenza giapponese, proprio nella città martire.
Adesso, dopo ottant’anni lo spettro di una guerra nucleare è tornato più immanente di quanto non fosse stato nell’ultimo decennio della Guerra Fredda. In Giappone, unico Paese al mondo ad aver subito un attacco atomico, quest'anno le commemorazioni della tragedia hanno un sapore più amaro, più potente, in un mondo che vede alcuni leader agitare con fin troppa leggerezza lo spettro dell'arma finale e sempre più nazioni interessate a dotarsene, ritenendola l'unica efficace forma di deterrenza in un mondo senza più equilibri certi.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per l’ottantesimo ricorrenza del bombardamento di Hiroshima, ha scritto: “Quei tragici avvenimenti, le molteplici sofferenze patite negli anni successivi dai sopravvissuti, rimangono per l’umanità monito che non può essere dimenticato. L’annientamento dell’umanità: la prospettiva che l’uso del nucleare ha posto dinanzi a tutti noi. Oggi, in uno scenario segnato da guerre, crescenti tensioni e contrapposizioni, occorre ribadire con forza che l’uso o anche la sola concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti nucleari appare crimine contro l’umanità. La architettura globale del disarmo e della non proliferazione delle armi nucleari, tra i cardini del sistema multilaterale faticosamente costruito nel secondo dopoguerra, non può essere abbandonata, a rischio di accelerare un clima di scontro. A cinquanta anni dalla ratifica del Trattato di Non Proliferazione, la Repubblica Italiana ribadisce l’obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari, con la valorizzazione completa degli organismi internazionali di controllo predisposti a questo scopo. Nessuna guerra nucleare può essere combattuta o vinta, a meno di mettere a rischio la stessa esistenza della vita sul pianeta. I bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki non sono solo episodi bellici tra i più dolorosi del secolo scorso, né rappresentano soltanto una ferita ancora aperta per il popolo giapponese. Le due città sono moniti eterni di una memoria universale che testimonia dove può portare la furia distruttrice dell’uomo e, al contempo, esempio di resilienza, di ciò che è possibile costruire con la pace”.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita istituzionale in Giappone, ha incontrato l'associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari, la Nihon Hidankyo, insignita l'anno scorso del Premio Nobel per la Pace. Parlando agli Hibakusha, i sopravvissuti, ha espresso gratitudine per il loro impegno nel mantenere viva la memoria e per il loro costante appello affinché nessun altro popolo debba mai affrontare una tragedia simile. Il Presidente ha detto: “Il vostro insegnamento è un messaggio di speranza”, ed ha ribadito l'urgenza di un'umanità che impari dai propri errori.
Mattarella ha anche denunciato la pericolosa retorica bellicista che ha recentemente preso piede, sottolineando come, nonostante l'orrore di Hiroshima e Nagasaki, la proliferazione delle armi nucleari e le minacce di conflitti atomici siano ancora una realtà inquietante. Il presidente ha condannato la rinnovata narrativa nucleare promossa dalla Federazione Russa spiegando come Mosca abbia instillato l'inaccettabile idea che gli ordigni nucleari possano essere strumenti ordinari nei conflitti, dimenticando come invece portino inevitabilmente alla distruzione totale.
Il presidente ha ribadito con fermezza la posizione dell'Italia, che condanna qualsiasi uso della guerra nucleare e rinnova il suo impegno per il disarmo. Ha ricordato l'importanza di continuare a lavorare per la piena realizzazione “dell'Articolo VI del Trattato di Non Proliferazione Nucleare”, impegnandosi a sostenere un multilateralismo efficace come miglior garanzia di pace. Mattarella ha concluso: “Una guerra nucleare non può essere vinta da nessuno e non deve mai essere combattuta”, sottolineando l'importanza di un'azione condivisa e di un dialogo strategico tra tutte le potenze nucleari.
Invece, durante i periodi di pace, gli arsenali nucleari sono stati continuamente riempiti e le potenze dotate di armi nucleari sono aumentate. Una follia, quando la saggezza avrebbe voluto riempire i granai per sfamare gli affamati del mondo che muoiono a milioni ogni anno soltanto per malnutrizione e per mancanza di farmaci. Una strage silenziosa portata avanti in tempo di pace senza sparare un colpo. Ditemi voi se anche questo non è un crimine condannabile alla pari delle guerre che hanno l’aggravante della distruzione oltre alle vittime causate dalle azioni militari.
Chi meglio di Italo Svevo ha evocato la catastrofe di allora e la possibile catastrofe di oggi. Nell’ultima pagina della “Coscienza di Zeno” ha scritto: “Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un pò più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie”.
Il volume Four Philosophers and the Bomb (London, Routledge, 2025), dovuto a quattro studiosi italiani di diversa formazione (Alberto Castelli, Giunia Gatta, Micaela Latini e Francesco Raschi), attesta l’elevato livello a cui è pervenuta la nostra storiografia filosofica anche quando si misura con autori e problemi contemporanei, sui quali non sempre esistono contributi specifici. Gli autori affrontano con rigore e densità critica la riflessione filosofica sull’arma atomica attraverso quattro figure centrali del pensiero novecentesco, di diverso orientamento: Bertrand Russell, uno dei padri fondatori della filosofia analitica, Raymond Aron, grande sociologo e politologo francese, Karl Jaspers, uno degli esponenti più autorevoli della filosofia dell’esistenza, e Günther Anders, filosofo e scrittore tedesco di origine ebraica. Il libro si colloca al crocevia tra storia delle idee, riflessione morale, politologia e filosofia della tecnica, offrendo un quadro comparativo che valorizza tanto le divergenze quanto le convergenze.
Nell’introduzione, Alberto Castelli contestualizza storicamente i contributi e poi li mette in rapporto con lo status quaestionis degli studi attuali. L’autore evidenzia come la maggior parte delle tesi discusse nel libro siano state formulate tra la seconda metà degli anni ‘40 e i primi anni ‘60. Si tratta di un periodo caratterizzato da tensioni dovute al progressivo intensificarsi della corsa agli armamenti, con focolai critici rappresentati dalla guerra di Corea, dall’invasione sovietica dell’Ungheria e dalla crisi di Suez. Il mondo conobbe la paura di essere sull’orlo di una terza guerra mondiale, rispetto alla quale le prime due sarebbero sembrate insignificanti. In breve, Russell, Jaspers, Aron e Anders si sono trovati a riflettere in un’atmosfera cupa e spaventosa, segnata dal timore che la corsa verso l’autodistruzione potesse essere inarrestabile. Con una certa disinvoltura, non priva di ragioni, Castelli sottolinea che anche il nostro tempo presenta alcune somiglianze con quel periodo: ci troviamo nel bel mezzo di forti tensioni internazionali e sarebbe difficile sostenere che l’atmosfera in cui viviamo possa corroborare qualsiasi forma di ottimistica fiducia nel futuro. Subito dopo, l’autore aggiunge un caveat, mettendo in evidenza che il nostro mondo presenta notevoli divergenze rispetto a quello degli autori esaminati in questo libro. La vera divergenza sta nella multipolarità dei centri di potere e di minaccia bellica: non ci troviamo più dinanzi a un confronto diretto e costante tra solo due superpotenze che si minacciano a vicenda con armi atomiche; sicché una nuova guerra mondiale tra grandi potenze appare improbabile. E tuttavia, non sarà inopportuno rivisitare oggi le riflessioni di Russell, Jaspers, Aron e Anders. Innanzitutto, perché le idee filosofiche del passato (e qui parliamo del passato prossimo) hanno sempre indicato la via per gli sviluppi futuri; e in secondo luogo perché, nonostante la differenza tra la loro epoca e la nostra, la possibilità di un olocausto nucleare non si è affatto eclissata dai nostri orizzonti (orizzonti dove potrebbero improvvisamente apparire “due soli”, come cantavano i Pink Floyd nel brano “Two Suns in the Sunset”, dall’album The Final Cut del 1983, con allusione alla luce quasi solare sprigionata da un’esplosione termonucleare).
Benché sostenga l’improbabilità di un conflitto nucleare globale, Castelli sottolinea come la disponibilità a ricorrere alle armi nucleari non sia affatto diminuita da ottant’anni a questa parte, pur nel radicale cambiamento delle relazioni geopolitiche. Le potenze che continuano a decidere dell’assetto politico e istituzionale del pianeta non hanno mai abbandonato la logica della volontà di potenza, che si concretizza in sentenze come «right or wrong, my country» o «si vis pacem para bellum». Ma come osservò giustamente Norberto Bobbio (altro filosofo che figurerebbe degnamente accanto ai quattro trattati nel libro), quella logica e quei princìpi sono considerati qualcosa di ovvio, con totale disprezzo della considerazione per cui «il potere, oltre un certo limite, si trasforma nel suo contrario», poiché annienta tutto ciò per cui era stato perseguito. Non va sottovalutato il fatto che oggi sono presenti 12.100 testate nucleari sparse in tutto il mondo, 2.100 delle quali pronte per essere utilizzate in brevissimo tempo. Pertanto, nonostante il ricordo dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, l’uso delle armi nucleari rimane un’opzione praticabile per i governi dei nove paesi del cosiddetto “club nucleare” (Cina, Francia, India, Israele, Corea del Nord, Pakistan, Russia, Regno Unito e Stati Uniti).
Dopo la fine della Guerra Fredda, sembra che il terrore verso le armi nucleari sia scomparso, ma si tratta piuttosto di un’amnesia generalizzata che di un attenuarsi della minaccia. Invece di sviluppare una “coscienza atomica”, riconoscendo, con Bobbio, che “la pace non è un processo inevitabile ma una conquista (e come tutte le conquiste, può essere persa una volta raggiunta)”, abbiamo formato una sorta di “inconscio atomico”, abbandonandoci a un preoccupante oblio collettivo di fronte alla possibilità di una catastrofe.
Per Castelli, l’oblio che circonda la questione nucleare è stato influenzato da almeno altri due fattori: il primo consiste nel fatto che, a partire dall’inizio degli anni ‘90, l’opinione pubblica occidentale si è abituata alle guerre convenzionali che si verificano vicino ai propri confini, guerre sanguinose ma limitate, le cui conseguenze sono state percepite come poco rilevanti per i cittadini dell’Unione Europea o degli Stati Uniti. Sostanzialmente, una volta scomparsa la paura della superpotenza comunista, per trent’anni gli occidentali hanno pensato che la possibilità dell’uso di armi nucleari fosse molto remota. Il secondo fattore che ha contribuito all’oblio della questione atomica è rappresentato dal fatto che, negli ultimi decenni, sono emersi altri problemi concernenti l’economia, l’ambiente, i diritti, la salute e le nuove tecnologie dell’informazione: questi problemi hanno una rilevanza globale, ma si intrecciano con altre questioni di rilevanza regionale o macro regionale, come l’immigrazione, l’inflazione, la crisi energetica e l’instabilità dei sistemi politici rappresentativi. In qualche modo, hanno quasi spostato nei recessi dell’inconscio la paura per la guerra.
Ma l’invasione dell’Ucraina da parte della superpotenza russa, riedizione 2.0 di quella sovietica (insieme alle ripetute minacce del leader del Cremlino di ricorrere alle armi nucleari), seguita dall’intervento indiretto della NATO, ha cambiato parzialmente la situazione provocando, quasi in termini freudiani, un parziale “ritorno del rimosso”. Parziale, perché è rimasto un certo scetticismo riguardo alla possibilità di un’escalation nucleare.
I quattro filosofi non affrontano la questione degli armamenti nucleari allo stesso modo, anche perché non formano né una “scuola di pensiero”, né una comunità intellettuale omogenea. La scelta degli autori del libro mira proprio a presentare le diverse prospettive possibili sullo stesso problema e i diversi modi di trattarlo, cercando altresì di mettere in luce i punti di convergenza.
Nel primo capitolo, dedicato a Bertrand Russell (“Bertrand Russell’s Commitment against Atomic Warfare”) Alberto Castelli mette in rilievo come il filosofo inglese fosse in grado di difendere la pace con buone argomentazioni, dimostrando la fallacia delle ragioni che spingono gli uomini alla guerra. Dal 1914 fino alla sua morte, nel 1970, non ha mai smesso di lottare contro la violenza, che considerava inutile e nemica della civiltà e della ragione (in cui riponeva immense speranze). Giustamente l’autore si sofferma sulle ragioni del pacifismo radicale di Russell al tempo della I guerra mondiale, posizione che gli costò anche l’allontanamento dal Trinity College di Cambridge e sei mesi di carcere nel 1918. Andrebbe altresì aggiunta la posizione soffertamente favorevole alla guerra contro Hitler, allorché, nel 1943, ebbe a dichiarare che se la guerra è sempre stata un grande male, in alcune circostanze particolarmente estreme può rivelarsi il male minore. Russell scrisse saggi brevi e incisivi, capaci di convincere sia l’uomo comune, sia gli intellettuali e i leaders politici. La sua posizione di fronte alla possibilità di un olocausto nucleare non era né quella di un politico (che calcola le reali possibilità di azione) né quella di un politologo realista (che mira a descrivere la situazione in modo obiettivo); era piuttosto quella di un filosofo engagé, che utilizza le migliori idee disponibili per spiegare come perseguire il bene (o evitare il male). In breve, l’obiettivo di Russell era quello di opporsi alla follia del suo tempo con la consapevolezza di un grande intellettuale e di sviluppare una filosofia in grado di assumersi la responsabilità di una tale sfida. Castelli segue l’itinerario di Russell con precisione e chiarezza, scandendo distintamente le sue prese di posizione. Ad esempio, osserva con molta pertinenza che negli anni Trenta Russell basava le sue riflessioni riguardo alla pace su tre convinzioni: la guerra (1) era insensata, non solo perché terreno fertile per la barbarie, ma anche a causa della distruttività della tecnologia militare a disposizione degli eserciti moderni; (2) la sua causa più profonda era l’autonomia degli Stati in politica estera; e (3) poteva essere abolita, o quanto meno limitata, attraverso istituzioni sovranazionali capaci di limitare tale autonomia. Queste convinzioni dovettero apparire a Russell confermate dagli eventi successivi: la diffusione del nazionalismo e la Seconda Guerra Mondiale, l’immenso caos causato dai bombardamenti, le atrocità, le distruzioni e, soprattutto, l’esplosione delle due bombe atomiche che rasero al suolo Hiroshima e Nagasaki.
Un atteggiamento molto diverso da quello di Russell è quello di Raymond Aron (“Raymond Aron. International Relations in the Atomic Age”), ben lumeggiato da Francesco Raschi.
La guerra e la politica internazionale sono temi che hanno sempre rivestito un ruolo importante nell’ampia produzione dello studioso parigino, il quale adotta una prospettiva europea e francese, anche a causa delle vicende del suo paese, dal colonialismo fino alle divisioni interne. Al centro dell’attenzione di Aron c’è il conflitto ideologico che determina spesso sistemi internazionali eterogenei, a loro volta fattori scatenanti di guerre che riflettono le tensioni politiche e sociali. Per quanto riguarda l’era nucleare, Aron, inizialmente pacifista, durante la Seconda Guerra Mondiale sviluppa un interesse per la strategia militare, confluito nella sua opera fondamentale, Paix et guerre entre les nations (Pace e guerra tra le nazioni). Aron introduce la dicotomia “pace impossibile/guerra improbabile” per descrivere la competizione tra USA e URSS negli anni della Guerra Fredda, sottolineando come la guerra sia inestricabilmente legata alla politica. Uno dei suoi punti di forza è la discussione politica e sociologica di temi come “la strategia della dissuasione”, la “rappresaglia massiccia” e la “risposta flessibile”, dove il ruolo delle armi nucleari nel limitare o esasperare i conflitti diventa una componente fondamentale.
Il suo realismo, radicato in un temperamento concreto e spassionato, lo persuade del fatto che anche nell’era nucleare i conflitti possano e debbano rimanere limitati e non condurre necessariamente alla distruzione globale temuta dai pessimisti. La prova di tale possibilità, secondo Aron, era fornita dalla guerra di Corea, che, nonostante il suo potenziale distruttivo, rimase confinata in un’area geografica limitata e comportò l’uso di armi convenzionali. Certamente Aron non fu ignaro della possibilità di una guerra atomica distruttiva a livello globale e ne era profondamente spaventato; allo stesso tempo, tuttavia, credeva che, se la politica fosse riuscita a mantenere i conflitti entro i limiti di obiettivi ragionevoli e limitati (cioè non mirati alla distruzione e alla resa incondizionata dell’avversario), sarebbe stato possibile evitare l’autodistruzione dell’umanità. Aron non risparmia severe critiche sia al comunismo sovietico sia al pacifismo ideologico, difendendo una posizione che potremmo definire di realismo secondo regole. Egli riconosce la deterrenza nucleare come fatto compiuto e al contempo come occasione per ridefinire i parametri della razionalità politica. Per Aron, la minaccia atomica non è tanto un fallimento della ragione quanto la sua prova più estrema, che deve puntare a trovare uno spazio di equilibrio tra etica della responsabilità e necessità geopolitica. La guerra atomica non è un destino, ma neppure un tabù: è uno scenario possibile, da razionalizzare e limitare attraverso accordi, trattati e soprattutto una consapevolezza nuova delle relazioni internazionali. Del resto, il meccanismo della deterrenza, per lui, non ha avuto origine nell’era atomica. Un simile meccanismo era sempre esistito e dipendeva principalmente dai mezzi materiali a disposizione di uno Stato per fermarne un altro, nonché dalla determinazione a utilizzare tali mezzi se necessario. Nell’era atomica, l’unica novità della deterrenza dipende, se non altro, dalle conseguenze materiali dell’attuazione della minaccia. La strategia della deterrenza era «essenzialmente una prova di forza di volontà, uno scambio di minacce e messaggi alternati, o meglio di minacce portatrici di messaggi e messaggi pregni di minacce». Una delle osservazioni più illuminanti di Aron riguarda la distinzione tra «guerra di autodifesa anticipatoria» (pre‑emptive war) e «guerra precauzionale» (preventive war). La guerra precauzionale o preventiva è un conflitto programmato “a freddo”, avviato in un momento ritenuto strategicamente favorevole da uno Stato, al fine di neutralizzare una potenziale minaccia futura ancora lontana o non attuale. La guerra di autodifesa anticipatoria, invece, scaturisce in un contesto di crisi imminente, quando lo Stato ritiene che un attacco sia ormai inevitabile e prossimo: non si sceglie la guerra rispetto alla pace, ma si reagisce per evitare di essere colti di sorpresa. Alla fine Raschi evidenzia come la riflessione aroniana sulla bomba atomica non si lasci travolgere dal catastrofismo né da un moralismo radicale, ma si inserisca in un più ampio quadro di pensiero liberale e realista.
La prospettiva di Jaspers (“Karl Jaspers: Between the Bomb and Totalitarianism”) viene analizzata da Giunia Gatta, che lo considera come un filosofo, erede della grande tradizione tedesca, non tanto incline ad attribuire importanza alle dinamiche politiche, quanto alle ragioni più profonde che sottendono il comportamento umano. Giunia Gatta spiega che, per Jaspers, la soluzione al problema della minaccia nucleare doveva essere una rivoluzione spirituale e culturale. Non sarebbe stato sufficiente trovare soluzioni politiche o istituzionali alla minaccia della guerra atomica; per eliminarla, sarebbe stato necessario qualcosa che fosse al di sopra della politica e che potesse cambiare radicalmente il comportamento umano. Sostanzialmente, Jaspers auspicava un’autentica rivoluzione esistenziale che avrebbe dovuto percorrere la linea sottilissima che separava la distruzione globale causata dalle bombe atomiche da un lato e la perdita della libertà (ovvero la condizione di ogni scelta) dall’altro. Al centro della trattazione vi è la convinzione jaspersiana che l’unico antidoto alla barbarie tecnologica sia una forma di comunicazione responsabile, in cui la libertà personale si apra alla trascendenza dell’altro. Gatta riesce a rendere con chiarezza il concetto jaspersiano di “colpa metafisica”, che impone a ogni individuo una responsabilità che va oltre la sfera dell’azione diretta (ossia una sorta di responsabilità senza colpa giuridica), e che si applica anche all’atteggiamento rispetto alla bomba.
In altre parole, si trattava di superare la difficile situazione emersa nel 1945 senza sprofondare nella guerra nucleare o soccombere al potere del totalitarismo sovietico (ad esempio, rinunciando all’arsenale nucleare). La prospettiva di Jaspers, nella sua ponderosa e un po’ ridondante monografia (Die Atombombe und die Zukunft des Menschen (La bomba atomica e il futuro dell’umanità), è sostanzialmente “metafisica”: la bomba non rappresenta solo un rischio tecnico-militare, ma un simbolo della crisi della ragione storica e del venir meno del dialogo autentico tra i popoli.
Il contributo di Micaela Latini su Günther Anders (“Hiroshima Is Everywhere: Günther Anders’ Reflection on the Atomic Threat”) appare storicamente molto ben documentato e filosoficamente approfondito. Molto acutamente l’autrice osserva che «nel percorso intellettuale del pensatore tedesco Günther Anders (nato Stern, 1902-1992) si trovano le tappe più significative del XX secolo, ma anche (e soprattutto) i punti cruciali della riflessione sulla necessità di prendere coscienza della possibile (o forse addirittura certa) fine di questa stessa storia»: la sua prospettiva fa di Anders un vero filosofo della storia, orientato piuttosto verso un tacito principio-disperazione che verso il principio-speranza: in qualche modo diventa una sorta di anti-Bloch.
Anders fu allievo di Husserl e uditore di Heidegger, cosa che lo rese più incline a riflettere su questioni filosofiche che sulle dinamiche di potere o sui percorsi politico-istituzionali da intraprendere. Tuttavia, nonostante una certa affinità con Jaspers per quanto riguarda l’ampio respiro filosofico, nel libro La minaccia atomica (Die atomare Drohung), pubblicato nel 1983, egli respinge fermamente l’idea di Jaspers secondo cui l’arsenale nucleare potrebbe rappresentare uno strumento utile per salvaguardare la libertà contro il totalitarismo. Secondo Anders, la disponibilità all’uso di armi atomiche sarebbe, di per sé, già una concessione al totalitarismo. Ma anche a prescindere dal disaccordo con Jaspers, la linea di pensiero avviata da Anders, evidenziata da Micaela Latini, riguarda il divario (definito “dislivello prometeico”, in tedesco Prometheisches Gefälle, in inglese Promethean Discrepancy) tra le enormi capacità tecniche degli esseri umani e la loro incapacità di immaginare (vorstellen) e controllare gli effetti dei prodotti che creano (herstellen): è la crescente “asincronia” tra l’essere umano e il mondo dei suoi prodotti, una distanza che aumenta ogni giorno che passa. Per usare le parole di Anders: «Chiamo prometeica quella differenza secondo il caso fondamentale del gradiente, cioè secondo il gradiente che esiste tra la nostra “realizzazione prometeica”, i prodotti che fabbrichiamo come “figli di Prometeo”, e tutte le altre realizzazioni: il fatto che non siamo uguali al “Prometeo dentro di noi”».
In questa situazione, gli esseri umani diventano marginali: incapaci di operare al livello dei prodotti tecnologici, l’individuo diventa un mero ingranaggio al servizio di una macchina più grande di lui. Oltre a presentare queste idee, la Latini esamina le riflessioni successive di Anders, quando, dopo il disastro di Chernobyl, giunge a teorizzare una forma di contro-violenza come atto di ribellione contro coloro che promuovono e sostengono la costruzione di prodotti che distruggono l’umanità. Latini affronta il pensiero di un autore radicale e volutamente “inattuale”, decostruendo con rielaborazione concettuale e precisione filosofica l’universo concettuale andersiano. Al centro della trattazione è il tema dell’inadeguatezza antropologica: la disparità tra le capacità produttive dell’uomo e la sua immaginazione etico-affettiva. Per il lettore meno a suo agio con la filosofia di Anders, Latini ricostruisce con accuratezza i suoi concetti chiave: dalla “vergogna prometeica” (sentimento che l’uomo prova di fronte all’irraggiungibile perfezione e potenza delle cose che lo circondano) all’“analfabetismo emotivo” (l’incapacità dell’uomo di misurare la portata delle proprie azioni e la perdita di controllo sui propri prodotti una volta che vengono “gettati nel mondo”); dall’obsolescenza dell’essere umano (per cui l’essere umano soffre di un senso di inferiorità nei confronti delle macchine da lui stesso costruite, perché, nei suoi tentativi di adattarsi ai suoi dispositivi e di farsi parte di questa o quella macchina, deve riconoscere di costituire una materia prima di scarsa qualità) al tempo della fine (quello di un’esistenza intrinsecamente minacciata dal rischio di un’apocalisse nucleare, come ci viene ricordato di tanto in tanto in modi allarmanti o “tra le righe”). L’autrice non si limita a presentare Anders come pensatore della catastrofe, ma ne valorizza anche l’urgenza morale e l’intensità profetica, in una chiave che richiama Benjamin ma anche Jaspers. Notevoli sono le pagine in cui si sofferma sul carteggio che Anders intrattenne alla fine degli anni ‘50 con Claude Eatherly, il giovane meteorologo texano dell’aereo da ricognizione americano che, il 6 agosto 1945, dopo aver constatato sufficienti condizioni di visibilità, diede il via libera al bombardamento atomico di Hiroshima. Scambio epistolare, pubblicato nel 1961, che legge in continuità con le riflessioni contenute in L’uomo sul ponte. Diario da Hiroshima e Nagasaki, scritto due anni prima (Milano Udine, Mimesis. 2024).
Di particolare rilievo è anche l’analisi dell’opera L’uomo è antiquato (Die Antiquiertheit des Menschen), che non indulge a semplificazioni in chiave apocalittica o a interpretazioni secondo la vulgata del pessimismo radicale (quasi un Leopardi o uno Schopenhauer del XX secolo, senza contare che neanche gli altri due sono mai stati pessimisti come vorrebbe una certa banalizzazione manualistica), restituendo un Anders rigoroso e attuale, lucido nella sua denuncia ma anche aperto a una possibile reazione etico-politica.
Il volume si impone come un contributo rilevante e originale alla riflessione sul rapporto tra filosofia e catastrofe tecnologica. Lungi dall’essere una semplice collezione di saggi, esso costituisce un esperimento riuscito di confronto comparato tra quattro figure emblematiche della filosofia del Novecento, ciascuna impegnata a suo modo a pensare l’impensabile: la distruzione totale, la disumanizzazione tecnologica, l’annientamento.
Russell, Aron, Jaspers e Anders non condividono un’unica visione né uno stile comune, ma vengono accomunati da un’urgenza etica e da una comune responsabilità intellettuale. La filosofia non è qui una disciplina accademica, ma una presa di posizione, una forma di resistenza alla banalizzazione tecnica del male.
In un’epoca segnata da nuove minacce o rischi globali (cambiamento climatico, intelligenza artificiale, guerra ibrida), tornare a riflettere sull’“età atomica” attraverso la lente di questi quattro pensatori significa riscoprire il ruolo della filosofia come pensiero del limite, della possibilità e della sopravvivenza. Il volume si presta a usi molteplici: manuale universitario, saggio da discussione e punto di partenza per ulteriori approfondimenti su un tema che resta drammaticamente attuale.
Il libro è consigliabile anche per i non addetti ai lavori, perché spinge a riflettere su questioni filosofiche di interesse generale per chi voglia vivere da cittadino consapevole, come il potere distruttivo della tecnologia e l’importanza della responsabilità etica. In ultima analisi, è un tentativo di risposta a un dilemma ancora irrisolto: come conciliare il progresso tecnologico con la sopravvivenza dell’umanità?
I dati sugli arsenali nucleari mondiali, forniti dalla Federation of American Scientists (FAS) parlano chiaro: nel 2025, nove paesi detengono ufficialmente armi nucleari. Stati Uniti e Russia rimangono le due superpotenze atomiche, controllando circa il 90% dell’arsenale globale (3.700–4.300 testate ciascuno). La Cina, sempre più determinata a espandere il proprio arsenale, ha circa 600 testate e un programma di modernizzazione che preoccupa sia Washington che Mosca. Francia e Regno Unito, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, mantengono arsenali più contenuti rispettivamente 290 e 225 testate. India e Pakistan, storici rivali, dispongono ciascuno di circa 180–170 testate, con strategie nucleari incentrate sulla deterrenza reciproca. Israele, pur non avendo mai confermato ufficialmente il proprio arsenale, è considerato uno stato nucleare latente, con circa 90 testate. Infine, la Corea del Nord, che , ha abbandonato il Trattato di Non Proliferazione (NPT) nel 2003, possiede un arsenale stimato tra le 40 e le 60 testate, continuando a sviluppare missili balistici intercontinentali.
Oltre al club ufficiale delle potenze nucleari, esistono Stati che si trovano sulla “soglia nucleare”: Paesi dotati della tecnologia e delle risorse necessarie per costruire un’arma atomica in tempi relativamente brevi. Come scrive l’analista Agnese Rossi nel suo approfondimento “Proliferazione senza deterrenza o della bomba di Schrodinger” pubblicato su Limes, il caso più citato è quello dell’Iran, che, dopo l’abbandono dell’accordo sul nucleare (JCPOA), ha accumulato uranio arricchito oltre il 60%, avvicinandosi così alla soglia tecnica per lo sviluppo di un’arma nucleare, sebbene non ci siano prove definitive di una decisione in tal senso. Paesi come Giappone, Germania, Corea del Sud e il Brasile rientrano tra gli Stati a latenza nucleare: civili, industrializzati e dotati di infrastrutture e competenze sufficienti a sviluppare un’arma nucleare entro pochi anni, qualora decidessero di farlo.
La logica della “mutua distruzione assicurata” (MAD) che ha dominato durante la Guerra Fredda ha effettivamente contribuito a evitare l’uso diretto delle armi nucleari, mantenendo una pace armata fondata sul terrore reciproco. Ma oggi, quello stesso equilibrio si sta incrinando. Gli arsenali sono in espansione, i rischi di conflitto, volontario o accidentale, aumentano, e l’infrastruttura diplomatica che regolava la deterrenza nucleare si sta sgretolando. Il Trattato di Non Proliferazione (NPT) è sempre più sotto pressione, e diversi accordi bilaterali tra Stati Uniti e Russia sono stati sospesi o abbandonati, lasciando un vuoto normativo sempre più difficile da colmare.
Un’alternativa al paradigma della deterrenza è stata proposta dal Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW), adottato nel 2017 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e in vigore dal 2021. Firmato da oltre 90 Paesi (ma non dalle potenze nucleari), il trattato mira a vietare in modo assoluto lo sviluppo, il possesso e l’uso di armi atomiche, sancendo per la prima volta un chiaro divieto giuridico internazionale.
Hiroshima e Nagasaki restano simboli vividi del potenziale distruttivo dell’umanità. Nonostante i progressi e le speranze riposte nel disarmo, la minaccia atomica non è mai scomparsa: è rimasta silente, ma presente. Oggi, la domanda resta aperta: il mondo si sta davvero avvicinando a un disarmo effettivo, oppure sta lentamente scivolando verso una nuova era di possibile impiego delle armi nucleari? Finché la pace si regge sull’equilibrio del terrore, la minaccia atomica continuerà a proiettare la sua ombra sul futuro.
Ci sono poi gli Stati che al contrario hanno deciso di ‘chiudere’ con il nucleare ed eliminare le proprie dotazioni. Il Sudafrica allestì il suo forziere nucleare tra la metà degli anni ’70 e la fine degli ’80 del secolo scorso, ma se ne liberò nel 1991. Poi i Paesi ex Urss come Bielorussia, Kazakistan e Ucraina: una volta divenuti Stati indipendenti smantellarono gli armamenti o li restituirono all’ex casa madre Russia.
L’Italia non possiede ‘sua’ bomba nucleare ma è un paese disponibile ad ospitarla per conto della Nato. Accetta la condivisione nucleare “in caso di conflitto”. Dal 2018 i Paesi Nato che aderiscono a questo programma sono il Belgio (con 10 testate dislocate nella base di Klein Brogel), la Germania (10-20 testate nella base di Büchel), l’Italia (ci sarebbero 50 testate ad Aviano e 20-40 in quella di Ghedi), i Paesi Bassi (10-20 testate nella base di Volkel) e la Turchia (50-90 testate nella base di Adana).
I numeri delle testate nucleari non possono infatti mai essere precisi, perché restano segreto di Stato. Per la maggior parte degli Stati con armi nucleari esistono solo stime basate su analisi di esperti, dichiarazioni pubbliche e fughe di notizie. Fanno eccezione gli Stati Uniti e la Russia che, sulla base della serie di trattati START, devono sottoporre i propri arsenali nucleari a periodiche ispezioni pubbliche. Secondo l’ultimo rapporto dedicato allo stato della sicurezza globale del Sipri, l’istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma, pubblicato lo scorso 16 giugno, “sta emergendo una nuova e pericolosa corsa agli armamenti nucleari in un momento in cui i regimi di controllo degli armamenti sono gravemente indeboliti“.
Il mondo e l’umanità stanno correndo rischi altissimi senza una chiara azione diplomatica volta a trovare un accordo per nuovo ordine mondiale. Ma, nessuno è disposto a cedere potere, anzi ognuno cerca di arrivare ad un accordo in posizione egemone. Invece bisognerebbe preoccuparsi di dare all’umanità una società in cui tutti possano vivere dignitosamente costruendo un clima di certezze fatto di giustizia e libertà, per il quale è indispensabile un forte impegno corale.
Allora, un “ragazzino” e un “grassone” rivelarono al mondo l’inizio dell’era atomica. La prima bomba era stata chiamata in codice Little Boy, la seconda Fat Man. Vennero sganciate il 6 agosto 1945 su Hiroshima e il 9 agosto su Nagasaki. Non ne occorse una terza, perché il Giappone che aveva rifiutato di capitolare sulle condizioni dell’ultimatum consegnato durante la Conferenza di Potsdam stavolta chinò il capo e si arrese. Quel duplice attacco doveva dimostrare la potenza distruttrice degli Stati Uniti e impedire lo stillicidio di soldati nei continui sbarchi con la tattica del “salto della rana” di isola in isola che aveva dimostrato solo l’irriducibilità nipponica a chiudere quella guerra.
Le vittime di Hiroshima e Nagasaki, incenerite dall’esplosione di un’arma apocalittica o uccise a distanza dalla radioattività, oscillano tra le centomila e le duecentomila, civili in schiacciante maggioranza. I problemi morali innescati da quella decisione e da quel gesto, che furono allo stesso tempo militari e politici, allora come oggi continuano a stendere la loro ombra sulla discussione su quanto la storia ha registrato. Si è trattato dell’unico utilizzo di ordigni nucleari in guerra. Allora li avevano solo gli Stati Uniti, oggi le nazioni con arsenale atomico sono nove, oltre agli Usa, la Russia già erede dell’Urss, Regno Unito, Francia, Cina, Pakistan, India, Corea del Nord e Israele, e altri hanno tentato di crearlo, come l’Iran.
Era la mattina del 6 agosto 1945 quando un B-29 Superfortezza volante, con un nome dipinto sulla fusoliera solo il giorno prima, si affacciò sulla città di Hiroshima. Il nome, entrato nella storia, era Enola Gay, la madre del colonnello Paul Warfield Tibbets Jr., 30 anni, pilota del quadrimotore in cui si trovavano il capitano copilota Robert A. Lewis, che aveva ceduto la cloche al superiore non senza celare il proprio malumore, l’addetto all’armamento della bomba e comandante della missione capitano William Parsons, il suo assistente sottotenente Morris Jeppson, il navigatore capitano Theodore Van Kirk, il bombardiere maggiore Thomas Ferebee, gli operatori radar e radio sergente Joe S. Stiborik e l’aviere scelto Richard Nelson, l’addetto alle contromisure radar tenente Jacob Beser, gli ingegneri di volo sergenti Wyatt Duzenbury e Robert Shumard, il mitragliere di coda sergente George Caron. La ricognizione aveva assicurato che le nubi dei giorni precedenti non coprivano più l’area urbana. Tutto era stato studiato a tavolino, tutti i calcoli fatti, rifatti e riverificati.
Alle 8.15 la pancia del B-29 si aprì lasciando precipitare verso terra un’unica bomba, con 60 chili di uranio 235. Anche Hiroshima era stata raggiunta dall’allarme aereo diramata dai radar giapponesi che avevano intercettato prima una grossa formazione di bombardieri americani ad alta quota, poi solo tre: Enola Gay, The Great Artiste e un terzo che solo dopo verrà macabramente chiamato Necessary Evil, col solo compito di scattare fotografie su quanto sarebbe accaduto. Questo particolare aveva frenato sull’invio massiccio di caccia intercettori, per risparmiare la preziosissima benzina di cui il Giappone scarseggiava.
Little Boy, come programmato, esplose a circa 600 metri dal suolo, con effetti tecnicamente equivalenti allo scoppio di 16.000 tonnellate di tritolo. In un attimo, in una luce accecante, vennero cancellate almeno settantamila vite e la quasi totalità di Hiroshima. Seguì un uragano atomico. Di alcuni civili restò solo la sagoma nera come fosse stata dipinta su un muro. Fu un’apocalisse, e non era un’iperbole. I risparmiati dalla morte immediata, vivranno in un inferno per il resto della loro vita segnata dalla contaminazione e dalle sofferenze per le quali non esisteva cura.
Il 6 agosto 1945 la Germania nazista era già capitolata da tre mesi e la bandiera dell'Urss sventolava sui territori dell'Europa orientale al posto di quella del Terzo Reich. Il Giappone imperiale, nonostante le enormi perdite e i bombardamenti incendiari che avevano ridotto in cenere Tokyo e altre grandi città, aveva però continuato a combattere. Fu sia per avere ragione di un nemico irriducibile che per mandare un eloquente messaggio a Mosca, alleato già trasformatosi in avversario, che quel giorno il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, ordinò il lancio di una bomba nucleare sulla città di Hiroshima, seguita tre giorni dopo dall'ordigno che colpì Nagasaki, secondo e ultimo impiego dell'arma atomica in un conflitto.
Era stato stabilito che il 9 agosto il secondo ordigno, Fat Man, sarebbe stato sganciato sulla città di Kokura. Ma uno strato di nubi fece cambiare la rotta del B-29 dopo tre inutili giri per effettuare il puntamento e il corso della storia. Il carburante ancora nei serbatoi del quadrimotore che scintillava alla luce del sole consentiva di raggiungere l’obiettivo secondario, che era Nagasaki. Le sirene dell’allarme aereo erano risuonate quel mattino per 40 minuti, e alle 08.30 smisero. Quando poco prima delle 11 si materializzarono due sagome all’orizzonte gli osservatori radar giapponesi pensarono fossero semplici ricognitori. E poi c’erano nuvole anche su Nagasaki, difficile ipotizzare il bombardamento. Ma Fat Man non poteva essere riportato alla base, ed era escluso che nel caso di mancanza di benzina si potesse tentare una manovra di ammaraggio.
Il comandante Charles W. Sweeney, che ai suoi ordini aveva l’equipaggio del B-29 The Great Artiste, non ancora pronto nelle modifiche per quella missione e utilizzato come ricognitore da affiancamento, contravvenendo alle disposizioni ricevute accese allora la strumentazione radar e da essa pervenne l’indicazione dell’obiettivo. E così il B-29 chiamato Bockscar sganciò la bomba al plutonio (poco meno di sei chili e mezzo) che esplose a un’altezza di meno di mezzo chilometro dalla zona dove sorgevano le industrie belliche, a pochissimi chilometri (4,5 o 6) da Nagasaki, parzialmente protetta da alcune colline. Non abbastanza protetta da poter impedire circa ottantamila vittime tra morti all’istante e feriti contaminati. Il Bockscar dopo la missione riuscirà fortunosamente ad atterrare a Okinawa con i serbatoi praticamente a secco.
Viene ritenuto che il duplice bombardamento atomico abbreviò la guerra e risparmiò agli americani la perdita di decine di migliaia di soldati. Altri ritengono che il Giappone, ormai stremato, stesse per chiedere all’Unione Sovietica di intercedere con gli Alleati per giungere a un armistizio. Ma due giorni dopo l’olocausto nucleare di Hiroshima Stalin aveva dichiarato guerra al Giappone per prendersi una parte di bottino sul fronte del Pacifico e quindi nessuna altra strada era praticabile se non la resa incondizionata. Che il Giappone dichiarò unilateralmente il 15 agosto con un discorso alla radio dell’imperatore Hirohito. Era la prima volta che i giapponesi udivano la voce di colui che ritenevano un dio in terra, e quella voce valeva molto più di quella dei militari che avevano voluto una guerra chiusa nel disastro dei due funghi atomici.
Nel dopoguerra furono in molti a sostenere che l'ecatombe radioattiva abbia evitato la carneficina ancora più immane che sarebbe stata comportata da uno sbarco alleato in Giappone. Sono calcoli che significano ben poco per i sopravvissuti, molti dei quali hanno dovuto affrontare conseguenze fisiche e psicologiche pesantissime, oltre allo stigma di essere 'hibakusha', esposti a radiazioni e dunque oggetto di pregiudizi. Proprio gli 'hibakusha' sono però diventati la voce più importante che possa levarsi contro l'utilizzo di armi atomiche, e quelli ancora in vita sono stati incontrati da numerosi leader mondiali e hanno fatto così valere al massimo la loro forza simbolica. Nel 2019 papa Francesco incontrò numerosi sopravvissuti durante la visita apostolica a Hiroshima e Nagasaki, quando ricordò l'inspiegabile orrore subito dalle vittime degli attacchi. Tre anni prima Barack Obama era stato il primo presidente degli Stati Uniti in carica a visitare Hiroshima: non chiese scusa ma abbracciò i superstiti e lanciò un appello per un mondo senza bombe nucleari. Nel 2023 una delegazione di hibakusha incontrò poi i leader del G7, riuniti, sotto la presidenza giapponese, proprio nella città martire.
Adesso, dopo ottant’anni lo spettro di una guerra nucleare è tornato più immanente di quanto non fosse stato nell’ultimo decennio della Guerra Fredda. In Giappone, unico Paese al mondo ad aver subito un attacco atomico, quest'anno le commemorazioni della tragedia hanno un sapore più amaro, più potente, in un mondo che vede alcuni leader agitare con fin troppa leggerezza lo spettro dell'arma finale e sempre più nazioni interessate a dotarsene, ritenendola l'unica efficace forma di deterrenza in un mondo senza più equilibri certi.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per l’ottantesimo ricorrenza del bombardamento di Hiroshima, ha scritto: “Quei tragici avvenimenti, le molteplici sofferenze patite negli anni successivi dai sopravvissuti, rimangono per l’umanità monito che non può essere dimenticato. L’annientamento dell’umanità: la prospettiva che l’uso del nucleare ha posto dinanzi a tutti noi. Oggi, in uno scenario segnato da guerre, crescenti tensioni e contrapposizioni, occorre ribadire con forza che l’uso o anche la sola concreta minaccia di introdurre nei conflitti armamenti nucleari appare crimine contro l’umanità. La architettura globale del disarmo e della non proliferazione delle armi nucleari, tra i cardini del sistema multilaterale faticosamente costruito nel secondo dopoguerra, non può essere abbandonata, a rischio di accelerare un clima di scontro. A cinquanta anni dalla ratifica del Trattato di Non Proliferazione, la Repubblica Italiana ribadisce l’obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari, con la valorizzazione completa degli organismi internazionali di controllo predisposti a questo scopo. Nessuna guerra nucleare può essere combattuta o vinta, a meno di mettere a rischio la stessa esistenza della vita sul pianeta. I bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki non sono solo episodi bellici tra i più dolorosi del secolo scorso, né rappresentano soltanto una ferita ancora aperta per il popolo giapponese. Le due città sono moniti eterni di una memoria universale che testimonia dove può portare la furia distruttrice dell’uomo e, al contempo, esempio di resilienza, di ciò che è possibile costruire con la pace”.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita istituzionale in Giappone, ha incontrato l'associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari, la Nihon Hidankyo, insignita l'anno scorso del Premio Nobel per la Pace. Parlando agli Hibakusha, i sopravvissuti, ha espresso gratitudine per il loro impegno nel mantenere viva la memoria e per il loro costante appello affinché nessun altro popolo debba mai affrontare una tragedia simile. Il Presidente ha detto: “Il vostro insegnamento è un messaggio di speranza”, ed ha ribadito l'urgenza di un'umanità che impari dai propri errori.
Mattarella ha anche denunciato la pericolosa retorica bellicista che ha recentemente preso piede, sottolineando come, nonostante l'orrore di Hiroshima e Nagasaki, la proliferazione delle armi nucleari e le minacce di conflitti atomici siano ancora una realtà inquietante. Il presidente ha condannato la rinnovata narrativa nucleare promossa dalla Federazione Russa spiegando come Mosca abbia instillato l'inaccettabile idea che gli ordigni nucleari possano essere strumenti ordinari nei conflitti, dimenticando come invece portino inevitabilmente alla distruzione totale.
Il presidente ha ribadito con fermezza la posizione dell'Italia, che condanna qualsiasi uso della guerra nucleare e rinnova il suo impegno per il disarmo. Ha ricordato l'importanza di continuare a lavorare per la piena realizzazione “dell'Articolo VI del Trattato di Non Proliferazione Nucleare”, impegnandosi a sostenere un multilateralismo efficace come miglior garanzia di pace. Mattarella ha concluso: “Una guerra nucleare non può essere vinta da nessuno e non deve mai essere combattuta”, sottolineando l'importanza di un'azione condivisa e di un dialogo strategico tra tutte le potenze nucleari.
Invece, durante i periodi di pace, gli arsenali nucleari sono stati continuamente riempiti e le potenze dotate di armi nucleari sono aumentate. Una follia, quando la saggezza avrebbe voluto riempire i granai per sfamare gli affamati del mondo che muoiono a milioni ogni anno soltanto per malnutrizione e per mancanza di farmaci. Una strage silenziosa portata avanti in tempo di pace senza sparare un colpo. Ditemi voi se anche questo non è un crimine condannabile alla pari delle guerre che hanno l’aggravante della distruzione oltre alle vittime causate dalle azioni militari.
Chi meglio di Italo Svevo ha evocato la catastrofe di allora e la possibile catastrofe di oggi. Nell’ultima pagina della “Coscienza di Zeno” ha scritto: “Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un pò più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie”.
Il volume Four Philosophers and the Bomb (London, Routledge, 2025), dovuto a quattro studiosi italiani di diversa formazione (Alberto Castelli, Giunia Gatta, Micaela Latini e Francesco Raschi), attesta l’elevato livello a cui è pervenuta la nostra storiografia filosofica anche quando si misura con autori e problemi contemporanei, sui quali non sempre esistono contributi specifici. Gli autori affrontano con rigore e densità critica la riflessione filosofica sull’arma atomica attraverso quattro figure centrali del pensiero novecentesco, di diverso orientamento: Bertrand Russell, uno dei padri fondatori della filosofia analitica, Raymond Aron, grande sociologo e politologo francese, Karl Jaspers, uno degli esponenti più autorevoli della filosofia dell’esistenza, e Günther Anders, filosofo e scrittore tedesco di origine ebraica. Il libro si colloca al crocevia tra storia delle idee, riflessione morale, politologia e filosofia della tecnica, offrendo un quadro comparativo che valorizza tanto le divergenze quanto le convergenze.
Nell’introduzione, Alberto Castelli contestualizza storicamente i contributi e poi li mette in rapporto con lo status quaestionis degli studi attuali. L’autore evidenzia come la maggior parte delle tesi discusse nel libro siano state formulate tra la seconda metà degli anni ‘40 e i primi anni ‘60. Si tratta di un periodo caratterizzato da tensioni dovute al progressivo intensificarsi della corsa agli armamenti, con focolai critici rappresentati dalla guerra di Corea, dall’invasione sovietica dell’Ungheria e dalla crisi di Suez. Il mondo conobbe la paura di essere sull’orlo di una terza guerra mondiale, rispetto alla quale le prime due sarebbero sembrate insignificanti. In breve, Russell, Jaspers, Aron e Anders si sono trovati a riflettere in un’atmosfera cupa e spaventosa, segnata dal timore che la corsa verso l’autodistruzione potesse essere inarrestabile. Con una certa disinvoltura, non priva di ragioni, Castelli sottolinea che anche il nostro tempo presenta alcune somiglianze con quel periodo: ci troviamo nel bel mezzo di forti tensioni internazionali e sarebbe difficile sostenere che l’atmosfera in cui viviamo possa corroborare qualsiasi forma di ottimistica fiducia nel futuro. Subito dopo, l’autore aggiunge un caveat, mettendo in evidenza che il nostro mondo presenta notevoli divergenze rispetto a quello degli autori esaminati in questo libro. La vera divergenza sta nella multipolarità dei centri di potere e di minaccia bellica: non ci troviamo più dinanzi a un confronto diretto e costante tra solo due superpotenze che si minacciano a vicenda con armi atomiche; sicché una nuova guerra mondiale tra grandi potenze appare improbabile. E tuttavia, non sarà inopportuno rivisitare oggi le riflessioni di Russell, Jaspers, Aron e Anders. Innanzitutto, perché le idee filosofiche del passato (e qui parliamo del passato prossimo) hanno sempre indicato la via per gli sviluppi futuri; e in secondo luogo perché, nonostante la differenza tra la loro epoca e la nostra, la possibilità di un olocausto nucleare non si è affatto eclissata dai nostri orizzonti (orizzonti dove potrebbero improvvisamente apparire “due soli”, come cantavano i Pink Floyd nel brano “Two Suns in the Sunset”, dall’album The Final Cut del 1983, con allusione alla luce quasi solare sprigionata da un’esplosione termonucleare).
Benché sostenga l’improbabilità di un conflitto nucleare globale, Castelli sottolinea come la disponibilità a ricorrere alle armi nucleari non sia affatto diminuita da ottant’anni a questa parte, pur nel radicale cambiamento delle relazioni geopolitiche. Le potenze che continuano a decidere dell’assetto politico e istituzionale del pianeta non hanno mai abbandonato la logica della volontà di potenza, che si concretizza in sentenze come «right or wrong, my country» o «si vis pacem para bellum». Ma come osservò giustamente Norberto Bobbio (altro filosofo che figurerebbe degnamente accanto ai quattro trattati nel libro), quella logica e quei princìpi sono considerati qualcosa di ovvio, con totale disprezzo della considerazione per cui «il potere, oltre un certo limite, si trasforma nel suo contrario», poiché annienta tutto ciò per cui era stato perseguito. Non va sottovalutato il fatto che oggi sono presenti 12.100 testate nucleari sparse in tutto il mondo, 2.100 delle quali pronte per essere utilizzate in brevissimo tempo. Pertanto, nonostante il ricordo dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, l’uso delle armi nucleari rimane un’opzione praticabile per i governi dei nove paesi del cosiddetto “club nucleare” (Cina, Francia, India, Israele, Corea del Nord, Pakistan, Russia, Regno Unito e Stati Uniti).
Dopo la fine della Guerra Fredda, sembra che il terrore verso le armi nucleari sia scomparso, ma si tratta piuttosto di un’amnesia generalizzata che di un attenuarsi della minaccia. Invece di sviluppare una “coscienza atomica”, riconoscendo, con Bobbio, che “la pace non è un processo inevitabile ma una conquista (e come tutte le conquiste, può essere persa una volta raggiunta)”, abbiamo formato una sorta di “inconscio atomico”, abbandonandoci a un preoccupante oblio collettivo di fronte alla possibilità di una catastrofe.
Per Castelli, l’oblio che circonda la questione nucleare è stato influenzato da almeno altri due fattori: il primo consiste nel fatto che, a partire dall’inizio degli anni ‘90, l’opinione pubblica occidentale si è abituata alle guerre convenzionali che si verificano vicino ai propri confini, guerre sanguinose ma limitate, le cui conseguenze sono state percepite come poco rilevanti per i cittadini dell’Unione Europea o degli Stati Uniti. Sostanzialmente, una volta scomparsa la paura della superpotenza comunista, per trent’anni gli occidentali hanno pensato che la possibilità dell’uso di armi nucleari fosse molto remota. Il secondo fattore che ha contribuito all’oblio della questione atomica è rappresentato dal fatto che, negli ultimi decenni, sono emersi altri problemi concernenti l’economia, l’ambiente, i diritti, la salute e le nuove tecnologie dell’informazione: questi problemi hanno una rilevanza globale, ma si intrecciano con altre questioni di rilevanza regionale o macro regionale, come l’immigrazione, l’inflazione, la crisi energetica e l’instabilità dei sistemi politici rappresentativi. In qualche modo, hanno quasi spostato nei recessi dell’inconscio la paura per la guerra.
Ma l’invasione dell’Ucraina da parte della superpotenza russa, riedizione 2.0 di quella sovietica (insieme alle ripetute minacce del leader del Cremlino di ricorrere alle armi nucleari), seguita dall’intervento indiretto della NATO, ha cambiato parzialmente la situazione provocando, quasi in termini freudiani, un parziale “ritorno del rimosso”. Parziale, perché è rimasto un certo scetticismo riguardo alla possibilità di un’escalation nucleare.
I quattro filosofi non affrontano la questione degli armamenti nucleari allo stesso modo, anche perché non formano né una “scuola di pensiero”, né una comunità intellettuale omogenea. La scelta degli autori del libro mira proprio a presentare le diverse prospettive possibili sullo stesso problema e i diversi modi di trattarlo, cercando altresì di mettere in luce i punti di convergenza.
Nel primo capitolo, dedicato a Bertrand Russell (“Bertrand Russell’s Commitment against Atomic Warfare”) Alberto Castelli mette in rilievo come il filosofo inglese fosse in grado di difendere la pace con buone argomentazioni, dimostrando la fallacia delle ragioni che spingono gli uomini alla guerra. Dal 1914 fino alla sua morte, nel 1970, non ha mai smesso di lottare contro la violenza, che considerava inutile e nemica della civiltà e della ragione (in cui riponeva immense speranze). Giustamente l’autore si sofferma sulle ragioni del pacifismo radicale di Russell al tempo della I guerra mondiale, posizione che gli costò anche l’allontanamento dal Trinity College di Cambridge e sei mesi di carcere nel 1918. Andrebbe altresì aggiunta la posizione soffertamente favorevole alla guerra contro Hitler, allorché, nel 1943, ebbe a dichiarare che se la guerra è sempre stata un grande male, in alcune circostanze particolarmente estreme può rivelarsi il male minore. Russell scrisse saggi brevi e incisivi, capaci di convincere sia l’uomo comune, sia gli intellettuali e i leaders politici. La sua posizione di fronte alla possibilità di un olocausto nucleare non era né quella di un politico (che calcola le reali possibilità di azione) né quella di un politologo realista (che mira a descrivere la situazione in modo obiettivo); era piuttosto quella di un filosofo engagé, che utilizza le migliori idee disponibili per spiegare come perseguire il bene (o evitare il male). In breve, l’obiettivo di Russell era quello di opporsi alla follia del suo tempo con la consapevolezza di un grande intellettuale e di sviluppare una filosofia in grado di assumersi la responsabilità di una tale sfida. Castelli segue l’itinerario di Russell con precisione e chiarezza, scandendo distintamente le sue prese di posizione. Ad esempio, osserva con molta pertinenza che negli anni Trenta Russell basava le sue riflessioni riguardo alla pace su tre convinzioni: la guerra (1) era insensata, non solo perché terreno fertile per la barbarie, ma anche a causa della distruttività della tecnologia militare a disposizione degli eserciti moderni; (2) la sua causa più profonda era l’autonomia degli Stati in politica estera; e (3) poteva essere abolita, o quanto meno limitata, attraverso istituzioni sovranazionali capaci di limitare tale autonomia. Queste convinzioni dovettero apparire a Russell confermate dagli eventi successivi: la diffusione del nazionalismo e la Seconda Guerra Mondiale, l’immenso caos causato dai bombardamenti, le atrocità, le distruzioni e, soprattutto, l’esplosione delle due bombe atomiche che rasero al suolo Hiroshima e Nagasaki.
Un atteggiamento molto diverso da quello di Russell è quello di Raymond Aron (“Raymond Aron. International Relations in the Atomic Age”), ben lumeggiato da Francesco Raschi.
La guerra e la politica internazionale sono temi che hanno sempre rivestito un ruolo importante nell’ampia produzione dello studioso parigino, il quale adotta una prospettiva europea e francese, anche a causa delle vicende del suo paese, dal colonialismo fino alle divisioni interne. Al centro dell’attenzione di Aron c’è il conflitto ideologico che determina spesso sistemi internazionali eterogenei, a loro volta fattori scatenanti di guerre che riflettono le tensioni politiche e sociali. Per quanto riguarda l’era nucleare, Aron, inizialmente pacifista, durante la Seconda Guerra Mondiale sviluppa un interesse per la strategia militare, confluito nella sua opera fondamentale, Paix et guerre entre les nations (Pace e guerra tra le nazioni). Aron introduce la dicotomia “pace impossibile/guerra improbabile” per descrivere la competizione tra USA e URSS negli anni della Guerra Fredda, sottolineando come la guerra sia inestricabilmente legata alla politica. Uno dei suoi punti di forza è la discussione politica e sociologica di temi come “la strategia della dissuasione”, la “rappresaglia massiccia” e la “risposta flessibile”, dove il ruolo delle armi nucleari nel limitare o esasperare i conflitti diventa una componente fondamentale.
Il suo realismo, radicato in un temperamento concreto e spassionato, lo persuade del fatto che anche nell’era nucleare i conflitti possano e debbano rimanere limitati e non condurre necessariamente alla distruzione globale temuta dai pessimisti. La prova di tale possibilità, secondo Aron, era fornita dalla guerra di Corea, che, nonostante il suo potenziale distruttivo, rimase confinata in un’area geografica limitata e comportò l’uso di armi convenzionali. Certamente Aron non fu ignaro della possibilità di una guerra atomica distruttiva a livello globale e ne era profondamente spaventato; allo stesso tempo, tuttavia, credeva che, se la politica fosse riuscita a mantenere i conflitti entro i limiti di obiettivi ragionevoli e limitati (cioè non mirati alla distruzione e alla resa incondizionata dell’avversario), sarebbe stato possibile evitare l’autodistruzione dell’umanità. Aron non risparmia severe critiche sia al comunismo sovietico sia al pacifismo ideologico, difendendo una posizione che potremmo definire di realismo secondo regole. Egli riconosce la deterrenza nucleare come fatto compiuto e al contempo come occasione per ridefinire i parametri della razionalità politica. Per Aron, la minaccia atomica non è tanto un fallimento della ragione quanto la sua prova più estrema, che deve puntare a trovare uno spazio di equilibrio tra etica della responsabilità e necessità geopolitica. La guerra atomica non è un destino, ma neppure un tabù: è uno scenario possibile, da razionalizzare e limitare attraverso accordi, trattati e soprattutto una consapevolezza nuova delle relazioni internazionali. Del resto, il meccanismo della deterrenza, per lui, non ha avuto origine nell’era atomica. Un simile meccanismo era sempre esistito e dipendeva principalmente dai mezzi materiali a disposizione di uno Stato per fermarne un altro, nonché dalla determinazione a utilizzare tali mezzi se necessario. Nell’era atomica, l’unica novità della deterrenza dipende, se non altro, dalle conseguenze materiali dell’attuazione della minaccia. La strategia della deterrenza era «essenzialmente una prova di forza di volontà, uno scambio di minacce e messaggi alternati, o meglio di minacce portatrici di messaggi e messaggi pregni di minacce». Una delle osservazioni più illuminanti di Aron riguarda la distinzione tra «guerra di autodifesa anticipatoria» (pre‑emptive war) e «guerra precauzionale» (preventive war). La guerra precauzionale o preventiva è un conflitto programmato “a freddo”, avviato in un momento ritenuto strategicamente favorevole da uno Stato, al fine di neutralizzare una potenziale minaccia futura ancora lontana o non attuale. La guerra di autodifesa anticipatoria, invece, scaturisce in un contesto di crisi imminente, quando lo Stato ritiene che un attacco sia ormai inevitabile e prossimo: non si sceglie la guerra rispetto alla pace, ma si reagisce per evitare di essere colti di sorpresa. Alla fine Raschi evidenzia come la riflessione aroniana sulla bomba atomica non si lasci travolgere dal catastrofismo né da un moralismo radicale, ma si inserisca in un più ampio quadro di pensiero liberale e realista.
La prospettiva di Jaspers (“Karl Jaspers: Between the Bomb and Totalitarianism”) viene analizzata da Giunia Gatta, che lo considera come un filosofo, erede della grande tradizione tedesca, non tanto incline ad attribuire importanza alle dinamiche politiche, quanto alle ragioni più profonde che sottendono il comportamento umano. Giunia Gatta spiega che, per Jaspers, la soluzione al problema della minaccia nucleare doveva essere una rivoluzione spirituale e culturale. Non sarebbe stato sufficiente trovare soluzioni politiche o istituzionali alla minaccia della guerra atomica; per eliminarla, sarebbe stato necessario qualcosa che fosse al di sopra della politica e che potesse cambiare radicalmente il comportamento umano. Sostanzialmente, Jaspers auspicava un’autentica rivoluzione esistenziale che avrebbe dovuto percorrere la linea sottilissima che separava la distruzione globale causata dalle bombe atomiche da un lato e la perdita della libertà (ovvero la condizione di ogni scelta) dall’altro. Al centro della trattazione vi è la convinzione jaspersiana che l’unico antidoto alla barbarie tecnologica sia una forma di comunicazione responsabile, in cui la libertà personale si apra alla trascendenza dell’altro. Gatta riesce a rendere con chiarezza il concetto jaspersiano di “colpa metafisica”, che impone a ogni individuo una responsabilità che va oltre la sfera dell’azione diretta (ossia una sorta di responsabilità senza colpa giuridica), e che si applica anche all’atteggiamento rispetto alla bomba.
In altre parole, si trattava di superare la difficile situazione emersa nel 1945 senza sprofondare nella guerra nucleare o soccombere al potere del totalitarismo sovietico (ad esempio, rinunciando all’arsenale nucleare). La prospettiva di Jaspers, nella sua ponderosa e un po’ ridondante monografia (Die Atombombe und die Zukunft des Menschen (La bomba atomica e il futuro dell’umanità), è sostanzialmente “metafisica”: la bomba non rappresenta solo un rischio tecnico-militare, ma un simbolo della crisi della ragione storica e del venir meno del dialogo autentico tra i popoli.
Il contributo di Micaela Latini su Günther Anders (“Hiroshima Is Everywhere: Günther Anders’ Reflection on the Atomic Threat”) appare storicamente molto ben documentato e filosoficamente approfondito. Molto acutamente l’autrice osserva che «nel percorso intellettuale del pensatore tedesco Günther Anders (nato Stern, 1902-1992) si trovano le tappe più significative del XX secolo, ma anche (e soprattutto) i punti cruciali della riflessione sulla necessità di prendere coscienza della possibile (o forse addirittura certa) fine di questa stessa storia»: la sua prospettiva fa di Anders un vero filosofo della storia, orientato piuttosto verso un tacito principio-disperazione che verso il principio-speranza: in qualche modo diventa una sorta di anti-Bloch.
Anders fu allievo di Husserl e uditore di Heidegger, cosa che lo rese più incline a riflettere su questioni filosofiche che sulle dinamiche di potere o sui percorsi politico-istituzionali da intraprendere. Tuttavia, nonostante una certa affinità con Jaspers per quanto riguarda l’ampio respiro filosofico, nel libro La minaccia atomica (Die atomare Drohung), pubblicato nel 1983, egli respinge fermamente l’idea di Jaspers secondo cui l’arsenale nucleare potrebbe rappresentare uno strumento utile per salvaguardare la libertà contro il totalitarismo. Secondo Anders, la disponibilità all’uso di armi atomiche sarebbe, di per sé, già una concessione al totalitarismo. Ma anche a prescindere dal disaccordo con Jaspers, la linea di pensiero avviata da Anders, evidenziata da Micaela Latini, riguarda il divario (definito “dislivello prometeico”, in tedesco Prometheisches Gefälle, in inglese Promethean Discrepancy) tra le enormi capacità tecniche degli esseri umani e la loro incapacità di immaginare (vorstellen) e controllare gli effetti dei prodotti che creano (herstellen): è la crescente “asincronia” tra l’essere umano e il mondo dei suoi prodotti, una distanza che aumenta ogni giorno che passa. Per usare le parole di Anders: «Chiamo prometeica quella differenza secondo il caso fondamentale del gradiente, cioè secondo il gradiente che esiste tra la nostra “realizzazione prometeica”, i prodotti che fabbrichiamo come “figli di Prometeo”, e tutte le altre realizzazioni: il fatto che non siamo uguali al “Prometeo dentro di noi”».
In questa situazione, gli esseri umani diventano marginali: incapaci di operare al livello dei prodotti tecnologici, l’individuo diventa un mero ingranaggio al servizio di una macchina più grande di lui. Oltre a presentare queste idee, la Latini esamina le riflessioni successive di Anders, quando, dopo il disastro di Chernobyl, giunge a teorizzare una forma di contro-violenza come atto di ribellione contro coloro che promuovono e sostengono la costruzione di prodotti che distruggono l’umanità. Latini affronta il pensiero di un autore radicale e volutamente “inattuale”, decostruendo con rielaborazione concettuale e precisione filosofica l’universo concettuale andersiano. Al centro della trattazione è il tema dell’inadeguatezza antropologica: la disparità tra le capacità produttive dell’uomo e la sua immaginazione etico-affettiva. Per il lettore meno a suo agio con la filosofia di Anders, Latini ricostruisce con accuratezza i suoi concetti chiave: dalla “vergogna prometeica” (sentimento che l’uomo prova di fronte all’irraggiungibile perfezione e potenza delle cose che lo circondano) all’“analfabetismo emotivo” (l’incapacità dell’uomo di misurare la portata delle proprie azioni e la perdita di controllo sui propri prodotti una volta che vengono “gettati nel mondo”); dall’obsolescenza dell’essere umano (per cui l’essere umano soffre di un senso di inferiorità nei confronti delle macchine da lui stesso costruite, perché, nei suoi tentativi di adattarsi ai suoi dispositivi e di farsi parte di questa o quella macchina, deve riconoscere di costituire una materia prima di scarsa qualità) al tempo della fine (quello di un’esistenza intrinsecamente minacciata dal rischio di un’apocalisse nucleare, come ci viene ricordato di tanto in tanto in modi allarmanti o “tra le righe”). L’autrice non si limita a presentare Anders come pensatore della catastrofe, ma ne valorizza anche l’urgenza morale e l’intensità profetica, in una chiave che richiama Benjamin ma anche Jaspers. Notevoli sono le pagine in cui si sofferma sul carteggio che Anders intrattenne alla fine degli anni ‘50 con Claude Eatherly, il giovane meteorologo texano dell’aereo da ricognizione americano che, il 6 agosto 1945, dopo aver constatato sufficienti condizioni di visibilità, diede il via libera al bombardamento atomico di Hiroshima. Scambio epistolare, pubblicato nel 1961, che legge in continuità con le riflessioni contenute in L’uomo sul ponte. Diario da Hiroshima e Nagasaki, scritto due anni prima (Milano Udine, Mimesis. 2024).
Di particolare rilievo è anche l’analisi dell’opera L’uomo è antiquato (Die Antiquiertheit des Menschen), che non indulge a semplificazioni in chiave apocalittica o a interpretazioni secondo la vulgata del pessimismo radicale (quasi un Leopardi o uno Schopenhauer del XX secolo, senza contare che neanche gli altri due sono mai stati pessimisti come vorrebbe una certa banalizzazione manualistica), restituendo un Anders rigoroso e attuale, lucido nella sua denuncia ma anche aperto a una possibile reazione etico-politica.
Il volume si impone come un contributo rilevante e originale alla riflessione sul rapporto tra filosofia e catastrofe tecnologica. Lungi dall’essere una semplice collezione di saggi, esso costituisce un esperimento riuscito di confronto comparato tra quattro figure emblematiche della filosofia del Novecento, ciascuna impegnata a suo modo a pensare l’impensabile: la distruzione totale, la disumanizzazione tecnologica, l’annientamento.
Russell, Aron, Jaspers e Anders non condividono un’unica visione né uno stile comune, ma vengono accomunati da un’urgenza etica e da una comune responsabilità intellettuale. La filosofia non è qui una disciplina accademica, ma una presa di posizione, una forma di resistenza alla banalizzazione tecnica del male.
In un’epoca segnata da nuove minacce o rischi globali (cambiamento climatico, intelligenza artificiale, guerra ibrida), tornare a riflettere sull’“età atomica” attraverso la lente di questi quattro pensatori significa riscoprire il ruolo della filosofia come pensiero del limite, della possibilità e della sopravvivenza. Il volume si presta a usi molteplici: manuale universitario, saggio da discussione e punto di partenza per ulteriori approfondimenti su un tema che resta drammaticamente attuale.
Il libro è consigliabile anche per i non addetti ai lavori, perché spinge a riflettere su questioni filosofiche di interesse generale per chi voglia vivere da cittadino consapevole, come il potere distruttivo della tecnologia e l’importanza della responsabilità etica. In ultima analisi, è un tentativo di risposta a un dilemma ancora irrisolto: come conciliare il progresso tecnologico con la sopravvivenza dell’umanità?
I dati sugli arsenali nucleari mondiali, forniti dalla Federation of American Scientists (FAS) parlano chiaro: nel 2025, nove paesi detengono ufficialmente armi nucleari. Stati Uniti e Russia rimangono le due superpotenze atomiche, controllando circa il 90% dell’arsenale globale (3.700–4.300 testate ciascuno). La Cina, sempre più determinata a espandere il proprio arsenale, ha circa 600 testate e un programma di modernizzazione che preoccupa sia Washington che Mosca. Francia e Regno Unito, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, mantengono arsenali più contenuti rispettivamente 290 e 225 testate. India e Pakistan, storici rivali, dispongono ciascuno di circa 180–170 testate, con strategie nucleari incentrate sulla deterrenza reciproca. Israele, pur non avendo mai confermato ufficialmente il proprio arsenale, è considerato uno stato nucleare latente, con circa 90 testate. Infine, la Corea del Nord, che , ha abbandonato il Trattato di Non Proliferazione (NPT) nel 2003, possiede un arsenale stimato tra le 40 e le 60 testate, continuando a sviluppare missili balistici intercontinentali.
Oltre al club ufficiale delle potenze nucleari, esistono Stati che si trovano sulla “soglia nucleare”: Paesi dotati della tecnologia e delle risorse necessarie per costruire un’arma atomica in tempi relativamente brevi. Come scrive l’analista Agnese Rossi nel suo approfondimento “Proliferazione senza deterrenza o della bomba di Schrodinger” pubblicato su Limes, il caso più citato è quello dell’Iran, che, dopo l’abbandono dell’accordo sul nucleare (JCPOA), ha accumulato uranio arricchito oltre il 60%, avvicinandosi così alla soglia tecnica per lo sviluppo di un’arma nucleare, sebbene non ci siano prove definitive di una decisione in tal senso. Paesi come Giappone, Germania, Corea del Sud e il Brasile rientrano tra gli Stati a latenza nucleare: civili, industrializzati e dotati di infrastrutture e competenze sufficienti a sviluppare un’arma nucleare entro pochi anni, qualora decidessero di farlo.
La logica della “mutua distruzione assicurata” (MAD) che ha dominato durante la Guerra Fredda ha effettivamente contribuito a evitare l’uso diretto delle armi nucleari, mantenendo una pace armata fondata sul terrore reciproco. Ma oggi, quello stesso equilibrio si sta incrinando. Gli arsenali sono in espansione, i rischi di conflitto, volontario o accidentale, aumentano, e l’infrastruttura diplomatica che regolava la deterrenza nucleare si sta sgretolando. Il Trattato di Non Proliferazione (NPT) è sempre più sotto pressione, e diversi accordi bilaterali tra Stati Uniti e Russia sono stati sospesi o abbandonati, lasciando un vuoto normativo sempre più difficile da colmare.
Un’alternativa al paradigma della deterrenza è stata proposta dal Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW), adottato nel 2017 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e in vigore dal 2021. Firmato da oltre 90 Paesi (ma non dalle potenze nucleari), il trattato mira a vietare in modo assoluto lo sviluppo, il possesso e l’uso di armi atomiche, sancendo per la prima volta un chiaro divieto giuridico internazionale.
Hiroshima e Nagasaki restano simboli vividi del potenziale distruttivo dell’umanità. Nonostante i progressi e le speranze riposte nel disarmo, la minaccia atomica non è mai scomparsa: è rimasta silente, ma presente. Oggi, la domanda resta aperta: il mondo si sta davvero avvicinando a un disarmo effettivo, oppure sta lentamente scivolando verso una nuova era di possibile impiego delle armi nucleari? Finché la pace si regge sull’equilibrio del terrore, la minaccia atomica continuerà a proiettare la sua ombra sul futuro.
Ci sono poi gli Stati che al contrario hanno deciso di ‘chiudere’ con il nucleare ed eliminare le proprie dotazioni. Il Sudafrica allestì il suo forziere nucleare tra la metà degli anni ’70 e la fine degli ’80 del secolo scorso, ma se ne liberò nel 1991. Poi i Paesi ex Urss come Bielorussia, Kazakistan e Ucraina: una volta divenuti Stati indipendenti smantellarono gli armamenti o li restituirono all’ex casa madre Russia.
L’Italia non possiede ‘sua’ bomba nucleare ma è un paese disponibile ad ospitarla per conto della Nato. Accetta la condivisione nucleare “in caso di conflitto”. Dal 2018 i Paesi Nato che aderiscono a questo programma sono il Belgio (con 10 testate dislocate nella base di Klein Brogel), la Germania (10-20 testate nella base di Büchel), l’Italia (ci sarebbero 50 testate ad Aviano e 20-40 in quella di Ghedi), i Paesi Bassi (10-20 testate nella base di Volkel) e la Turchia (50-90 testate nella base di Adana).
I numeri delle testate nucleari non possono infatti mai essere precisi, perché restano segreto di Stato. Per la maggior parte degli Stati con armi nucleari esistono solo stime basate su analisi di esperti, dichiarazioni pubbliche e fughe di notizie. Fanno eccezione gli Stati Uniti e la Russia che, sulla base della serie di trattati START, devono sottoporre i propri arsenali nucleari a periodiche ispezioni pubbliche. Secondo l’ultimo rapporto dedicato allo stato della sicurezza globale del Sipri, l’istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma, pubblicato lo scorso 16 giugno, “sta emergendo una nuova e pericolosa corsa agli armamenti nucleari in un momento in cui i regimi di controllo degli armamenti sono gravemente indeboliti“.
Il mondo e l’umanità stanno correndo rischi altissimi senza una chiara azione diplomatica volta a trovare un accordo per nuovo ordine mondiale. Ma, nessuno è disposto a cedere potere, anzi ognuno cerca di arrivare ad un accordo in posizione egemone. Invece bisognerebbe preoccuparsi di dare all’umanità una società in cui tutti possano vivere dignitosamente costruendo un clima di certezze fatto di giustizia e libertà, per il quale è indispensabile un forte impegno corale.
Fonte: di Salvatore Rondello