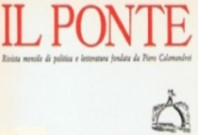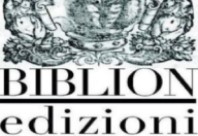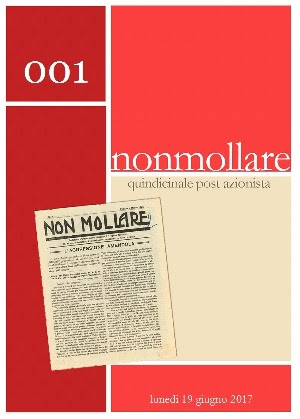RODOLFO MORANDI
20-07-2025 - GALLERIA SOCIALISTA di Ferdinando Leonzio
Il Partito ho servito, con serietà e onestà di intendimenti e con pari umiltà, nello schietto intento di servire la causa generale dei lavoratori.
(Rodolfo Morandi)
(Rodolfo Morandi)
Avvocato, economista, scrittore, attivo antifascista, principale dirigente del Centro Socialista Interno, perseguitato politico, autorevole esponente della Resistenza, ministro, senatore, fermo nella sua fede socialista, coerente fino al sacrificio, strenuo fautore dell'unità del movimento operaio, Rodolfo Morandi fu l'instancabile costruttore della rete organizzativa del partito socialista, destinata a sopravvivergli per molti anni, e il primo a lanciare la parola d'ordine del dialogo tra socialisti e cattolici.
Nella storia del socialismo italiano, sempre oscillante tra un riformismo, a volte un po' troppo accomodante, e un rivoluzionarismo spesso inconcludente e parolaio, la grandezza di Morandi sta, inoltre, nell'avere avviato un processo di rinnovamento in cui pensiero e azione si potessero fondere nell'ambito di una lotta unitaria per il socialismo; linea questa da lui sempre tenuta con ferma coerenza, qualche volta scambiata per freddezza, spiegata con un'oratoria “ragionata” e senza enfasi, in cui non c'era contrasto alcuno tra ideologia e politica, tra strategia e tattica. Questa la sua storia.
Rodolfo Morandi, terzo figlio dell'imprenditore alberghiero di idee mazziniane Enrico e di Enrica Maraviglia, nacque a Milano il 30 luglio 1902.
Ottenuto il diploma al liceo Parini di Milano, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, dove aderì al partito repubblicano e dove conobbe due personaggi destinati a diventare protagonisti prestigiosi del socialismo italiano: Lelio Basso e Giuseppe Faravelli.
Negli anni 1921-1925 si dedicò particolarmente allo studio delle opere di Giuseppe Mazzini e della filosofia hegeliana.
Dopo la tragica morte di Giacomo Matteotti per mano fascista (10-6-1924)[1] decise di impegnarsi in politica, fondando, assieme a Basso, i Gruppi goliardici per la libertà e collaborando con la rivista Quarto Stato[2] diretta da Carlo Rosselli e Pietro Nenni, mentre andava staccandosi dal partito repubblicano, per aderire al mondo socialista, specialmente dopo un viaggio in Germania, culla del socialismo marxista. Nel 1928, essendo stato individuato dalla polizia, si rifugiò in Francia, dove prese contatto con la Direzione socialista dell'esilio:
Io lo conobbi nei primi anni del lungo esilio a Parigi, dov'era venuto per prendere contatto con il Partito, prima di consacrarsi, qui a Milano, anima e corpo, alla organizzazione di un centro interno di azione socialista e alla rischiosa attività clandestina e sotterranea[3].
Frutto del nuovo orientamento ideologico fu la sua opera forse più nota: Storia della grande industria in Italia, pubblicata nel 1931[4]. Aveva intanto aderito, assieme a Faravelli, al movimento di “Giustizia e Libertà” (GL)[5], accentuandone tuttavia gli aspetti socialisti. Ma le tesi classiste e marxiste dell'intellettuale milanese, che assegnava al proletariato la direzione della rivoluzione antifascista e sosteneva l'impossibilità di risolvere la crisi italiana con il semplice ritorno alla democrazia borghese, si scontrarono con le posizioni liberalsocialiste del fondatore di GL. Nel luglio 1931 il PSI/IOS[6] stipulò un accordo con GL, in base al quale delegò formalmente a quest'ultima tutta l'attività clandestina in Italia.
Morandi criticò tale accordo e interruppe la sua attività clandestina, ritenendo irrinunciabile la vocazione classista del socialismo. Ciò tuttavia non lo spinse ad aderire all'altro movimento che agiva clandestinamente contro il regime mussoliniano: quello comunista, di cui respingeva gli aspetti autoritari e statalisti.
Severo era il suo giudizio sulla socialdemocrazia, la cui organizzazione riteneva inadeguata ad affrontare la sfida del fascismo.
Nel novembre del 1932 sposò Fausta Damiani, appartenente ad una famiglia di solida tradizione democratica e antifascista [7], dalla quale nel 1934 ebbe la sua unica figlia, Adriana.
Intorno alla metà degli anni '30 si verificarono avvenimenti fondamentali nella vita politica del Nostro. In tale periodo Morandi riprese, infatti, la sua sempre più intensa attività clandestina e si riavvicinò al partito socialista, che nel maggio 1934 aveva liquidato l'esperienza della Concentrazione antifascista[8], rotto l'accordo con GL e stipulato col Partito Comunista d'Italia (PCdI) un Patto di unità d'azione[9]. Il partito socialista si poneva ormai sulla strada di un socialismo schiettamente classista.
Quando il PSI/IOS dall'esilio di Parigi decise di promuovere un'azione autonoma di penetrazione in Italia, Morandi fu il più attivo protagonista della costituzione del Centro Socialista Interno (CSI), avvenuta nell'estate del 1934[10]. Dopo un inizio incentrato sulla propaganda ideologica il CSI cominciò a penetrare fra intellettuali e operai.
Morandi distingueva la sua futura azione in due distinte fasi: una “di transizione”, che prevedeva un'alleanza con i ceti borghesi progressisti nella comune lotta contro il fascismo; e una successiva in cui l'iniziativa spettava al movimento operaio per la costruzione dello Stato socialista. Per questo il partito doveva mantenere i suoi caratteri classisti e rivoluzionari. Per questo motivo egli non mise mai in discussione la sua linea politica unitaria nei confronti del partito comunista, anch'esso espressione della classe operaia, benché ne respingesse l'eccessivo centralismo che urtava con la spinta libertaria che secondo lui doveva caratterizzare la rivoluzione proletaria. La classe operaia doveva prevalere sul partito e non viceversa.
La sua azione instancabile alla direzione del Centro Socialista Interno servì, in effetti, negli anni dal 1934 al 1937, a riqualificare in senso classista e rivoluzionario il socialismo italiano, favorendo un indirizzo politico profondamente unitario[11], che avrà un ruolo importante anche nel dopoguerra.
Il successo dell'organizzazione clandestina socialista, specialmente durante la guerra di Spagna, non poteva sfuggire alla bieca sorveglianza della polizia fascista, che nell'aprile 1937 arrestò, nell'ambito di una vasta retata, circa 250 socialisti, fra cui vari dirigenti del CSI[12].
Morandi, invece di scappare e di mettersi in salvo, si lasciò arrestare in una seconda retata e fu deferito al Tribunale Speciale, che 13 ottobre 1937 lo condannò a 10 anni di carcere[13]. La pena fu scontata inizialmente nel penitenziario di Castelfranco Emilia (MO)[14] e, dal novembre 1940, a Saluzzo (CN), dove rimase fino al febbraio 1943[15], quando gli fu accordata la libertà condizionale per motivi di salute.
Dopo l'arresto di Morandi, la direzione del CSI passò a Eugenio Colorni, che sarà anch'egli arrestato nel 1938[16] e sostituito da Eugenio Curiel, poi divenuto comunista e ucciso nel 1945 dalle Brigate Nere. Dissoltosi in tal modo il CSI, bisognerà aspettare il 1942 per nuovi tentativi di ricostruire il PSI[17].
Il 29 settembre 1942 un gruppo di socialisti rimasti in Italia approvò un atto di ricostituzione del PSI con segretario Giuseppe Romita e vicesegretario Oreste Lizzadri[18]. La caduta del fascismo (25-7-1943) e la conseguente nomina del governo Badoglio, comportò il rilascio dei prigionieri politici.
Morandi, seppure in non buone condizioni di salute, riprese il suo impegno politico nelle file socialiste. Anche se non poté partecipare alla storica riunione che il 22 e 23 agosto 1943 si tenne in casa di Lizzadri, nella quale fu decisa la fusione tra il PSI, il MUP [19] e UP [20], che diede vita al Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP), Morandi fu inserito nella Direzione [21] del nuovo partito e gli fu anche assegnata la direzione dell'edizione milanese dell'Avanti!
Questo riassestamento delle forze socialiste non ebbe vita lunga, giacché, con l'annuncio dell'armistizio dell'8 settembre 1943, la virulenta reazione tedesca, la fuga del Re e del governo a Brindisi, la spaccatura dell'Italia in due parti [22], il PSIUP fu costretto a tornare alla clandestinità. Il giorno dopo, 9 settembre 1943, fu costituito dai partiti antifascisti il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN)[23]. Morandi, che si trovava a Milano, per evitare l'arresto fu costretto, come molti altri esponenti antifascisti milanesi, a espatriare in Svizzera (17-9-1943)[24]. Tornò in Italia quando Sandro Pertini, diventato segretario del PSIUP per l'Alta Italia, lo richiamò (giugno 1944) a Milano[25].
Durante la Resistenza Morandi cercò anche di approfondire i temi ideologici, attraverso il periodico Edificazione socialista e la rivista ufficiale del PSIUP Politica di classe. A suo avviso il programma del partito per il dopoguerra doveva puntare sulle nazionalizzazioni dei grandi monopoli e delle banche, sulla riforma fiscale e su quella agraria, tappe di un cammino che doveva portare allo Stato socialista.
In questo periodo gli furono affidati compiti importanti, come la preparazione e la formazione dei quadri socialisti, l'organizzazione militare in Lombardia, la guida dell'insurrezione di Torino.
Il 27 aprile 1945 fu nominato presidente del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) e il successivo 25 settembre membro della Consulta Nazionale[26].
Finita la guerra, le due tradizionali anime del socialismo italiano, e non solo, riemersero impetuose alla luce del sole nella prima assise pubblica tenuta dal PSIUP, il Consiglio Nazionale del 29 luglio-1° agosto del 1945. Vi si confrontarono una “sinistra” attestata a difesa dell'unità del movimento operaio, e dunque favorevole a una salda alleanza col PCI [27], e una “destra”, guidata da Giuseppe Saragat, che si poneva come vigile custode dell'autonomia politica e organizzativa del partito. Prevalse, col 76 %, la mozione della sinistra, firmata da Pertini, Basso e Morandi, il quale entrò nella nuova Direzione.
Fu poi formato un Esecutivo composto da Pietro Nenni (segretario generale), Sandro Pertini (segretario), Lelio Basso e Luigi Cacciatore, vicesegretari.
Quando Pertini si dimise da segretario (22-12-1945)[28] al suo posto fu eletto Rodolfo Morandi, che così assurse al vertice del partito, con vicesegretario Foscolo Lombardi e direttore dell'Avanti! Ignazio Silone.
Durante la sua gestione Morandi si attenne alla linea classista, che strategicamente comportava una stretta alleanza con il PCI, qualificandosi così come il principale leader e il maggior teorico della sinistra socialista; il che però portò inevitabilmente allo scontro con la contrapposta strategia socialdemocratica propugnata da Giuseppe Saragat.
Nella visione politica ed economica morandiana lo Stato doveva essere il motore dello sviluppo economico, collegando la nazionalizzazione dei settori strategici con la programmazione degli investimenti, promuovendo la industrializzazione del Mezzogiorno e la partecipazione dei lavoratori, per mezzo dei loro consigli di gestione, alla ricostruzione industriale.
All'approssimarsi del primo appuntamento congressuale dopo la Liberazione, convocato in vista del referendum istituzionale e delle elezioni dell'Assemblea Costituente, cominciarono a riemergere le diverse posizioni sulla strategia e sulla tattica cui il partito avrebbe dovuto attenersi, magari un po' troppo intrise di ideologismo parolaio.
Nella storia del socialismo italiano, sempre oscillante tra un riformismo, a volte un po' troppo accomodante, e un rivoluzionarismo spesso inconcludente e parolaio, la grandezza di Morandi sta, inoltre, nell'avere avviato un processo di rinnovamento in cui pensiero e azione si potessero fondere nell'ambito di una lotta unitaria per il socialismo; linea questa da lui sempre tenuta con ferma coerenza, qualche volta scambiata per freddezza, spiegata con un'oratoria “ragionata” e senza enfasi, in cui non c'era contrasto alcuno tra ideologia e politica, tra strategia e tattica. Questa la sua storia.
Rodolfo Morandi, terzo figlio dell'imprenditore alberghiero di idee mazziniane Enrico e di Enrica Maraviglia, nacque a Milano il 30 luglio 1902.
Ottenuto il diploma al liceo Parini di Milano, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, dove aderì al partito repubblicano e dove conobbe due personaggi destinati a diventare protagonisti prestigiosi del socialismo italiano: Lelio Basso e Giuseppe Faravelli.
Negli anni 1921-1925 si dedicò particolarmente allo studio delle opere di Giuseppe Mazzini e della filosofia hegeliana.
Dopo la tragica morte di Giacomo Matteotti per mano fascista (10-6-1924)[1] decise di impegnarsi in politica, fondando, assieme a Basso, i Gruppi goliardici per la libertà e collaborando con la rivista Quarto Stato[2] diretta da Carlo Rosselli e Pietro Nenni, mentre andava staccandosi dal partito repubblicano, per aderire al mondo socialista, specialmente dopo un viaggio in Germania, culla del socialismo marxista. Nel 1928, essendo stato individuato dalla polizia, si rifugiò in Francia, dove prese contatto con la Direzione socialista dell'esilio:
Io lo conobbi nei primi anni del lungo esilio a Parigi, dov'era venuto per prendere contatto con il Partito, prima di consacrarsi, qui a Milano, anima e corpo, alla organizzazione di un centro interno di azione socialista e alla rischiosa attività clandestina e sotterranea[3].
Frutto del nuovo orientamento ideologico fu la sua opera forse più nota: Storia della grande industria in Italia, pubblicata nel 1931[4]. Aveva intanto aderito, assieme a Faravelli, al movimento di “Giustizia e Libertà” (GL)[5], accentuandone tuttavia gli aspetti socialisti. Ma le tesi classiste e marxiste dell'intellettuale milanese, che assegnava al proletariato la direzione della rivoluzione antifascista e sosteneva l'impossibilità di risolvere la crisi italiana con il semplice ritorno alla democrazia borghese, si scontrarono con le posizioni liberalsocialiste del fondatore di GL. Nel luglio 1931 il PSI/IOS[6] stipulò un accordo con GL, in base al quale delegò formalmente a quest'ultima tutta l'attività clandestina in Italia.
Morandi criticò tale accordo e interruppe la sua attività clandestina, ritenendo irrinunciabile la vocazione classista del socialismo. Ciò tuttavia non lo spinse ad aderire all'altro movimento che agiva clandestinamente contro il regime mussoliniano: quello comunista, di cui respingeva gli aspetti autoritari e statalisti.
Severo era il suo giudizio sulla socialdemocrazia, la cui organizzazione riteneva inadeguata ad affrontare la sfida del fascismo.
Nel novembre del 1932 sposò Fausta Damiani, appartenente ad una famiglia di solida tradizione democratica e antifascista [7], dalla quale nel 1934 ebbe la sua unica figlia, Adriana.
Intorno alla metà degli anni '30 si verificarono avvenimenti fondamentali nella vita politica del Nostro. In tale periodo Morandi riprese, infatti, la sua sempre più intensa attività clandestina e si riavvicinò al partito socialista, che nel maggio 1934 aveva liquidato l'esperienza della Concentrazione antifascista[8], rotto l'accordo con GL e stipulato col Partito Comunista d'Italia (PCdI) un Patto di unità d'azione[9]. Il partito socialista si poneva ormai sulla strada di un socialismo schiettamente classista.
Quando il PSI/IOS dall'esilio di Parigi decise di promuovere un'azione autonoma di penetrazione in Italia, Morandi fu il più attivo protagonista della costituzione del Centro Socialista Interno (CSI), avvenuta nell'estate del 1934[10]. Dopo un inizio incentrato sulla propaganda ideologica il CSI cominciò a penetrare fra intellettuali e operai.
Morandi distingueva la sua futura azione in due distinte fasi: una “di transizione”, che prevedeva un'alleanza con i ceti borghesi progressisti nella comune lotta contro il fascismo; e una successiva in cui l'iniziativa spettava al movimento operaio per la costruzione dello Stato socialista. Per questo il partito doveva mantenere i suoi caratteri classisti e rivoluzionari. Per questo motivo egli non mise mai in discussione la sua linea politica unitaria nei confronti del partito comunista, anch'esso espressione della classe operaia, benché ne respingesse l'eccessivo centralismo che urtava con la spinta libertaria che secondo lui doveva caratterizzare la rivoluzione proletaria. La classe operaia doveva prevalere sul partito e non viceversa.
La sua azione instancabile alla direzione del Centro Socialista Interno servì, in effetti, negli anni dal 1934 al 1937, a riqualificare in senso classista e rivoluzionario il socialismo italiano, favorendo un indirizzo politico profondamente unitario[11], che avrà un ruolo importante anche nel dopoguerra.
Il successo dell'organizzazione clandestina socialista, specialmente durante la guerra di Spagna, non poteva sfuggire alla bieca sorveglianza della polizia fascista, che nell'aprile 1937 arrestò, nell'ambito di una vasta retata, circa 250 socialisti, fra cui vari dirigenti del CSI[12].
Morandi, invece di scappare e di mettersi in salvo, si lasciò arrestare in una seconda retata e fu deferito al Tribunale Speciale, che 13 ottobre 1937 lo condannò a 10 anni di carcere[13]. La pena fu scontata inizialmente nel penitenziario di Castelfranco Emilia (MO)[14] e, dal novembre 1940, a Saluzzo (CN), dove rimase fino al febbraio 1943[15], quando gli fu accordata la libertà condizionale per motivi di salute.
Dopo l'arresto di Morandi, la direzione del CSI passò a Eugenio Colorni, che sarà anch'egli arrestato nel 1938[16] e sostituito da Eugenio Curiel, poi divenuto comunista e ucciso nel 1945 dalle Brigate Nere. Dissoltosi in tal modo il CSI, bisognerà aspettare il 1942 per nuovi tentativi di ricostruire il PSI[17].
Il 29 settembre 1942 un gruppo di socialisti rimasti in Italia approvò un atto di ricostituzione del PSI con segretario Giuseppe Romita e vicesegretario Oreste Lizzadri[18]. La caduta del fascismo (25-7-1943) e la conseguente nomina del governo Badoglio, comportò il rilascio dei prigionieri politici.
Morandi, seppure in non buone condizioni di salute, riprese il suo impegno politico nelle file socialiste. Anche se non poté partecipare alla storica riunione che il 22 e 23 agosto 1943 si tenne in casa di Lizzadri, nella quale fu decisa la fusione tra il PSI, il MUP [19] e UP [20], che diede vita al Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP), Morandi fu inserito nella Direzione [21] del nuovo partito e gli fu anche assegnata la direzione dell'edizione milanese dell'Avanti!
Questo riassestamento delle forze socialiste non ebbe vita lunga, giacché, con l'annuncio dell'armistizio dell'8 settembre 1943, la virulenta reazione tedesca, la fuga del Re e del governo a Brindisi, la spaccatura dell'Italia in due parti [22], il PSIUP fu costretto a tornare alla clandestinità. Il giorno dopo, 9 settembre 1943, fu costituito dai partiti antifascisti il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN)[23]. Morandi, che si trovava a Milano, per evitare l'arresto fu costretto, come molti altri esponenti antifascisti milanesi, a espatriare in Svizzera (17-9-1943)[24]. Tornò in Italia quando Sandro Pertini, diventato segretario del PSIUP per l'Alta Italia, lo richiamò (giugno 1944) a Milano[25].
Durante la Resistenza Morandi cercò anche di approfondire i temi ideologici, attraverso il periodico Edificazione socialista e la rivista ufficiale del PSIUP Politica di classe. A suo avviso il programma del partito per il dopoguerra doveva puntare sulle nazionalizzazioni dei grandi monopoli e delle banche, sulla riforma fiscale e su quella agraria, tappe di un cammino che doveva portare allo Stato socialista.
In questo periodo gli furono affidati compiti importanti, come la preparazione e la formazione dei quadri socialisti, l'organizzazione militare in Lombardia, la guida dell'insurrezione di Torino.
Il 27 aprile 1945 fu nominato presidente del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) e il successivo 25 settembre membro della Consulta Nazionale[26].
Finita la guerra, le due tradizionali anime del socialismo italiano, e non solo, riemersero impetuose alla luce del sole nella prima assise pubblica tenuta dal PSIUP, il Consiglio Nazionale del 29 luglio-1° agosto del 1945. Vi si confrontarono una “sinistra” attestata a difesa dell'unità del movimento operaio, e dunque favorevole a una salda alleanza col PCI [27], e una “destra”, guidata da Giuseppe Saragat, che si poneva come vigile custode dell'autonomia politica e organizzativa del partito. Prevalse, col 76 %, la mozione della sinistra, firmata da Pertini, Basso e Morandi, il quale entrò nella nuova Direzione.
Fu poi formato un Esecutivo composto da Pietro Nenni (segretario generale), Sandro Pertini (segretario), Lelio Basso e Luigi Cacciatore, vicesegretari.
Quando Pertini si dimise da segretario (22-12-1945)[28] al suo posto fu eletto Rodolfo Morandi, che così assurse al vertice del partito, con vicesegretario Foscolo Lombardi e direttore dell'Avanti! Ignazio Silone.
Durante la sua gestione Morandi si attenne alla linea classista, che strategicamente comportava una stretta alleanza con il PCI, qualificandosi così come il principale leader e il maggior teorico della sinistra socialista; il che però portò inevitabilmente allo scontro con la contrapposta strategia socialdemocratica propugnata da Giuseppe Saragat.
Nella visione politica ed economica morandiana lo Stato doveva essere il motore dello sviluppo economico, collegando la nazionalizzazione dei settori strategici con la programmazione degli investimenti, promuovendo la industrializzazione del Mezzogiorno e la partecipazione dei lavoratori, per mezzo dei loro consigli di gestione, alla ricostruzione industriale.
All'approssimarsi del primo appuntamento congressuale dopo la Liberazione, convocato in vista del referendum istituzionale e delle elezioni dell'Assemblea Costituente, cominciarono a riemergere le diverse posizioni sulla strategia e sulla tattica cui il partito avrebbe dovuto attenersi, magari un po' troppo intrise di ideologismo parolaio.
Per questo il segretario Morandi volle richiamare [29] i suoi compagni a un maggiore realismo, che sostanzialmente era quello di condurre una battaglia unitaria per la repubblica, condizione indispensabile per la costruzione di un Italia democratica e per attuare le riforme sociali:
E' necessario ci rendiamo conto che primo compito nostro è di definire realisticamente e senza funambolismi ideologici una politica di partito nell'attuale momento.
La funzione propria del partito si definisce pertanto nel senso di sviluppare una sempre più vasta azione popolare per la democrazia, prefiggendole obbiettivi di sicurezza, sia nel campo politico che in quello economico.
Il primo obbiettivo da assegnarle è l'abbattimento della monarchia, di un istituto di cui è ben scaduta la reputazione e l'autorità, ma non la capacità di far leva su tutti gli interessi che avversano la democrazia, convogliando al loro seguito i disperati che sperano di trar guadagno da una nuova avventura.
Al XXIV congresso socialista (Firenze, 11-17/4/1946)[30] le forze della sinistra, (comprensive di quelle apertamente fusioniste) e quelle autonomiste (Iniziativa Socialista, Critica Sociale) risultarono sostanzialmente equilibrate, per cui esso si concluse con un compromesso, suggerito da Saragat, con Nenni Presidente del partito e il poco conosciuto Ivan Matteo Lombardo segretario. Morandi fu uno dei 7 componenti della sinistra della nuova Direzione[31].
Le elezioni del 2 giugno, in cui prevalse la repubblica, andarono abbastanza bene per il PSIUP che, col suo 20,68 %, si classifico secondo, dopo la DC, ed elesse alla Costituente 115/556 deputati, fra cui Morandi.
Questo successo comportò per i socialisti, oltre alla presidenza dell'Assemblea Costituente (Giuseppe Saragat), la nomina di quattro ministri, fra cui Morandi all'Industria e Commercio, nel secondo governo De Gasperi (14-7-1946/2-2-1947)[32]. Il risultato più importante della sua attività ministeriale, ispirata al principio della programmazione economica, fu la creazione dell'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (SVIMEZ)[33].
La tregua interna durò poco. I cattivi risultati nelle elezioni amministrative del novembre 1946 fecero da spunto per il riaccendersi delle polemiche e fu necessario convocare un nuovo congresso (Roma, 9-13 gennaio 1947), che si concluse drammaticamente con la scissione dell'ala socialdemocratica, guidata da Saragat [34]. Pesante fu il giudizio di Morandi sulla scissione. Egli sottolineò la sostanziale differenza tra l'antico riformismo e la nuova socialdemocrazia. Il primo era fautore di un socialismo graduale volto a evitare la crudezza delle rivoluzioni, senza tuttavia indulgere a deteriori compromessi con le forze della conservazione e sempre volto allo scopo finale della conquista del socialismo e della difesa della pace e della neutralità.
La moderna socialdemocrazia, invece – secondo Morandi - rientrava in un disegno internazionale volto a dividere il movimento operaio e a operare in Europa una restaurazione capitalista. Da qui la necessità di rispondere con una politica unitaria di classe.
Il PSIUP, su proposta di Olindo Vernocchi, riprese l'antica denominazione di Partito Socialista Italiano (PSI) e si diede una nuova Direzione [35], rappresentativa di tutte le posizioni, con Lelio Basso segretario, Foscolo Lombardi vicesegretario e Pietro Nenni direttore dell'Avanti!
E' necessario ci rendiamo conto che primo compito nostro è di definire realisticamente e senza funambolismi ideologici una politica di partito nell'attuale momento.
La funzione propria del partito si definisce pertanto nel senso di sviluppare una sempre più vasta azione popolare per la democrazia, prefiggendole obbiettivi di sicurezza, sia nel campo politico che in quello economico.
Il primo obbiettivo da assegnarle è l'abbattimento della monarchia, di un istituto di cui è ben scaduta la reputazione e l'autorità, ma non la capacità di far leva su tutti gli interessi che avversano la democrazia, convogliando al loro seguito i disperati che sperano di trar guadagno da una nuova avventura.
Al XXIV congresso socialista (Firenze, 11-17/4/1946)[30] le forze della sinistra, (comprensive di quelle apertamente fusioniste) e quelle autonomiste (Iniziativa Socialista, Critica Sociale) risultarono sostanzialmente equilibrate, per cui esso si concluse con un compromesso, suggerito da Saragat, con Nenni Presidente del partito e il poco conosciuto Ivan Matteo Lombardo segretario. Morandi fu uno dei 7 componenti della sinistra della nuova Direzione[31].
Le elezioni del 2 giugno, in cui prevalse la repubblica, andarono abbastanza bene per il PSIUP che, col suo 20,68 %, si classifico secondo, dopo la DC, ed elesse alla Costituente 115/556 deputati, fra cui Morandi.
Questo successo comportò per i socialisti, oltre alla presidenza dell'Assemblea Costituente (Giuseppe Saragat), la nomina di quattro ministri, fra cui Morandi all'Industria e Commercio, nel secondo governo De Gasperi (14-7-1946/2-2-1947)[32]. Il risultato più importante della sua attività ministeriale, ispirata al principio della programmazione economica, fu la creazione dell'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (SVIMEZ)[33].
La tregua interna durò poco. I cattivi risultati nelle elezioni amministrative del novembre 1946 fecero da spunto per il riaccendersi delle polemiche e fu necessario convocare un nuovo congresso (Roma, 9-13 gennaio 1947), che si concluse drammaticamente con la scissione dell'ala socialdemocratica, guidata da Saragat [34]. Pesante fu il giudizio di Morandi sulla scissione. Egli sottolineò la sostanziale differenza tra l'antico riformismo e la nuova socialdemocrazia. Il primo era fautore di un socialismo graduale volto a evitare la crudezza delle rivoluzioni, senza tuttavia indulgere a deteriori compromessi con le forze della conservazione e sempre volto allo scopo finale della conquista del socialismo e della difesa della pace e della neutralità.
La moderna socialdemocrazia, invece – secondo Morandi - rientrava in un disegno internazionale volto a dividere il movimento operaio e a operare in Europa una restaurazione capitalista. Da qui la necessità di rispondere con una politica unitaria di classe.
Il PSIUP, su proposta di Olindo Vernocchi, riprese l'antica denominazione di Partito Socialista Italiano (PSI) e si diede una nuova Direzione [35], rappresentativa di tutte le posizioni, con Lelio Basso segretario, Foscolo Lombardi vicesegretario e Pietro Nenni direttore dell'Avanti!
Dopo la scissione socialista Alcide De Gasperi (DC) costituì il suo terzo ministero, un “tripartito” DC-PCI-PSI, nel quale entrarono solo tre ministri socialisti: Luigi Cacciatore (Poste), Giuseppe Romita (Lavoro e Previdenza Sociale), Rodolfo Morandi (Industria e Commercio). Esso durò pochi mesi perché De Gasperi nel maggio 1947 scaricò i due partiti di sinistra e costituì un monocolore democristiano, inserendovi anche qualche ministro liberale.
Intanto la ruota della storia prendeva a girare velocemente. Il 21 ottobre 1947 il Partito d'Azione (Pd'Az) [36], nella sua maggioranza [37] (Riccardo Lombardi, Francesco De Martino, Vittorio Foa) decise di confluire nel PSI.
Nel dicembre 1947 PSLI e PRI entrarono nel governo, dando inizio alla lunga serie dei governi quadripartiti (DC, PSLI, PRI, PLI) di centro [38].
Il XXVI congresso del PSI (Roma, 19-22 gennaio 1948) decise a larghissima maggioranza (99,43 %) di costituire, in vista delle imminenti elezioni politiche, il Fronte Democratico Popolare (FDP) assieme al PCI. Passò anche (66,8 %) la decisione di presentare liste uniche PSI- PCI, nonostante le perplessità di alcuni membri della maggioranza, come Basso e Pertini, e l'aperta opposizione della nuova minoranza autonomista coagulatasi attorno a Giuseppe Romita. Morandi fu riconfermato nella Direzione.
Il 7 febbraio 1948 Ivan Matteo Lombardo e il gruppetto di estrema destra che lo seguiva lasciarono il PSI. Formeranno, assieme agli ex azionisti di Codignola e al gruppo di Europa Socialista guidato da Ignazio Silone, l'Unione dei Socialisti (UdS).
UdS e PSLI si presenteranno assieme, come Unità Socialista, alle elezioni politiche[39] del 18 aprile 1948. I risultati del Fronte furono disastrosi. E, all'interno della sconfitta, il PSI, meno organizzato del PCI nell'orientamento delle preferenze, fu il più colpito, ottenendo solo 46 deputati sui 183 eletti dal Fronte.
Tali risultati causarono disorientamento e malcontento all'interno del partito, specialmente nella sua ancora consistente ala destra degli autonomisti di Romita, ormai favorevoli a una denuncia non solo del Fronte, ma anche del Patto d'unità d'azione col PCI e alla riunificazione con l'Unione dei Socialisti e col PSLI, nell'ambito del COMISCO [40], antesignano della futura Internazionale Socialista.
Emerse nel PSI anche un'area centrista, guidata da Riccardo Lombardi e Alberto Jacometti, favorevole al mantenimento del Patto, ma non del Fronte e neutralista in politica estera. Quest'ultima al XXVII congresso (Genova, 27-30 giugno 1948) del partito ottenne la maggioranza relativa (42 %) e costituì una Direzione monocolore con segretario Alberto Jacometti e direttore dell'Avanti! Riccardo Lombardi.
Il senatore Morandi [41] ormai uno degli esponenti più qualificati della sinistra interna, nel suo intervento sostenne che le elezioni del 18 aprile erano da inquadrarsi nella più grande guerra fredda che si stava combattendo in Europa.
La sinistra socialista ritornò (50,06 %) alla guida dei PSI nel successivo congresso (Firenze, 11-16 maggio 1949), che elesse una Direzione interamente di sinistra [42], con Nenni segretario e Pertini direttore dell'Avanti!
Morandi fu chiamato a far parte dell'Esecutivo [43]. Lo stesso giorno della chiusura del Congresso Giuseppe Romita e la corrente autonomista lasciarono il PSI [44].
Fu allora che il PSI, nel mondo ormai diviso in due blocchi, operò in Italia, una scelta di campo, schierandosi accanto al PCI e all'Unione Sovietica, dichiarandosi contro la guerra, per il neutralismo in politica estera, contro il Patto Atlantico, contro i governi centristi e contro la socialdemocrazia. In un appello pubblicato sull'Avanti! del 20 maggio 1949, la nuova Direzione precisò gli obiettivi immediati che il partito si poneva al suo interno:
In ordine ai problemi inerenti alla vita interna del Partito, il Congresso ha dato alla Direzione il mandato del rafforzamento ideologico e della lotta contro l'opportunismo, dell'adeguamento dell'organizzazione ai compiti di un Partito moderno che non può vivere chiuso in sé medesimo, ma deve quotidianamente sforzarsi di tradurre in azione di massa la sua linea politica.
Sarà proprio nel campo dell'organizzazione che Morandi lascerà il segno. Egli organizzò il partito come forza espressa della classe operaia, impegnata nella lotta contro il capitalismo e l'imperialismo, eliminando incrostazioni clientelari e personalismi elettoralistici, ancora presenti nel PSI, preservandone tuttavia le caratteristiche ideologiche e creando nuclei preparati di funzionari, capaci di scuotere il partito e di guidarlo nelle grandi lotte [45]. Da allora i congressi divennero “unitari”, cioè senza mozioni concorrenti, per un decennio.
Nel gennaio 1951 Morandi divenne vicesegretario del PSI (con Nenni segretario) e mantenne tale carica fino alla morte, rimanendo sempre legato alla politica di intesa col PCI, anche aderendo al leninismo, e non risparmiandosi nel suo lavoro politico e organizzativo.
Al XXX congresso (Milano, 8-11 gennaio 1953), tutto incentrato sul tema della nuova legge elettorale sostenuta dai partiti governativi, la cosiddetta “legge truffa”, Morandi volle rispondere a quanti allora additavano il PSI come mancante di autonomia nei confronti del più forte e agguerrito PCI e addirittura appiattito su di esso:
Una volta sottratto il Partito alla influenza dei nemici di classe, liberatolo dagli agenti della borghesia, dai provocatori infiltratisi nelle nostre file, purgatolo da quanti erano entrati a flotti in esso, scambiando il socialismo per una forma di radicalismo borghese, ecco quindi che il PSI acquista coscienza della sua funzione, acquista certezza di essere utile strumento della lotta di classe, sicurezza nei confronti degli avversari, ecco cadere i complessi di inferiorità ai quali in passato il Partito era soggiaciuto ed esprimersi liberamente, espandersi entusiasticamente le energie del Partito, accrescersi le sue capacità, qualificarsi sempre meglio la sua personalità [46].
Alle elezioni del 7-8 giugno 1953 la “legge truffa” non scattò e il PSI ottenne un'ottima affermazione sia al Senato (11,90 % e 26 senatori) che alla Camera (12,70 % e 75 deputati). Morandi fu confermato senatore e successivamente eletto capogruppo del PSI. Ma l'irrequietezza [47] interna del Psi non era affatto scomparsa, poiché la sua vocazione libertaria per la dialettica e il confronto erano insiti nella sua natura e in quella dei suoi dirigenti, compreso lo stesso Morandi.
Egli intuì che il quadro politicamente immobile di quegli anni, con la costante contrapposizione fra centrismo e frontismo, doveva essere in qualche modo superato e si rese conto che era necessario un nuovo approccio tra i socialisti e le masse cattoliche e il partito che politicamente le rappresentava, la Democrazia Cristiana. Un discorso a cui i socialisti erano pronti a partecipare, non con una nuova operazione trasformistica, ma con la loro identitá classista e unitaria e non certo per fornire un nuovo puntello al traballante centrismo.
E, infatti, del XXXI congresso (Torino, 31 marzo-3 aprile 1955) fu lui il protagonista assoluto, il regista di una nuova stagione del socialismo italiano, quella del dialogo con i cattolici e dell'apertura a sinistra, ai cui sviluppi non poté però partecipare. Non è dato sapere quali sarebbero stati tali sviluppi nel disegno di Morandi, poiché la morte lo colse qualche mese dopo il congresso.
Intanto la ruota della storia prendeva a girare velocemente. Il 21 ottobre 1947 il Partito d'Azione (Pd'Az) [36], nella sua maggioranza [37] (Riccardo Lombardi, Francesco De Martino, Vittorio Foa) decise di confluire nel PSI.
Nel dicembre 1947 PSLI e PRI entrarono nel governo, dando inizio alla lunga serie dei governi quadripartiti (DC, PSLI, PRI, PLI) di centro [38].
Il XXVI congresso del PSI (Roma, 19-22 gennaio 1948) decise a larghissima maggioranza (99,43 %) di costituire, in vista delle imminenti elezioni politiche, il Fronte Democratico Popolare (FDP) assieme al PCI. Passò anche (66,8 %) la decisione di presentare liste uniche PSI- PCI, nonostante le perplessità di alcuni membri della maggioranza, come Basso e Pertini, e l'aperta opposizione della nuova minoranza autonomista coagulatasi attorno a Giuseppe Romita. Morandi fu riconfermato nella Direzione.
Il 7 febbraio 1948 Ivan Matteo Lombardo e il gruppetto di estrema destra che lo seguiva lasciarono il PSI. Formeranno, assieme agli ex azionisti di Codignola e al gruppo di Europa Socialista guidato da Ignazio Silone, l'Unione dei Socialisti (UdS).
UdS e PSLI si presenteranno assieme, come Unità Socialista, alle elezioni politiche[39] del 18 aprile 1948. I risultati del Fronte furono disastrosi. E, all'interno della sconfitta, il PSI, meno organizzato del PCI nell'orientamento delle preferenze, fu il più colpito, ottenendo solo 46 deputati sui 183 eletti dal Fronte.
Tali risultati causarono disorientamento e malcontento all'interno del partito, specialmente nella sua ancora consistente ala destra degli autonomisti di Romita, ormai favorevoli a una denuncia non solo del Fronte, ma anche del Patto d'unità d'azione col PCI e alla riunificazione con l'Unione dei Socialisti e col PSLI, nell'ambito del COMISCO [40], antesignano della futura Internazionale Socialista.
Emerse nel PSI anche un'area centrista, guidata da Riccardo Lombardi e Alberto Jacometti, favorevole al mantenimento del Patto, ma non del Fronte e neutralista in politica estera. Quest'ultima al XXVII congresso (Genova, 27-30 giugno 1948) del partito ottenne la maggioranza relativa (42 %) e costituì una Direzione monocolore con segretario Alberto Jacometti e direttore dell'Avanti! Riccardo Lombardi.
Il senatore Morandi [41] ormai uno degli esponenti più qualificati della sinistra interna, nel suo intervento sostenne che le elezioni del 18 aprile erano da inquadrarsi nella più grande guerra fredda che si stava combattendo in Europa.
La sinistra socialista ritornò (50,06 %) alla guida dei PSI nel successivo congresso (Firenze, 11-16 maggio 1949), che elesse una Direzione interamente di sinistra [42], con Nenni segretario e Pertini direttore dell'Avanti!
Morandi fu chiamato a far parte dell'Esecutivo [43]. Lo stesso giorno della chiusura del Congresso Giuseppe Romita e la corrente autonomista lasciarono il PSI [44].
Fu allora che il PSI, nel mondo ormai diviso in due blocchi, operò in Italia, una scelta di campo, schierandosi accanto al PCI e all'Unione Sovietica, dichiarandosi contro la guerra, per il neutralismo in politica estera, contro il Patto Atlantico, contro i governi centristi e contro la socialdemocrazia. In un appello pubblicato sull'Avanti! del 20 maggio 1949, la nuova Direzione precisò gli obiettivi immediati che il partito si poneva al suo interno:
In ordine ai problemi inerenti alla vita interna del Partito, il Congresso ha dato alla Direzione il mandato del rafforzamento ideologico e della lotta contro l'opportunismo, dell'adeguamento dell'organizzazione ai compiti di un Partito moderno che non può vivere chiuso in sé medesimo, ma deve quotidianamente sforzarsi di tradurre in azione di massa la sua linea politica.
Sarà proprio nel campo dell'organizzazione che Morandi lascerà il segno. Egli organizzò il partito come forza espressa della classe operaia, impegnata nella lotta contro il capitalismo e l'imperialismo, eliminando incrostazioni clientelari e personalismi elettoralistici, ancora presenti nel PSI, preservandone tuttavia le caratteristiche ideologiche e creando nuclei preparati di funzionari, capaci di scuotere il partito e di guidarlo nelle grandi lotte [45]. Da allora i congressi divennero “unitari”, cioè senza mozioni concorrenti, per un decennio.
Nel gennaio 1951 Morandi divenne vicesegretario del PSI (con Nenni segretario) e mantenne tale carica fino alla morte, rimanendo sempre legato alla politica di intesa col PCI, anche aderendo al leninismo, e non risparmiandosi nel suo lavoro politico e organizzativo.
Al XXX congresso (Milano, 8-11 gennaio 1953), tutto incentrato sul tema della nuova legge elettorale sostenuta dai partiti governativi, la cosiddetta “legge truffa”, Morandi volle rispondere a quanti allora additavano il PSI come mancante di autonomia nei confronti del più forte e agguerrito PCI e addirittura appiattito su di esso:
Una volta sottratto il Partito alla influenza dei nemici di classe, liberatolo dagli agenti della borghesia, dai provocatori infiltratisi nelle nostre file, purgatolo da quanti erano entrati a flotti in esso, scambiando il socialismo per una forma di radicalismo borghese, ecco quindi che il PSI acquista coscienza della sua funzione, acquista certezza di essere utile strumento della lotta di classe, sicurezza nei confronti degli avversari, ecco cadere i complessi di inferiorità ai quali in passato il Partito era soggiaciuto ed esprimersi liberamente, espandersi entusiasticamente le energie del Partito, accrescersi le sue capacità, qualificarsi sempre meglio la sua personalità [46].
Alle elezioni del 7-8 giugno 1953 la “legge truffa” non scattò e il PSI ottenne un'ottima affermazione sia al Senato (11,90 % e 26 senatori) che alla Camera (12,70 % e 75 deputati). Morandi fu confermato senatore e successivamente eletto capogruppo del PSI. Ma l'irrequietezza [47] interna del Psi non era affatto scomparsa, poiché la sua vocazione libertaria per la dialettica e il confronto erano insiti nella sua natura e in quella dei suoi dirigenti, compreso lo stesso Morandi.
Egli intuì che il quadro politicamente immobile di quegli anni, con la costante contrapposizione fra centrismo e frontismo, doveva essere in qualche modo superato e si rese conto che era necessario un nuovo approccio tra i socialisti e le masse cattoliche e il partito che politicamente le rappresentava, la Democrazia Cristiana. Un discorso a cui i socialisti erano pronti a partecipare, non con una nuova operazione trasformistica, ma con la loro identitá classista e unitaria e non certo per fornire un nuovo puntello al traballante centrismo.
E, infatti, del XXXI congresso (Torino, 31 marzo-3 aprile 1955) fu lui il protagonista assoluto, il regista di una nuova stagione del socialismo italiano, quella del dialogo con i cattolici e dell'apertura a sinistra, ai cui sviluppi non poté però partecipare. Non è dato sapere quali sarebbero stati tali sviluppi nel disegno di Morandi, poiché la morte lo colse qualche mese dopo il congresso.
Morì improvvisamente a Milano il 26 luglio 1955 [48]. Così la Direzione del PSI, appositamente riunita, ne descrisse il contributo alla causa del socialismo in un messaggio ai militanti:
Il contributo di Rodolfo Morandi allo sviluppo del Partito fu tanto originale nel pensiero e nella fedele interpretazione della dottrina del socialismo, quanto fermo nel concetto che il Partito si identifica con la classe operaia e con le masse popolari e trae dall'unità nella lotta la forza per portare avanti la democrazia fino all'avvento del socialismo [49].
Nell'orazione funebre [50] da lui tenuta, Pietro Nenni ebbe a dire, fra l'altro:
Uomo di eccezione fu il compagno Rodolfo Morandi, così come eccezionale è l'esempio di vita che egli lascia in eredità al Partito, ai lavoratori, ai giovani verso i quali sempre fu rivolta la sua autentica vocazione di educatore e di forgiatore di caratteri.
Tre preoccupazioni costanti lo dominarono: fare dell'organizzazione non un diaframma, ma l'organo di trasmissione dell'ideologia socialista e della politica del partito dal vertice alla base e dalla base al vertice; dare impulso alla politica unitaria del partito non tanto e non solo nella collaborazione fra dirigenti socialisti e comunisti, quanto nell'incontro delle masse nell'azione per gli obbiettivi politici e sociali della fase attuale della lotta di classe; attrezzare ideologicamente e tecnicamente il Partito ai grandi compiti di direzione della lotta politica e della lotta sindacale.
In Lui, in essi, il sentimento della responsabilità verso l'intera classe operaia, e verso tutto il popolo, non ha mortificato mai, ma esaltato, l'amore per il Partito, la volontà di fare più grande e più forte il Partito, di adeguarlo al compito insostituibile che gli è proprio: portare i lavoratori alla direzione dello Stato e della società. Questo pare a me, con l'esempio della vita, ciò che di Rodolfo rimarrà al di là della tomba. Un insegnamento che si è mutato in esperienza, un germe che si è dischiuso ai più promettenti germogli.
Un'interpretazione autentica e serena dell'azione politica del grande dirigente socialista scomparso fu lo stesso Morandi a darla nella parte politica del suo testamento [51], redatto il 23 novembre 1954, ma ritrovato fra le sue carte dopo la morte, da cui sono tratte le seguenti parole:
La mia fede unitaria, che è la scaturigine originaria delle mie prime esperienze politiche e di partito, è stata radicata sempre molto più nel fondo che non in analisi. Ha echeggiato l'aspirazione genuina, l'ansia e la speranza che è nel fondo di ogni lavoratore cosciente. Al di sopra del Partito ho sempre posto la causa dei lavoratori, la causa del popolo, nella convinzione che il Partito non avesse diritto di chiedermi di più. L'ho servito con intendimenti disinteressati sempre.
Il contributo di Rodolfo Morandi allo sviluppo del Partito fu tanto originale nel pensiero e nella fedele interpretazione della dottrina del socialismo, quanto fermo nel concetto che il Partito si identifica con la classe operaia e con le masse popolari e trae dall'unità nella lotta la forza per portare avanti la democrazia fino all'avvento del socialismo [49].
Nell'orazione funebre [50] da lui tenuta, Pietro Nenni ebbe a dire, fra l'altro:
Uomo di eccezione fu il compagno Rodolfo Morandi, così come eccezionale è l'esempio di vita che egli lascia in eredità al Partito, ai lavoratori, ai giovani verso i quali sempre fu rivolta la sua autentica vocazione di educatore e di forgiatore di caratteri.
Tre preoccupazioni costanti lo dominarono: fare dell'organizzazione non un diaframma, ma l'organo di trasmissione dell'ideologia socialista e della politica del partito dal vertice alla base e dalla base al vertice; dare impulso alla politica unitaria del partito non tanto e non solo nella collaborazione fra dirigenti socialisti e comunisti, quanto nell'incontro delle masse nell'azione per gli obbiettivi politici e sociali della fase attuale della lotta di classe; attrezzare ideologicamente e tecnicamente il Partito ai grandi compiti di direzione della lotta politica e della lotta sindacale.
In Lui, in essi, il sentimento della responsabilità verso l'intera classe operaia, e verso tutto il popolo, non ha mortificato mai, ma esaltato, l'amore per il Partito, la volontà di fare più grande e più forte il Partito, di adeguarlo al compito insostituibile che gli è proprio: portare i lavoratori alla direzione dello Stato e della società. Questo pare a me, con l'esempio della vita, ciò che di Rodolfo rimarrà al di là della tomba. Un insegnamento che si è mutato in esperienza, un germe che si è dischiuso ai più promettenti germogli.
Un'interpretazione autentica e serena dell'azione politica del grande dirigente socialista scomparso fu lo stesso Morandi a darla nella parte politica del suo testamento [51], redatto il 23 novembre 1954, ma ritrovato fra le sue carte dopo la morte, da cui sono tratte le seguenti parole:
La mia fede unitaria, che è la scaturigine originaria delle mie prime esperienze politiche e di partito, è stata radicata sempre molto più nel fondo che non in analisi. Ha echeggiato l'aspirazione genuina, l'ansia e la speranza che è nel fondo di ogni lavoratore cosciente. Al di sopra del Partito ho sempre posto la causa dei lavoratori, la causa del popolo, nella convinzione che il Partito non avesse diritto di chiedermi di più. L'ho servito con intendimenti disinteressati sempre.
- Morandi disapprovò l' “Aventino”, cioè la scelta dei deputati antifascisti di abbandonare i lavori parlamentari dopo l'uccisione di Matteotti.
- Il settimanale socialista e antifascista Il Quarto Stato, fondato e diretto da Pietro Nenni e Carlo Rosselli, durerà pochi mesi, dal 27/3 al 30/10 1926.
- Pietro Nenni in “Elogio funebre”, Mondo Operaio n. 15-16 del 1955.
- Altre sue opere significative furono: La democrazia del socialismo, Democrazia diretta e ricostruzione capitalistica, Il Partito e la Classe.
- Il movimento liberalsocialista “Giustizia e Libertà ” fu fondato a Parigi nell'agosto 1929; esso si proponeva una lotta concreta ed efficace contro il fascismo. Esponenti principali ne erano Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Alberto Tarchiani.
- All'estero i socialisti si erano riunificati, mettendo fine all'ormai inutile diatriba riformisti-massimalisti. Il congresso dell'unità ebbe luogo a Parigi, nella Casa dei socialisti francesi, il 19 e il 20 luglio 1930. Protagonisti ne furono l'ala fusionista del PSI guidata da Pietro Nenni e il PSULI di Filippo Turati e Giuseppe Saragat. Non vi aderì l'ala massimalista ortodossa del PSI, guidata da Angelica Balabanoff (PSIm), che si disgregherà nel 1940. Il nuovo partito si chiamò PSI/Sezione dell'Internazionale Operaia Socialista (PSI/IOS). Al congresso parteciparono 47 delegati, in rappresentanza di 1017 iscritti per il PSI fusionista e 50 delegati in rappresentanza di 811 iscritti al PSULI. Segretario fu eletto Ugo Coccia. Dopo un anno gli iscritti raddoppiarono.
- Fausta Damiani era figlia del bresciano Eugenio Damiani, ingegnere e imprenditore edile, e della genovese Ada Grossi, amica di Anna Kuliscioff. I fratelli Grossi, Mario (tra i fondatori del Partito d'Azione, morto a Mauthausen-Gusen), Alberto e Piero furono attivi antifascisti.
- La Concentrazione era un organismo unitario dell'emigrazione antifascista (esclusi i comunisti). Ne facevano parte il PSI, il PSULI, il PRI, la Lega italiana per i diritti dell'uomo e la CGdL, ricostituita all'estero dal sindacalista socialista Bruno Buozzi. Il suo settimanale La Libertà era diretto da Claudio Treves.
- Il Patto d'unità d'azione fra PSI/IOS e PCdI fu firmato il 17-8-1934.
- Fra i principali esponenti del CSI ricordiamo Giuseppe Faravelli, Lucio Luzzatto, Domenico Viotto, Antonio Greppi, Eugenio Colorni, Paolo Treves, Roberto Veratti.
- Morandi collaborava attivamente alla rivista Politica socialista, pubblicata in Francia e diffusa clandestinamente in Italia.
- Furono arrestati anche militanti comunisti e repubblicani.
- Il PSI/IOS gli dedicherà la tessera del 1938, assieme ad altri due imprigionati dal fascismo: Sandro Pertini (12 anni di carcere) e Antonio Pesenti (21 anni).
- In carcere partecipò all'organizzazione di un collettivo di studio dei detenuti.
- In carcere approfondì lo studio della questione meridionale, del problema agrario e dell'intervento pubblico nell'economia.
- Eugenio Colorni (1909-1944), filosofo, federalista europeo, redattore capo dell'Avanti!, sarà assassinato da militi fascisti il 28-5-1944.
- Il PSI/IOS di Parigi si era dissolto in seguito all'occupazione nazista della Francia.
- Dell'Esecutivo segreto e permanente facevano parte, oltre Romita e Lizzadri, Emilio Canevari, Nicola Perrotti e Olindo Vernocchi. Adesioni significative al risorto PSI furono quelle di Gregorio Agnini, Antonio Greppi, Ivan Matteo Lombardo, Alcide Malagugini, Lina Merlin.
- il Movimento di unità Proletaria per la Repubblica Socialista (MUP), con leader Lelio Basso, si proponeva il superamento del “tatticismo” riformista e del “nullismo” massimalista; esso era stato fondato a Milano il 10-1-1943. Vi aderivano alcuni futuri dirigenti socialisti di spicco come Carlo Andreoni, Lucio Luzzatto, Corrado Bonfantini, Domenico Viotto.
- L'Unione Proletaria (UP) era formata da giovani antifascisti che aderivano al socialismo inteso come realizzazione delle libertà individuali e collettive. Ne facevano parte, fra gli altri, Giuliano Vassalli, Vezio Crisafulli, Mario Zagari, Tullio Vecchietti, Leo Solari.
- Della Direzione facevano parte Pietro Nenni (segretario), Sandro Pertini (vicesegretario), Giuseppe Saragat, Rodolfo Morandi, Bruno Buozzi, Emilio Canevari, Giuseppe Romita, Oreste Lizzadri, Nicola Perrotta. Marcello Cirenei, Vannuccio Taralli, Filippo Acciarini, Carmine Mancinelli (ex PSI); Lelio Basso, Carlo Andreoni (vicesegretario), Lucio Luzzatto, Corrado Bonfantini, Roberto Verari, Gianguido Borghese (ex MUP); Giuliano Vassalli, Mario Zagari, Vezio Crisafulli, Tullio Vecchietti (ex UP).
- Nel centro-nord, occupato dai tedeschi, fu costituita la Repubblica Sociale Italiana (RSI), detta anche Repubblica di Salò, dove fu costituito un governo fascista fantoccio capeggiato da Mussolini. Nell'Italia meridionale, occupata dagli Alleati, detta anche Il Regno del Sud, risiedeva il Re e il governo Badoglio, in continuità giuridica con le istituzioni monarchiche.
- Ne facevano parte il PCI, il PSIUP, il Partito d'Azione (PdAz), la DC, la Democrazia del lavoro (DL), il PLI.
- Risiedette a Lugano presso Guglielmo Canevascini (1886-1965), leader socialista ticinese e fervente antifascista.
- La direzione politica del PSIUP nell'Italia occupata era composta, oltre che da Pertini, da Rodolfo Morandi, Lelio Basso, Corrado Bonfantini e Guido Mazzali. Scopo principale: organizzare la resistenza al nazifascismo, soprattutto mediante la costituzione di Brigate Matteotti.
- La Consulta Nazionale fu un'assemblea legislativa consultiva provvisoria che si insediò il 25 -9 -1945 ed ebbe fine con l'elezione dell'Assemblea Costituente (2-6-1946). La prima seduta fu presieduta dal socialista Gregorio Agnini, in quanto il più anziano dei consultori. Presidente fu poi eletto il repubblicano Carlo Sforza (1872-1952). Il PSIUP vi ottenne 38 membri su un totale di 430. Morandi fu presidente della Commissione affari politici e amministrativi.
- Dopo lo scioglimento dell'Internazionale Comunista (15-5-1943) il Partito Comunista d'Italia (PCdI) assunse la denominazione di Partito Comunista Italiano (PCI).
- Pertini si dimise per contrasti politici con i due vicesegretari (anch'essi dimissionari), per le loro posizioni eccessivamente fusioniste, giá rigettate dal CC del 17-22/10/1945.
- In articolo Verso il congresso, pubblicato sulla rivista Socialismo del marzo 1946.
- Il congresso fu dominato dall'elevato duello oratorio fra Nenni e Saragat.
- La nuova Direzione era così composta: Lelio Basso, Luigi Cacciatore, Luigi Chignoli, Alberto Jacometti, Foscolo Lombardi, Ivan Matteo Lombardo, Rodolfo Morandi, Pietro Nenni, Sandro Pertini, Giuseppe Saragat, Ignazio Silone, Alberto Simonini, Aldo Valcarenghi, Mario Zagari, Lina Merlin (per le donne), Matteo Matteotti (per i giovani), Oreste Lizzadri (per i sindacalisti).
- Gli altri tre erano: Pietro Nenni (Esteri), Giuseppe Romita (Lavori Pubblici) e Ludovico D'Aragona (Lavoro e Previdenza Sociale).
- La SVIMEZ è un'associazione privata, istituita il 2-12-1946. La sua finalità á quella di studiare le condizioni economiche del Mezzogiorno, al fine di proporre concreti programmi di intervento.
- Gli scissionisti si riunirono a parte, a Palazzo Barberini, e fondarono (11-1-1947) il Partito Socialista dei Lavoratori italiani (PSLI), cui aderirono la maggioranza delle correnti di “Iniziativa Socialista” e di “Critica Sociale” e 52 deputati sui 115 eletti alla Costituente. Saragat si dimise da presidente della Costituente e fu sostituito dal comunista Umberto Terracini, essendo divenuto il PCI il secondo partito.
- Ne facevano parte Lelio Basso, Gaetano Bertelli, Agatino Bonfiglio, Amerigo Bottai, Luigi Cacciatore, Vannuccio Faralli, Michele Giua, Alberto Jacometti, Foscolo Lombardi, Cesare Lombroso, Lucio Luzzatto, Oreste Lizzadri, Giacomo Mancini, Lina Merlin, Rodolfo Morandi, Pietro Nenni, Nicola Perrotti, Giuseppe Romita, Piero Rossi, Renato Sansone, Giusto Tolloy.
- Il Partito d'Azione, fondato il 14-7-1942, era l'erede politico del movimento Giustizia e Libertà di Carlo Rosselli.
- La minoranza (Tristano Codignola, Piero Calamandrei, Paolo Vittorelli) costituì il Movimento d'Azione Socialista Giustizia e Libertà.
- Al ministero dell'Industria e Commercio andò il socialdemocratico Roberto Tremelloni, ex sottosegretario di Rodolfo Morandi.
- Unità Socialista ottenne alla Camera il 7,07 % e 33 deputati.
- Comitato della Conferenza Internazionale Socialista, costituito nel novembre 1946.
- La III disposizione transitoria e finale della Costituzione aveva stabilito che, nella 1° legislatura, avrebbero fatto parte del Senato, accanto ai senatori eletti, anche dei senatori di diritto. Si trattava dei membri della Costituente che avessero particolari requisiti. Essi furono 107, di cui 11 (fra cui Rodolfo Morandi) erano iscritti al PSI: Francesco Buffoni, Giovanni Cosattini, Michele Giua, Emidio Lopardi, Pietro Mancini, Rodolfo Morandi, Tito Oro Nobili, Sandro Pertini, Antonio Priolo, Giuseppe Romita, Tommaso Tonello.
- La Direzione era così composta: Lelio Basso, Amerigo Bottai, Nazareno Buschi, Luigi Cacciatore, Elena Caporaso, Laura Conti, Achille Corona, Francesco De Martino, Michele Giua, Oreste Lizzadri, Lucio Luzzatto, Alcide Malagugini, Lionello Matteucci, Guido Mazzali, Rodolfo Morandi, Pietro Nenni, Sandro Pertini, Luigi Renato Sansone, Ferdinando Targetti, Azzo Toni, Alberto Trebbi.
- Facevano parte dell'Esecutivo: Pietro Nenni, Sandro Pertini, Lucio Luzzatto, Lelio Basso, Amerigo Bottai, Luigi Cacciatore, Oreste Lizzadri e Rodolfo Morandi.
- I nuovi scissionisti si organizzarono in Movimento Socialista Autonomo (MSA) che successivamente (4-12-1949) si fonderà con l'UdS (segretario Ignazio Silone) e con la sinistra socialdemocratica guidata da Ugo Guido Mondolfo, dando vita al Partito Socialista Unitario (PSU). Quest'ultimo, a sua volta, il 1° maggio 1951, assieme al PSLI, costituirà il Partito Socialista-Sezione Italiana dell'Internazionale Socialista (PS-SIIS), in seguito rinominato Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI).
- Sua la creazione dei NAS (Nuclei Aziendali Socialisti).
- In Avanti!, 11-1-1953
- Il termine irrequietezza è ispirato al titolo del libro di Paolo Mattera Il partito irrequieto, ed. Carocci, 2004.
- Al Senato, il 27-9-1955, gli subentrò Mario Grampa (1899-1961), ex sindaco di Busto Arsizio, che sarà riconfermato nella carica anche nel 1958.
- In Avanti!, 27-7-1955.
- L'intera orazione funebre di Nenni fu pubblicata in Mondo Operaio n. 15-16 del 1955.
- La parte politica del testamento di Morandi, indirizzata “Al Partito, ai miei compagni”, fu pubblicata per intero nel già citato n. 15-16 del 1955 della rivista Mondo Operaio. Da essa è tratta pure la frase in corsivo posta all'inizio di questo lavoro.
Fonte: di Ferdinando Leonzio