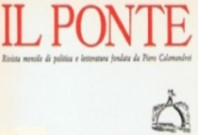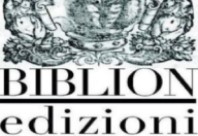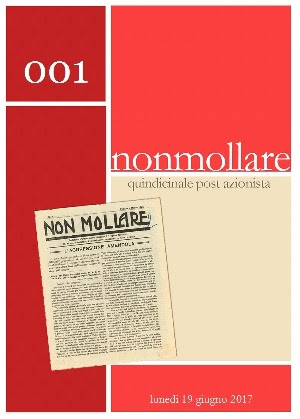L'ITALIA SECONDA IN EUROPA PER I NEET di Sergio Castelli
IN EUROPA PER I NEET
di Sergio Castelli
27-10-2025 - CRONACHE SOCIALISTE
Al primo posto la Romania, seguono la Lituania e la Grecia. In Italia l’incidenza massima nelle città e nelle aree urbane più densamente popolate, mentre risulta inferiore sia nei comuni a densità intermedia sia nelle aree rurali.
Il 15 luglio di ogni anno, le Nazioni Unite celebrano la Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili. Questo evento rappresenta un'importante occasione per valutare gli sforzi messi in atto dai vari Stati nel potenziare le competenze delle giovani generazioni. Tale riflessione assume una rilevanza ancora maggiore alla luce dei dati, che evidenziano una situazione giovanile complessa, soprattutto dopo l'impatto del Covid. Sul piano socio economico, si registra un aumento della povertà infantile; dal punto di vista educativo, vi è un incremento di fenomeni come l'abbandono scolastico, specialmente tra gli studenti più vulnerabili.
In Italia, nonostante le narrazioni spesso contrarie, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano né sono impegnati in percorsi di istruzione o formazione (noti come NEET, acronimo di "Not in Education, Employment or Training") rappresentano il 15,2%, circa 1,3 milioni del totale dei giovani, secondo i dati di Eurostat pubblicati il 12 giugno 2025 e aggiornati ai primi tre mesi dello stesso anno. Sebbene questa percentuale sia in calo rispetto agli anni precedenti (16,1% nel 2023 e 19% nel 2022), contrariamente a quanto afferma il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che dichiara: «il numero dei NEET è in continua crescita», l'Italia rimane, dopo la Romania (19,4%), il paese con il tasso di NEET più elevato in Europa nel 2024. A seguire troviamo la Lituania (14,7%) e la Grecia (14,2%). Questi paesi si trovano ad affrontare una sfida cruciale per raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione Europea per il 2030, che mira a ridurre al di sotto del 9% la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi formativi. Nel 2024, i Paesi Bassi (4,9%), la Svezia (6,3%) e Malta (7,2%) registrano le percentuali più basse di NEET. Questi stati, insieme ad altri sei, hanno già conseguito il traguardo delineato per il 2030. L'obiettivo in questione pone una forte enfasi su tematiche sociali riguardanti i giovani ed è una componente essenziale del piano d’azione per il pilastro europeo dei diritti sociali. Allo stesso tempo, ha evidenti ricadute educative che incidono in maniera significativa sui sistemi scolastici. I divari formativi presenti nel paese possono condizionare la situazione futura dei NEET sotto due principali prospettive, spesso strettamente collegate tra loro. Da un lato, un livello di istruzione inadeguato o l’ottenimento di un titolo scolastico che non rappresenta un reale bagaglio di competenze (fenomeno noto come dispersione implicita) rende difficoltoso l’accesso sia a percorsi di istruzione superiore che al mercato del lavoro. Questo problema è particolarmente rilevante in un contesto lavorativo che richiede sempre più competenze tecnologiche e digitali, indispensabili per assicurarsi posizioni stabili e ben remunerate.
Il 15 luglio di ogni anno, le Nazioni Unite celebrano la Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili. Questo evento rappresenta un'importante occasione per valutare gli sforzi messi in atto dai vari Stati nel potenziare le competenze delle giovani generazioni. Tale riflessione assume una rilevanza ancora maggiore alla luce dei dati, che evidenziano una situazione giovanile complessa, soprattutto dopo l'impatto del Covid. Sul piano socio economico, si registra un aumento della povertà infantile; dal punto di vista educativo, vi è un incremento di fenomeni come l'abbandono scolastico, specialmente tra gli studenti più vulnerabili.
In Italia, nonostante le narrazioni spesso contrarie, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano né sono impegnati in percorsi di istruzione o formazione (noti come NEET, acronimo di "Not in Education, Employment or Training") rappresentano il 15,2%, circa 1,3 milioni del totale dei giovani, secondo i dati di Eurostat pubblicati il 12 giugno 2025 e aggiornati ai primi tre mesi dello stesso anno. Sebbene questa percentuale sia in calo rispetto agli anni precedenti (16,1% nel 2023 e 19% nel 2022), contrariamente a quanto afferma il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che dichiara: «il numero dei NEET è in continua crescita», l'Italia rimane, dopo la Romania (19,4%), il paese con il tasso di NEET più elevato in Europa nel 2024. A seguire troviamo la Lituania (14,7%) e la Grecia (14,2%). Questi paesi si trovano ad affrontare una sfida cruciale per raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione Europea per il 2030, che mira a ridurre al di sotto del 9% la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi formativi. Nel 2024, i Paesi Bassi (4,9%), la Svezia (6,3%) e Malta (7,2%) registrano le percentuali più basse di NEET. Questi stati, insieme ad altri sei, hanno già conseguito il traguardo delineato per il 2030. L'obiettivo in questione pone una forte enfasi su tematiche sociali riguardanti i giovani ed è una componente essenziale del piano d’azione per il pilastro europeo dei diritti sociali. Allo stesso tempo, ha evidenti ricadute educative che incidono in maniera significativa sui sistemi scolastici. I divari formativi presenti nel paese possono condizionare la situazione futura dei NEET sotto due principali prospettive, spesso strettamente collegate tra loro. Da un lato, un livello di istruzione inadeguato o l’ottenimento di un titolo scolastico che non rappresenta un reale bagaglio di competenze (fenomeno noto come dispersione implicita) rende difficoltoso l’accesso sia a percorsi di istruzione superiore che al mercato del lavoro. Questo problema è particolarmente rilevante in un contesto lavorativo che richiede sempre più competenze tecnologiche e digitali, indispensabili per assicurarsi posizioni stabili e ben remunerate.
Nel nostro paese, conseguire un diploma di scuola superiore non sembra sempre sufficiente a ridurre il rischio di diventare NEET. Mentre in Europa la percentuale di NEET tra i diplomati (11,3%) è quasi in linea con la media generale (circa 11%), in Italia questa cifra tra i giovani diplomati sale al 18%, superando di quasi 3 punti la media nazionale (15,2%). Per i laureati italiani, invece, il dato scende all’11,8%. Sorprendentemente, la percentuale di NEET è maggiore tra coloro che possiedono un diploma di scuola superiore rispetto a chi si ferma alla licenza media (13,3%). Questo riflette da una parte le peculiarità del mercato del lavoro italiano e dall’altra le carenze del sistema scolastico nel formare adeguatamente anche chi termina il ciclo d’istruzione secondaria. Un problema rilevante è la mancanza di supporto per i giovani nella scelta del loro percorso scolastico. Un aspetto cruciale è rappresentato proprio dalle difficoltà nell’orientamento e nelle decisioni educative.
Come evidenziato anche dagli studi di Almalaurea, gli studenti spesso ricevono indicazioni poco chiare o inadeguate su queste scelte fondamentali, con il rischio di prendere decisioni poco consapevoli. L’assenza di un percorso di orientamento valido può portare a scelte non in linea con le proprie attitudini e, in alcuni casi, all’abbandono del sistema formativo. L’incidenza dei giovani NEET varia notevolmente sul territorio nazionale, differenziandosi non solo tra Nord e Sud ma anche rispetto al grado di urbanizzazione dei luoghi in cui vivono. Secondo i dati Eurostat, il fenomeno è più pronunciato nelle città e nelle aree urbane densamente popolate, dove il tasso supera il 16%, contro il 15% delle aree a densità intermedia (14,7%) e delle zone rurali (14,4%). Nel 2024, il dato raggiunge il 16,3% nelle città e nei centri urbani con la maggiore densità abitativa. I dati sulle disuguaglianze interne al paese offrono un'ulteriore chiave di lettura. Incrociando le informazioni Istat sulle condizioni socio-economiche delle famiglie e altre fonti amministrative, emerge un quadro chiaro: si tratta di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano né studiano. Tuttavia, va notato che questi dati, derivanti da statistiche sperimentali dell’Istat, sono disponibili solo per i comuni con almeno cinquemila abitanti e risalgono al 2020, anno segnato profondamente dagli effetti della pandemia. Nonostante ciò, si conferma una tendenza consolidata: il fenomeno è particolarmente grave in alcune grandi città del Sud. Nel 2020 i capoluoghi con la più alta percentuale di NEET erano concentrati soprattutto nel mezzogiorno: Catania (42%), Palermo (39,8%), Napoli (37,3%), Messina (33,7%), Caltanissetta (32,1%), Agrigento (31,7%), Trapani (31,6%), Siracusa (31,5%), Frosinone (30,5%) ed Enna (30,4%). Al contrario, le città capoluogo con le percentuali più basse di NEET includevano Belluno (16,1%), Pesaro (16,4%), Rimini (17,3%), Siena (17,6%), Forlì (17,7%), Prato (17,8%), Aosta (17,9%), Ravenna (17,9%), Matera (18%) e Grosseto (18,4%).
Cosa possiamo fare per modificare questa tendenza? Dobbiamo esplorare le ragioni e le storie di questi giovani. Ascoltarle con attenzione e riconoscerne la validità in un contesto segnato da incertezza e complessità; questa azione rappresenta il primo passo necessario che il mondo adulto e le istituzioni sono chiamati a compiere. Ripercorrere con i protagonisti gli errori e i momenti di svolta come tappe fondamentali, ricche di opportunità di apprendimento, è l'approccio ideale per supportarli nel loro percorso verso l'età adulta.
Come evidenziato anche dagli studi di Almalaurea, gli studenti spesso ricevono indicazioni poco chiare o inadeguate su queste scelte fondamentali, con il rischio di prendere decisioni poco consapevoli. L’assenza di un percorso di orientamento valido può portare a scelte non in linea con le proprie attitudini e, in alcuni casi, all’abbandono del sistema formativo. L’incidenza dei giovani NEET varia notevolmente sul territorio nazionale, differenziandosi non solo tra Nord e Sud ma anche rispetto al grado di urbanizzazione dei luoghi in cui vivono. Secondo i dati Eurostat, il fenomeno è più pronunciato nelle città e nelle aree urbane densamente popolate, dove il tasso supera il 16%, contro il 15% delle aree a densità intermedia (14,7%) e delle zone rurali (14,4%). Nel 2024, il dato raggiunge il 16,3% nelle città e nei centri urbani con la maggiore densità abitativa. I dati sulle disuguaglianze interne al paese offrono un'ulteriore chiave di lettura. Incrociando le informazioni Istat sulle condizioni socio-economiche delle famiglie e altre fonti amministrative, emerge un quadro chiaro: si tratta di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano né studiano. Tuttavia, va notato che questi dati, derivanti da statistiche sperimentali dell’Istat, sono disponibili solo per i comuni con almeno cinquemila abitanti e risalgono al 2020, anno segnato profondamente dagli effetti della pandemia. Nonostante ciò, si conferma una tendenza consolidata: il fenomeno è particolarmente grave in alcune grandi città del Sud. Nel 2020 i capoluoghi con la più alta percentuale di NEET erano concentrati soprattutto nel mezzogiorno: Catania (42%), Palermo (39,8%), Napoli (37,3%), Messina (33,7%), Caltanissetta (32,1%), Agrigento (31,7%), Trapani (31,6%), Siracusa (31,5%), Frosinone (30,5%) ed Enna (30,4%). Al contrario, le città capoluogo con le percentuali più basse di NEET includevano Belluno (16,1%), Pesaro (16,4%), Rimini (17,3%), Siena (17,6%), Forlì (17,7%), Prato (17,8%), Aosta (17,9%), Ravenna (17,9%), Matera (18%) e Grosseto (18,4%).
Cosa possiamo fare per modificare questa tendenza? Dobbiamo esplorare le ragioni e le storie di questi giovani. Ascoltarle con attenzione e riconoscerne la validità in un contesto segnato da incertezza e complessità; questa azione rappresenta il primo passo necessario che il mondo adulto e le istituzioni sono chiamati a compiere. Ripercorrere con i protagonisti gli errori e i momenti di svolta come tappe fondamentali, ricche di opportunità di apprendimento, è l'approccio ideale per supportarli nel loro percorso verso l'età adulta.
Fonte: di Sergio Castelli