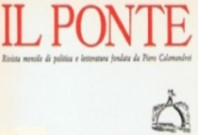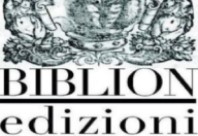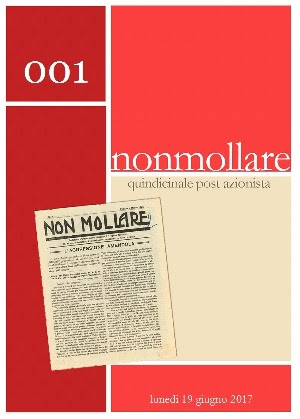CORRADO BONFANTINI
27-10-2025 - GALLERIA SOCIALISTA di Ferdinando Leonzio
Corrado Bonfantini nacque e si formò in una famiglia di antica tradizione socialista, di cui assorbì i saldi principi. Uomo d'azione, personalità ribelle, ma anche ricca di umanità, abbracciò giovanissimo le idee di libertà e di giustizia sociale del socialismo, alle quali rimase sempre fedele, mettendo spesso a rischio la sua libertà e la sua stessa vita.
Alla storia del socialismo italiano e dell'antifascismo appartiene il suo nome, soprattutto per essere stato comandante delle Brigate Matteotti.
Egli nacque a Novara il 22 febbraio 1909 da Giuseppe Bonfantini (1877-1955) [1] e da Maria Ferrari (1896-1948) [2] ed ebbe una sorella, Vera, e tre fratelli: Mario [3], Sergio [4] e Felice (Cino) [5], tutti socialisti e antifascisti.
L'aver assistito alle violenze e alle intimidazioni fasciste contro il padre, sindaco socialista di Novara, fecero sorgere in lui uno spirito di ribellione che lo porterà ad un antifascismo senza tentennamenti: già a 16 anni si occupò di politica e nel 1924, dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti, si iscrisse al Partito Socialista Unitario (PSU) [6] e, quando questo fu sciolto, a quello che ne prese il posto, il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI) [7]. Quando anche quest'ultimo, in seguito alle leggi speciali, fu sciolto, il giovane Corrado, assieme a Camillo Pasquali, futuro sindaco di Novara e senatore del PSI dopo la Liberazione, fondò il Gruppo dei Rossi Liberi, formato da giovani tendenti all'unità antifascista tra socialisti e comunisti. Il contatto con questi ultimi nel 1927 lo portò ad aderire al PCdI [8]. Nell'ottobre dello stesso anno si iscrisse alla facoltà di Medicina della Statale di Milano, dove continuò la sua attività politica clandestina. In occasione di una retata di antifascisti, a soli 19 anni, venne arrestato.
Il Tribunale Speciale di Roma lo condannò, per congiura contro il governo, a 18 mesi di carcere, per cui da Regina Coeli (Roma) venne mandato al carcere giudiziario di Cassino (FR) e, infine, a Suna-Pallanza, frazione di Verbania (VCO), da cui fu rilasciato il 29 ottobre 1929.
Uscito dal carcere, Corrado si diede da fare per aiutare la famiglia, facendo lezioni private di matematica e fisica, essedo stato il padre trasferito a Cagliari; ma non interruppe, pur essendo sorvegliato dal regime, i suoi contatti con gli antifascisti novaresi; sinché, in seguito ad una soffiata, il 4 marzo 1933, poco prima della laurea in Medicina, fu nuovamente arrestato a Milano e, dopo quattro mesi di isolamento a San Vittore, il 28 luglio 1933 venne condannato a cinque anni di confino, trascorsi prima a Ponza, poi alle isole Tremiti e, infine, a Istonia Marina (CH). Il 12 dicembre 1934 venne prosciolto e adempì al servizio militare, come soldato semplice, all'Ospedale Militare di Torino.
Nel 1935 conseguì la laurea [9] e aprì uno studio medico a Novara, guadagnandosi il nomignolo di medico dei poveri, per la sua umanità e generosità e rimanendo in contatto con gli altri antifascisti.
L'ingresso in guerra dell'Italia a fianco della Germania nazista e i suoi drammatici sviluppi, come l'attacco alla Grecia, alla Jugoslavia e all'URSS, resero la vigilanza del regime assai più severa, specialmente per tipi come Corrado, sempre attivo cospiratore antifascista.
Il 10 gennaio 1943, ad esempio, egli partecipò alla costituzione del “Movimento di Unità Proletaria per la repubblica socialista” (MUP) con leader Lelio Basso, organizzazione socialista che si proponeva il superamento del “tatticismo” riformista e del “nullismo” massimalista [10].
Ma il 12 gennaio 1943 – dunque in piena guerra – venne di nuovo arrestato come indiziato di attività antifascista e l'11 maggio successivo condannato a cinque anni di confino, ancora alle Tremiti, da cui sarà liberato il 14 agosto 1943, in seguito agli avvenimenti che in quel periodo investirono l'intera politica italiana, fra cui in particolare lo sbarco degli Alleati in Sicilia, la caduta del governo Mussolini (25-7-1943) e la sua sostituzione col governo monarchico del maresciallo Pietro Badoglio.
Tale avvenimento, pur lasciando inalterata l'alleanza dell'Italia con la Germania nazista e la prosecuzione della guerra accanto ad essa, aveva favorito un clima di relativa democrazia che, sia pure lentamente, avrebbe portato al rientro in Italia di molti esuli e al rilascio dei prigionieri politici e dei confinati, come Pietro Nenni, Sandro Pertini e Bruno Buozzi. Ciò consentì il risorgere dei partiti politici, che pian piano uscirono allo scoperto e presero a riorganizzare le loro file.
Le ragioni della costituzione del MUP, al quale il battagliero Bonfantini aderiva, erano state spiegate su un numero dell'Avanti! pubblicato il 1° agosto 1943 dallo stesso movimento, in cui, fra l'altro si leggeva:
I vecchi partiti sono morti, ben morti.
Quel che ne è sopravvissuto, attraverso questo periodo di lotte illegali, sono delle audaci organizzazioni clandestine, attrezzate forse per la cospirazione, ma prive da vent'anni di contatti con la vita vera e con i veri sentimenti delle masse, soprattutto della generazione che in questi vent'anni si è formata.
Pretendere di trasformarli di nuovo in partiti di masse, di farne senz'altro degli strumenti efficienti di lotta politica in un nuovo clima in cui ben diverse saranno le situazioni e i compiti, sarebbe commettere un errore politico. Un errore politico anche perché vorrebbe dire richiamare in vita, insieme ai vecchi partiti che — nati in situazioni storiche diverse e per obbedire ad esigenze diverse - non rispondono più alle nuove condizioni, anche tutto il bagaglio delle polemiche, delle lotte intestine, delle scissioni che quei diversi partiti rappresentano, tutto il peso degli errori che i vecchi nomi richiamano. […].
Il nostro movimento ha per compito appunto di promuovere la futura costituzione di questo nuovo partito unificato del proletariato italiano: non quindi un terzo o quarto partito, ma soltanto il centro di raccolta per tutti coloro, vecchi e giovani, che non credono ai vecchi schemi e alle mentalità del passato, e vogliono adoperarsi per la fondazione del partito unico del proletariato.
In realtà l'auspicata unificazione fu possibile solo tra le forze di area socialista, nel corso di un incontro, avvenuto a Roma, in casa di Oreste Lizzadri il 23 agosto 1943, dalla quale scaturì la formazione del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP), con segretario Nenni [11]. Bonfantini, da poco scarcerato, non era presente alla riunione, ma venne inserito lo stesso nella Direzione [12]. Attivo e appassionato come sempre, Bonfantini si diede a girare soprattutto il Piemonte e la Lombardia per ricostituire sezioni e federazioni socialiste.
Questo suo intenso lavoro organizzativo fu interrotto dall'annuncio dell'8 settembre 1943, con cui si diede comunicazione dell'avvenuto armistizio fra Italia e Alleati. La notizia provocò gravi e drammatiche conseguenze: la fuga del Re e del governo Badoglio nel Meridione d'Italia, occupato dagli anglo-americani, e il loro insediamento prima a Brindisi e poi a Salerno; la furiosa reazione tedesca; la sgretolamento dell'esercito italiano; la creazione, nel Centro-Nord occupato dai tedeschi, dello stato fantoccio detto Repubblica Sociale Italiana (RSI) governata da Mussolini e dal nuovo Partito Fascista Repubblicano (PFR); la costituzione, il 9 settembre 1943, del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) formato da sei partiti antifascisti [13], col compito di dirigere la lotta, sia politica che militare, contro il nazifascismo.
Mentre nel Regno del Sud la vita politica si svolgeva con una certa regolarità, nel territorio di Salò il neo costituito PSIUP, come tutti gli altri partiti antifascisti, fu invece costretto a tornare nella clandestinità. Il 10 settembre 1943 il PSIUP decise di organizzare un proprio “Centro militare” al comando del vicesegretario Sandro Pertini [14], il quale però venne arrestato il 1° ottobre 1943, assieme a Giuseppe Saragat. I due furono liberati con uno stratagemma da un commando di partigiani socialisti guidati da Giuliano Vassalli il 24 gennaio 1944. Successivamente Pertini fu inviato al Nord, a Milano, dove riorganizzò il partito, falcidiato da arresti e deportazioni, e diede vita al Comitato Esecutivo del PSIUP per l'Alta Italia. Intanto Corrado, scoperto a Torino, era stato di nuovo arrestato dalla polizia fascista e ferito in un tentativo di fuga. Portato all'ospedale San Giovanni Vecchio di Torino, era riuscito a fuggire dalla sala operatoria e a riparare a Milano.
Anche nel capoluogo lombardo prese subito contatto con il PSIUP, dandosi anch'egli da fare per rianimare l'organizzazione clandestina socialista, tanto che nel giugno 1944 venne inserito nel Comitato Esecutivo per l'Alta Italia del PSIUP, il quale decise la costituzione delle Brigate Matteotti, il cui comando generale venne affidato proprio a Corrado Bonfantini [15]. Il quale, in tal veste, inviò a tutte le formazioni un'ispirata circolare [16]:
Operai, contadini, studenti accorsi generosamente a rafforzare le schiere dei patrioti, nel combattere tra le nostre fila tendete non solo alla meta immediata della cacciata dei nazisti e dei fascisti, ma a quella più alta che consiste nel preparare un mondo migliore.
Bonfantini (nome di battaglia Corrado) fu uno dei principali organizzatori di quella che fu detta La Repubblica dell'Ossola, una repubblica partigiana sorta nel novarese con una propria Giunta Provvisoria di Governo, presieduta dal medico socialista Ettore Tibaldi (futuro senatore) e durata dal 10 settembre al 23 ottobre 1944 [17].
Nell'aprile 1945 il comandante Bonfantini, nell'illusione di poter cosi evitare ulteriori spargimenti di sangue, accettò ingenuamente di trattare sulla disperata e fantasiosa proposta avanzata da alcuni esponenti fascisti, impauriti dall'imminente crollo del regime, circa un passaggio incruento di poteri dalla RSI al CLNAI [18]. Nello stesso tempo però i tedeschi, ormai in precipitosa ritirata, scaricavano la loro rabbia sulla popolazione inerme, colpevole di aver aiutato i partigiani. Fu Pertini [19] a ricordargli che con i fascisti non si tratta, mentre il PSIUP e il CLN si affrettarono a sconfessare il tentativo.
Corrado dunque si rituffò nella lotta di liberazione con più foga di prima, con grande coraggio e dedizione alla causa del socialismo. Fu lui per primo ad annunciare la liberazione di Milano da una stazione radio occupata dai partigiani della Matteotti:
Alla storia del socialismo italiano e dell'antifascismo appartiene il suo nome, soprattutto per essere stato comandante delle Brigate Matteotti.
Egli nacque a Novara il 22 febbraio 1909 da Giuseppe Bonfantini (1877-1955) [1] e da Maria Ferrari (1896-1948) [2] ed ebbe una sorella, Vera, e tre fratelli: Mario [3], Sergio [4] e Felice (Cino) [5], tutti socialisti e antifascisti.
L'aver assistito alle violenze e alle intimidazioni fasciste contro il padre, sindaco socialista di Novara, fecero sorgere in lui uno spirito di ribellione che lo porterà ad un antifascismo senza tentennamenti: già a 16 anni si occupò di politica e nel 1924, dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti, si iscrisse al Partito Socialista Unitario (PSU) [6] e, quando questo fu sciolto, a quello che ne prese il posto, il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI) [7]. Quando anche quest'ultimo, in seguito alle leggi speciali, fu sciolto, il giovane Corrado, assieme a Camillo Pasquali, futuro sindaco di Novara e senatore del PSI dopo la Liberazione, fondò il Gruppo dei Rossi Liberi, formato da giovani tendenti all'unità antifascista tra socialisti e comunisti. Il contatto con questi ultimi nel 1927 lo portò ad aderire al PCdI [8]. Nell'ottobre dello stesso anno si iscrisse alla facoltà di Medicina della Statale di Milano, dove continuò la sua attività politica clandestina. In occasione di una retata di antifascisti, a soli 19 anni, venne arrestato.
Il Tribunale Speciale di Roma lo condannò, per congiura contro il governo, a 18 mesi di carcere, per cui da Regina Coeli (Roma) venne mandato al carcere giudiziario di Cassino (FR) e, infine, a Suna-Pallanza, frazione di Verbania (VCO), da cui fu rilasciato il 29 ottobre 1929.
Uscito dal carcere, Corrado si diede da fare per aiutare la famiglia, facendo lezioni private di matematica e fisica, essedo stato il padre trasferito a Cagliari; ma non interruppe, pur essendo sorvegliato dal regime, i suoi contatti con gli antifascisti novaresi; sinché, in seguito ad una soffiata, il 4 marzo 1933, poco prima della laurea in Medicina, fu nuovamente arrestato a Milano e, dopo quattro mesi di isolamento a San Vittore, il 28 luglio 1933 venne condannato a cinque anni di confino, trascorsi prima a Ponza, poi alle isole Tremiti e, infine, a Istonia Marina (CH). Il 12 dicembre 1934 venne prosciolto e adempì al servizio militare, come soldato semplice, all'Ospedale Militare di Torino.
Nel 1935 conseguì la laurea [9] e aprì uno studio medico a Novara, guadagnandosi il nomignolo di medico dei poveri, per la sua umanità e generosità e rimanendo in contatto con gli altri antifascisti.
L'ingresso in guerra dell'Italia a fianco della Germania nazista e i suoi drammatici sviluppi, come l'attacco alla Grecia, alla Jugoslavia e all'URSS, resero la vigilanza del regime assai più severa, specialmente per tipi come Corrado, sempre attivo cospiratore antifascista.
Il 10 gennaio 1943, ad esempio, egli partecipò alla costituzione del “Movimento di Unità Proletaria per la repubblica socialista” (MUP) con leader Lelio Basso, organizzazione socialista che si proponeva il superamento del “tatticismo” riformista e del “nullismo” massimalista [10].
Ma il 12 gennaio 1943 – dunque in piena guerra – venne di nuovo arrestato come indiziato di attività antifascista e l'11 maggio successivo condannato a cinque anni di confino, ancora alle Tremiti, da cui sarà liberato il 14 agosto 1943, in seguito agli avvenimenti che in quel periodo investirono l'intera politica italiana, fra cui in particolare lo sbarco degli Alleati in Sicilia, la caduta del governo Mussolini (25-7-1943) e la sua sostituzione col governo monarchico del maresciallo Pietro Badoglio.
Tale avvenimento, pur lasciando inalterata l'alleanza dell'Italia con la Germania nazista e la prosecuzione della guerra accanto ad essa, aveva favorito un clima di relativa democrazia che, sia pure lentamente, avrebbe portato al rientro in Italia di molti esuli e al rilascio dei prigionieri politici e dei confinati, come Pietro Nenni, Sandro Pertini e Bruno Buozzi. Ciò consentì il risorgere dei partiti politici, che pian piano uscirono allo scoperto e presero a riorganizzare le loro file.
Le ragioni della costituzione del MUP, al quale il battagliero Bonfantini aderiva, erano state spiegate su un numero dell'Avanti! pubblicato il 1° agosto 1943 dallo stesso movimento, in cui, fra l'altro si leggeva:
I vecchi partiti sono morti, ben morti.
Quel che ne è sopravvissuto, attraverso questo periodo di lotte illegali, sono delle audaci organizzazioni clandestine, attrezzate forse per la cospirazione, ma prive da vent'anni di contatti con la vita vera e con i veri sentimenti delle masse, soprattutto della generazione che in questi vent'anni si è formata.
Pretendere di trasformarli di nuovo in partiti di masse, di farne senz'altro degli strumenti efficienti di lotta politica in un nuovo clima in cui ben diverse saranno le situazioni e i compiti, sarebbe commettere un errore politico. Un errore politico anche perché vorrebbe dire richiamare in vita, insieme ai vecchi partiti che — nati in situazioni storiche diverse e per obbedire ad esigenze diverse - non rispondono più alle nuove condizioni, anche tutto il bagaglio delle polemiche, delle lotte intestine, delle scissioni che quei diversi partiti rappresentano, tutto il peso degli errori che i vecchi nomi richiamano. […].
Il nostro movimento ha per compito appunto di promuovere la futura costituzione di questo nuovo partito unificato del proletariato italiano: non quindi un terzo o quarto partito, ma soltanto il centro di raccolta per tutti coloro, vecchi e giovani, che non credono ai vecchi schemi e alle mentalità del passato, e vogliono adoperarsi per la fondazione del partito unico del proletariato.
In realtà l'auspicata unificazione fu possibile solo tra le forze di area socialista, nel corso di un incontro, avvenuto a Roma, in casa di Oreste Lizzadri il 23 agosto 1943, dalla quale scaturì la formazione del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP), con segretario Nenni [11]. Bonfantini, da poco scarcerato, non era presente alla riunione, ma venne inserito lo stesso nella Direzione [12]. Attivo e appassionato come sempre, Bonfantini si diede a girare soprattutto il Piemonte e la Lombardia per ricostituire sezioni e federazioni socialiste.
Questo suo intenso lavoro organizzativo fu interrotto dall'annuncio dell'8 settembre 1943, con cui si diede comunicazione dell'avvenuto armistizio fra Italia e Alleati. La notizia provocò gravi e drammatiche conseguenze: la fuga del Re e del governo Badoglio nel Meridione d'Italia, occupato dagli anglo-americani, e il loro insediamento prima a Brindisi e poi a Salerno; la furiosa reazione tedesca; la sgretolamento dell'esercito italiano; la creazione, nel Centro-Nord occupato dai tedeschi, dello stato fantoccio detto Repubblica Sociale Italiana (RSI) governata da Mussolini e dal nuovo Partito Fascista Repubblicano (PFR); la costituzione, il 9 settembre 1943, del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) formato da sei partiti antifascisti [13], col compito di dirigere la lotta, sia politica che militare, contro il nazifascismo.
Mentre nel Regno del Sud la vita politica si svolgeva con una certa regolarità, nel territorio di Salò il neo costituito PSIUP, come tutti gli altri partiti antifascisti, fu invece costretto a tornare nella clandestinità. Il 10 settembre 1943 il PSIUP decise di organizzare un proprio “Centro militare” al comando del vicesegretario Sandro Pertini [14], il quale però venne arrestato il 1° ottobre 1943, assieme a Giuseppe Saragat. I due furono liberati con uno stratagemma da un commando di partigiani socialisti guidati da Giuliano Vassalli il 24 gennaio 1944. Successivamente Pertini fu inviato al Nord, a Milano, dove riorganizzò il partito, falcidiato da arresti e deportazioni, e diede vita al Comitato Esecutivo del PSIUP per l'Alta Italia. Intanto Corrado, scoperto a Torino, era stato di nuovo arrestato dalla polizia fascista e ferito in un tentativo di fuga. Portato all'ospedale San Giovanni Vecchio di Torino, era riuscito a fuggire dalla sala operatoria e a riparare a Milano.
Anche nel capoluogo lombardo prese subito contatto con il PSIUP, dandosi anch'egli da fare per rianimare l'organizzazione clandestina socialista, tanto che nel giugno 1944 venne inserito nel Comitato Esecutivo per l'Alta Italia del PSIUP, il quale decise la costituzione delle Brigate Matteotti, il cui comando generale venne affidato proprio a Corrado Bonfantini [15]. Il quale, in tal veste, inviò a tutte le formazioni un'ispirata circolare [16]:
Operai, contadini, studenti accorsi generosamente a rafforzare le schiere dei patrioti, nel combattere tra le nostre fila tendete non solo alla meta immediata della cacciata dei nazisti e dei fascisti, ma a quella più alta che consiste nel preparare un mondo migliore.
Bonfantini (nome di battaglia Corrado) fu uno dei principali organizzatori di quella che fu detta La Repubblica dell'Ossola, una repubblica partigiana sorta nel novarese con una propria Giunta Provvisoria di Governo, presieduta dal medico socialista Ettore Tibaldi (futuro senatore) e durata dal 10 settembre al 23 ottobre 1944 [17].
Nell'aprile 1945 il comandante Bonfantini, nell'illusione di poter cosi evitare ulteriori spargimenti di sangue, accettò ingenuamente di trattare sulla disperata e fantasiosa proposta avanzata da alcuni esponenti fascisti, impauriti dall'imminente crollo del regime, circa un passaggio incruento di poteri dalla RSI al CLNAI [18]. Nello stesso tempo però i tedeschi, ormai in precipitosa ritirata, scaricavano la loro rabbia sulla popolazione inerme, colpevole di aver aiutato i partigiani. Fu Pertini [19] a ricordargli che con i fascisti non si tratta, mentre il PSIUP e il CLN si affrettarono a sconfessare il tentativo.
Corrado dunque si rituffò nella lotta di liberazione con più foga di prima, con grande coraggio e dedizione alla causa del socialismo. Fu lui per primo ad annunciare la liberazione di Milano da una stazione radio occupata dai partigiani della Matteotti:
Qui parla Corrado, comandante delle Matteotti. Milano è libera. Abbiamo conquistato la libertà, ma ora dobbiamo costruire una democrazia.
Terminata la guerra e quindi la lotta partigiana, Bonfantini non lasciò la vita politica, a cui si era dedicato da giovanissimo e divenne segretario della Federazione del PSIUP di Torino, ma non mancò di partecipare attivamente anche alle vicende della politica nazionale. Intanto nel partito socialista emergevano le diverse anime che gli avevano dato vita: quella dei fuorusciti ritornati dall'esilio, come Nenni e Saragat, quella dei vecchi massimalisti come Vernocchi e dei fusionisti come Lizzadri, dei riformisti turatiani, organizzati attorno alla rivista Critica Sociale, come Mondolfo e Faravelli, quella dei giovani come Vassalli e Zagari riuniti attorno a Iniziativa Socialista - sorta nel 1946 a Milano e diretta proprio da Bonfantini - da cui la loro corrente prendeva nome. La dialettica, sempre vivace in casa socialista, era destinata ad assumere toni via via più accesi, a causa dell'eterno problema del rapporto coi comunisti e con l'URSS.
Le differenziazioni tra coloro che privilegiavano l'alleanza col PCI per assicurare l'unità del proletariato contro i già evidenti tentativi di restaurazione capitalistica e coloro che sostenevano posizioni fortemente autonomistiche per assicurare all'Italia e all'Europa un'essenziale iniziativa socialista e democratica emersero con chiarezza sia nel Consiglio Nazionale del 29-7/1°agosto 1945, presieduto dal prestigioso sindaco partigiano di Milano Antonio Greppi, che nel XXIV congresso socialista (Firenze, 11-14/4/1946), conclusosi però con un necessario compromesso essendo imminenti le elezioni per l'Assemblea Costituente (2-6-1946), in cui il PSIUP ottenne un risultato più che soddisfacente[20]. Bonfantini fu eletto nel collegio Torino-Novara-Vercelli, con 28.629 voti di preferenza.
Tuttavia, dopo i deludenti risultati delle elezioni amministrative del successivo novembre, il clima interno del PSIUP si arroventó e il suo successivo congresso (Roma, 9-13/1/1947) dovette registrare la cosiddetta “scissione di Palazzo Barberini” (11-1-1947), guidata da Giuseppe Saragat, le cui truppe furono fornite dalla riformista corrente “Critica Sociale” (Ugo Guido Mondolfo, Giuseppe Faravelli), dalla sinistra di “Iniziativa Socialista” (Giuliano Vassalli, Mario Zagari) e dalla Federazione Giovanile Socialista Italiana (Leo Solari, Matteo Matteotti), unite dall'acceso autonomismo e dalla diffidenza verso il comunismo. Corrado Bonfantini aderì alla nuova formazione che assunse la denominazione di Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI)[21], della cui Direzione egli fu chiamato a far parte[22].
Alle prime elezioni politiche del dopoguerra, tenute il 18 aprile 1948, la lista di Unità Socialista, espressione del cartello elettorale PSLI + UdS[23], conseguì una buona affermazione, avendo ottenuto il 7,1 % e 33/574 deputati, fra cui Corrado Bonfantini, eletto ancora nello stesso collegio.
Ma anche nel PSLI le carte si sarebbero rimescolate di fronte ai grossi problemi del dopoguerra, il principale dei quali era la divisione del mondo in due blocchi contrapposti: quello "occidentale", capitanato dagli USA e quello "orientale" guidato dall'URSS. Tale divisione era destinata a calarsi anche all'interno degli Stati, Italia compresa. Essa finirà anche per stritolare ogni posizione intermedia autonoma, costringendo i partiti socialisti a schierarsi con l'uno o con l'altro blocco.
Il PSI, pur dichiarandosi neutralista in politica estera, si schierò idealmente con l'URSS. Per quanto riguardava la socialdemocrazia italiana, rappresentata essenzialmente dal PSLI, il primo grosso problema da affrontare fu la questione della partecipazione ai governi centristi a direzione democristiana, auspicata dal centro-destra del partito, guidato da Giuseppe Saragat e Alberto Simonini, e la contrarietà delle sinistre, i cui leader Ugo Guido Mondolfo e Mario Zagari, fautori di un'Europa autonoma e socialista, temevano di essere inglobati nel blocco occidentale.
Successivamente si aggiunsero la spinosa questione dell'adesione o meno all'Alleanza Atlantica (NATO), espressione militare del blocco occidentale, e quella dell'unificazione socialista o almeno delle organizzazioni che stavano fuori del PSI, ormai acquisito alla politica frontista col PCI.
Alla fine l'unica unificazione possibile si rivelò quella tra la sinistra del PSLI, con cui stava Bonfantini, l'UdS, di cui si é accennato, e il Movimento Socialista (MAS), formato dai residui autonomisti guidati da Giuseppe Romita che il 16 maggio 1949 avevano lasciato il PSI.
Le tre forze, il 4 dicembre 1949 costituirono il Partito Socialista Unitario (PSU)[24] nella cui Direzione[25] e nel cui gruppo parlamentare entrò anche Corrado Bonfantini[26].
Il secondo congresso del PSU dovette però registrare la divisone tra coloro, guidati da Giuseppe Romita e risultati maggioritari, che auspicavano la fusione col PSLI e quelli che preferivano mantenere l'esistenza autonoma del partito, fra cui Bonfantini che entrò anche nella nuova Direzione[27].
Si arrivò dunque alla fusione tra PSU e PSLI che fu ufficializzata il 1° maggio 1951 con la costituzione del Partito Socialista-Sezione Italiana dell'Internazionale Socialista (PS-SIIS), che fu ammesso, come unico rappresentante dell'Italia, nella costituenda Internazionale Socialista e che al suo primo congresso (Bologna, 3-6 gennaio 1952) assunse la definitiva denominazione di Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI).
Il PSDI risultava tuttavia molto frastagliato al suo interno; ma il vero confronto era tra il suo centro-destra, ormai integrato nel centrismo in politica interna e nell'atlantismo in quella estera, e il suo centro-sinistra legato alla tradizione socialista e democratica. Un duro confronto si aprì nel PSDI a causa della proposta governativa di una nuova legge elettorale, poi chiamata legge-truffa, per modificare in senso fortemente maggioritario[28] la precedente legge proporzionale.
L'acceso dibattito interno del PSDI si concluse con la vittoria dell'ala saragattiana e la sinistra ne uscì ridimensionata, anche perché una sua ala lasciò il partito[29], mentre quella riunita attorno a Critica Sociale (Faravelli, Mondolfo) e gli ultimi eredi di Iniziativa Socialista preferirono continuare la loro lotta all'interno del partito.
La legge fu approvata dal Parlamento, a maggioranza centrista, nonostante la forte opposizione delle sinistre (PSI, PCI) e delle destre (PNM, MSI), ma non produsse i suoi effetti maggioritari, giacché la coalizione centrista (DC-PSDI-PRI-PLI) non riuscì a raggiungere il quorum richiesto. Il PSDI ne pagò lo scotto anche sul piano elettorale, in quanto alle elezioni politiche del 7-8 giugno 1953 scese da 33 a 19 deputati. Bonfantini comunque fu rieletto, ancora nel collegio Torino-Novara-Vercelli.
Gli anni che seguirono furono densi di avvenimenti in campo socialista:
Il dialogo con i cattolici avviato dal PSI nel 1955, gli articoli di Nenni sul XX congresso del PCUS e la destalinizzazione, la rivoluzione ungherese, la rottura del Patto d'unità d'azione PSI-PCI, la distensione internazionale, l'incontro Nenni-Saragat di Pralognan (Savoia) del 25-8-1956, il congresso di Venezia del PSI del 1957, la costituzione di giunte locali di centro-sinistra, il sorgere di una corrente autonomista capeggiata da Pietro Nenni avviarono il PSI ad abbandonare la politica frontista e a intraprendere la strada dell'autonomia socialista.
La sinistra socialdemocratica, ora collaborando ora polemizzando col resto del partito ormai saldamente in mano a Saragat, aveva seguito con attenzione l'evolversi della politica del PSI, in cui intanto erano confluite l'Unione socialista Indipendente (24-3-1957), guidata da Valdo Magnani e Unità Popolare (27-10-1957) con leader Tristano Codignola.
Bonfantini, sempre collocato nella sinistra socialdemocratica, accanto a Zagari, Mondolfo e Faravelli, era rientrato, dopo alcuni anni di assenza, nella direzione del PSDI a seguito dei congressi del 1954 e del 1956. Alle elezioni politiche del 25-26 maggio 1958 fu rieletto per la terza volta alla Camera[30], nello stesso collegio di sempre.
Il tema dell'unificazione socialista, alla luce di quelle novità politiche e dei positivi risultati alle elezioni, dopo dieci anni di separazione, era ritornato di attualità. Ma a dare decisivo impulso alla tematica unitaria furono le conclusioni del 33° congresso del PSI (Napoli, 15-18/1/1959), che assegnò la vittoria alla corrente autonomista, assestata su posizioni assai apprezzate dalla sinistra socialdemocratica, la quale infatti constatò come il congresso del PSI avesse realizzato nella loro totalità le condizioni sempre considerate fondamentali per il conseguimento dell'unificazione in un solo partito, per cui la politica di alternativa democratica potrà essere avviata a quell'attuazione a cui sono interessate e dovranno concorrere tutte le forze socialiste del Paese[31].
Tali considerazioni non furono per nulla condivise dalla maggioranza del PSDI e il braccio di ferro interno nella socialdemocrazia si concluse con la scissione della sinistra che costituì il Movimento Unitario di Iniziativa Socialista (MUIS)[32], che successivamente (19-6-1959) confluì nel PSI. Bonfantini e altri quattro deputati[33] lasciarono il partito e il 24-7-1959 aderirono al gruppo parlamentare del PSI. Alla scadenza della legislatura Bonfantini si dedicò per lo più ad attività nelle associazioni partigiane. In particolare fu fondatore dell'Unione Italiana della Resistenza (UIR) e diresse la sezione ANPI di Milano. Sull'Avanti! del 25 aprile 1968 pubblicò un articolo rievocativo della Resistenza, intitolato Avventura partigiana nella Torino del 1944[34]. Quando i socialdemocratici si scissero per la seconda (5-7-1969) volta dal partito socialista[35], egli scelse di rimanere nel PSI.
Morì a Imperia il 9 agosto del 1989. L'Avanti! dell'11 agosto 1989 gli dedicò il seguente articolo commemorativo:
Si è spento mercoledì ad Imperia, per un arresto cardiaco, il compagno Corrado Bonfantini. Aveva 80 anni. A lui sono legate alcune indimenticabili pagine della storia del socialismo italiano. Bonfantini, come diceva Nenni, aveva l'abitudine di «buttarsi avanti e di fare e strafare». Fu proprio questo suo tipico carattere di uomo d'azione, di tenace combattente, che sempre lo distinse, fin da quando, all'età di 16 anni, scelse la strada dell'impegno politico per condurre le sue battaglie in difesa della libertà e degli interessi delle classi lavoratrici.
Nato a Novara il 22 febbraio 1909, Bonfantini si laurea in medicina ed esercita la professione di medico chirurgo prima a Torino e successivamente a Milano. Il suo impegno politico, che in giovane età gli aveva procurato una condanna ad un anno e mezzo di reclusione, si traduce in un'aperta avversione al fascismo. Perseguitato dal regime per la sua attività di opposizione, subisce ripetute condanne. Dopo essere stato incarcerato, è confinato nel '33 a Ponza, dove si stacca dal Partito comunista e si iscrive al PSI.
Nel '41 Bonfantini è fra i promotori della rinascita clandestina del partito socialista e, due anni più tardi, dopo il 25 luglio del '43, entra a far parte della direzione del partito. Per il PSl si impegna nella lotta clandestina. Organizza e comanda le «Brigate Matteotti», partecipa alla liberazione dell'Ossola e, al fianco di Pertini, all'insurrezione di Milano.
Nel dopoguerra a Torino è segretario regionale del PSIUP, fonda il quotidiano socialista Mondo Nuovo e, più tardi, promuove la nascita del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani.
Nel '46 è eletto alla Costituente e rieletto come deputato nei '48, nel '53 e nel '58, questa volta nelle file del PSDI. Un anno più tardi si iscrive come indipendente al gruppo parlamentare socialista.
«La sua vita - ha detto la moglie, Elisabetta Pontermayer - è stata generosissima; ha sempre e solo dato. E' stato un animo unico».
mi.lo.
Una commossa e toccante rievocazione del partigiano “Corrado” fu pubblicata dal giornale online Zona Nove dell'aprile 2018, pag. 15, nella rubrica “lettere in redazione”:
L'acceso dibattito interno del PSDI si concluse con la vittoria dell'ala saragattiana e la sinistra ne uscì ridimensionata, anche perché una sua ala lasciò il partito[29], mentre quella riunita attorno a Critica Sociale (Faravelli, Mondolfo) e gli ultimi eredi di Iniziativa Socialista preferirono continuare la loro lotta all'interno del partito.
La legge fu approvata dal Parlamento, a maggioranza centrista, nonostante la forte opposizione delle sinistre (PSI, PCI) e delle destre (PNM, MSI), ma non produsse i suoi effetti maggioritari, giacché la coalizione centrista (DC-PSDI-PRI-PLI) non riuscì a raggiungere il quorum richiesto. Il PSDI ne pagò lo scotto anche sul piano elettorale, in quanto alle elezioni politiche del 7-8 giugno 1953 scese da 33 a 19 deputati. Bonfantini comunque fu rieletto, ancora nel collegio Torino-Novara-Vercelli.
Gli anni che seguirono furono densi di avvenimenti in campo socialista:
Il dialogo con i cattolici avviato dal PSI nel 1955, gli articoli di Nenni sul XX congresso del PCUS e la destalinizzazione, la rivoluzione ungherese, la rottura del Patto d'unità d'azione PSI-PCI, la distensione internazionale, l'incontro Nenni-Saragat di Pralognan (Savoia) del 25-8-1956, il congresso di Venezia del PSI del 1957, la costituzione di giunte locali di centro-sinistra, il sorgere di una corrente autonomista capeggiata da Pietro Nenni avviarono il PSI ad abbandonare la politica frontista e a intraprendere la strada dell'autonomia socialista.
La sinistra socialdemocratica, ora collaborando ora polemizzando col resto del partito ormai saldamente in mano a Saragat, aveva seguito con attenzione l'evolversi della politica del PSI, in cui intanto erano confluite l'Unione socialista Indipendente (24-3-1957), guidata da Valdo Magnani e Unità Popolare (27-10-1957) con leader Tristano Codignola.
Bonfantini, sempre collocato nella sinistra socialdemocratica, accanto a Zagari, Mondolfo e Faravelli, era rientrato, dopo alcuni anni di assenza, nella direzione del PSDI a seguito dei congressi del 1954 e del 1956. Alle elezioni politiche del 25-26 maggio 1958 fu rieletto per la terza volta alla Camera[30], nello stesso collegio di sempre.
Il tema dell'unificazione socialista, alla luce di quelle novità politiche e dei positivi risultati alle elezioni, dopo dieci anni di separazione, era ritornato di attualità. Ma a dare decisivo impulso alla tematica unitaria furono le conclusioni del 33° congresso del PSI (Napoli, 15-18/1/1959), che assegnò la vittoria alla corrente autonomista, assestata su posizioni assai apprezzate dalla sinistra socialdemocratica, la quale infatti constatò come il congresso del PSI avesse realizzato nella loro totalità le condizioni sempre considerate fondamentali per il conseguimento dell'unificazione in un solo partito, per cui la politica di alternativa democratica potrà essere avviata a quell'attuazione a cui sono interessate e dovranno concorrere tutte le forze socialiste del Paese[31].
Tali considerazioni non furono per nulla condivise dalla maggioranza del PSDI e il braccio di ferro interno nella socialdemocrazia si concluse con la scissione della sinistra che costituì il Movimento Unitario di Iniziativa Socialista (MUIS)[32], che successivamente (19-6-1959) confluì nel PSI. Bonfantini e altri quattro deputati[33] lasciarono il partito e il 24-7-1959 aderirono al gruppo parlamentare del PSI. Alla scadenza della legislatura Bonfantini si dedicò per lo più ad attività nelle associazioni partigiane. In particolare fu fondatore dell'Unione Italiana della Resistenza (UIR) e diresse la sezione ANPI di Milano. Sull'Avanti! del 25 aprile 1968 pubblicò un articolo rievocativo della Resistenza, intitolato Avventura partigiana nella Torino del 1944[34]. Quando i socialdemocratici si scissero per la seconda (5-7-1969) volta dal partito socialista[35], egli scelse di rimanere nel PSI.
Morì a Imperia il 9 agosto del 1989. L'Avanti! dell'11 agosto 1989 gli dedicò il seguente articolo commemorativo:
Si è spento mercoledì ad Imperia, per un arresto cardiaco, il compagno Corrado Bonfantini. Aveva 80 anni. A lui sono legate alcune indimenticabili pagine della storia del socialismo italiano. Bonfantini, come diceva Nenni, aveva l'abitudine di «buttarsi avanti e di fare e strafare». Fu proprio questo suo tipico carattere di uomo d'azione, di tenace combattente, che sempre lo distinse, fin da quando, all'età di 16 anni, scelse la strada dell'impegno politico per condurre le sue battaglie in difesa della libertà e degli interessi delle classi lavoratrici.
Nato a Novara il 22 febbraio 1909, Bonfantini si laurea in medicina ed esercita la professione di medico chirurgo prima a Torino e successivamente a Milano. Il suo impegno politico, che in giovane età gli aveva procurato una condanna ad un anno e mezzo di reclusione, si traduce in un'aperta avversione al fascismo. Perseguitato dal regime per la sua attività di opposizione, subisce ripetute condanne. Dopo essere stato incarcerato, è confinato nel '33 a Ponza, dove si stacca dal Partito comunista e si iscrive al PSI.
Nel '41 Bonfantini è fra i promotori della rinascita clandestina del partito socialista e, due anni più tardi, dopo il 25 luglio del '43, entra a far parte della direzione del partito. Per il PSl si impegna nella lotta clandestina. Organizza e comanda le «Brigate Matteotti», partecipa alla liberazione dell'Ossola e, al fianco di Pertini, all'insurrezione di Milano.
Nel dopoguerra a Torino è segretario regionale del PSIUP, fonda il quotidiano socialista Mondo Nuovo e, più tardi, promuove la nascita del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani.
Nel '46 è eletto alla Costituente e rieletto come deputato nei '48, nel '53 e nel '58, questa volta nelle file del PSDI. Un anno più tardi si iscrive come indipendente al gruppo parlamentare socialista.
«La sua vita - ha detto la moglie, Elisabetta Pontermayer - è stata generosissima; ha sempre e solo dato. E' stato un animo unico».
mi.lo.
Una commossa e toccante rievocazione del partigiano “Corrado” fu pubblicata dal giornale online Zona Nove dell'aprile 2018, pag. 15, nella rubrica “lettere in redazione”:
UN RICORDO DI CORRADO BONFANTINI (titolo redazionale)
Sono stata la compagna di Corrado Bonfantini, Comandante Generale delle Brigate Matteotti, noto per la sua grande umanità, qualità assai rara, e per la sua vita dedicata agli ideali del Socialismo. Medico dei poveri a Novara, confino a Ponza, incarcerato varie volte, vorrei ricordare un episodio della sua vita durante gli anni della Resistenza. Tramite un accordo con l’allora prefetto di Milano e con la collaborazione del Comandante delle Brigate Libertarie Bruzzi-Malatesta Michele Concordia, fu arrestata la Banda Koch nella famigerata Villa Triste, dove venivano torturati con orribili sevizie antifascisti ed ebrei, liberando così un rilevante numero di prigionieri. Fra questi persone di rilievo politico e semplici cittadini, vorrei ricordare la Sua persona, che è stata inserita nel Giardino dei Giusti Online per i suoi meriti, oltre che nel Famedio al Cimitero Monumentale. Ricordo che negli anni settanta era stato invitato dalla Cooperativa Sociale di Niguarda per un discorso in occasione di un 25 Aprile. In questo mondo così cambiato, la memoria di queste persone che hanno dedicato la vita per la nostra libertà va tenuta sempre viva. Marilena Dossena (aprile).
Sono stata la compagna di Corrado Bonfantini, Comandante Generale delle Brigate Matteotti, noto per la sua grande umanità, qualità assai rara, e per la sua vita dedicata agli ideali del Socialismo. Medico dei poveri a Novara, confino a Ponza, incarcerato varie volte, vorrei ricordare un episodio della sua vita durante gli anni della Resistenza. Tramite un accordo con l’allora prefetto di Milano e con la collaborazione del Comandante delle Brigate Libertarie Bruzzi-Malatesta Michele Concordia, fu arrestata la Banda Koch nella famigerata Villa Triste, dove venivano torturati con orribili sevizie antifascisti ed ebrei, liberando così un rilevante numero di prigionieri. Fra questi persone di rilievo politico e semplici cittadini, vorrei ricordare la Sua persona, che è stata inserita nel Giardino dei Giusti Online per i suoi meriti, oltre che nel Famedio al Cimitero Monumentale. Ricordo che negli anni settanta era stato invitato dalla Cooperativa Sociale di Niguarda per un discorso in occasione di un 25 Aprile. In questo mondo così cambiato, la memoria di queste persone che hanno dedicato la vita per la nostra libertà va tenuta sempre viva. Marilena Dossena (aprile).
- Il padre, professore di matematica e fisica, iscritto al PSI dal 1895, nel 1910 venne eletto consigliere comunale di Novara, poi riconfermato nel 1914, diventando l'anno dopo vicesindaco dell'amministrazione del medico Luigi Giulietti, anch'egli socialista. Il 26 agosto 1915 divenne sindaco della Città. Rieletto nel 1920 rimase in carica fino al giugno 1922, quando, in seguito ad un'azione squadristica, con la solita motivazione di dover mantenere l'ordine pubblico, il Prefetto sciolse l'Amministrazione comunale. Bonfantini padre, tuttavia, pur perseguitato dai fascisti, rimase in politica e nel 1925 fu eletto consigliere provinciale. Durante la guerra collaborò con la Resistenza e nel 1947 aderì al PSLI. L'anno dopo passò all'Unione dei Socialisti (UdS). Nel 1952 fu eletto, come indipendente nella lista del PSI, consigliere provinciale, divenendo infine Presidente della Provincia, col sostegno dell'intero schieramento di sinistra (PCI, PSI, PSDI). Concluse la sua carriera come Provveditore agli Studi.
- Maria Ferrari era figlia del garibaldino Gaetano Ferrari, il quale partecipò alla seconda fase della spedizione dei Mille, da Milazzo al Volturno, e scrisse il diario Memorie di guerra e brigantaggio.
- Mario Bonfantini (1904-1978), docente universitario di Letteratura francese, scrittore e critico letterario, fu un fervente antifascista. Nel 1944 si salvò dal campo di concentramento buttandosi dal treno che lo portava in Germania e successivamente aderì alla Resistenza.
- Sergio Bonfantini (1910-1989), pittore, fu partigiano combattente come i fratelli Mario e Corrado.
- Felicino (Cino) Bonfantini (1912-1944), medico pediatra, fu sottotenente dell'esercito, combattente in Grecia. Dopo l'8 settembre fu arrestato dai tedeschi e inviato nel campo di concentramento di Dortmund in Vestfalia, dove curava i compatrioti e dove si spense il 13-6-1944.
- L'adesione al PSU avvenne nello studio dell'avv. Porzio Giovanola (1889-1949) segretario della sezione, vittima di un'aggressione fascista assieme ad Alberto Jacometti, e futuro sindaco di Novara (1947-1949).
- Il PSU era sorto il 4-10-1924, con segretario Giacomo Matteotti, da una scissione dell'ala riformista del PSI, ormai dominato dai massimalisti. In seguito al fallito attentato Zaniboni contro Mussolini il PSU fu sciolto (6-11-1925), ma i riformisti si riorganizzarono rifondandolo (29-11-1925) come PSLI. Quando tutti i partiti antifascisti furono sciolti (16-11-1926) il PSLI si trasferì in Francia, dove assunse (19-12-1927) la denominazione di Partito Socialista Unitario dei Lavoratori Italiani (PSULI). Il 19-7-1930 si fuse con l'ala PSI fusionista di Nenni, dando vita al Partito Socialista Italiano/ Sezione dell'Internazionale Operaia Socialista (PSI/IOS) con segretario Ugo Coccia.
- La sua formazione libertaria e socialista e la sua indipendenza di giudizio col tempo si scontreranno con la disciplina vigente nel PCdI, per cui Bonfantini, maldisposto ad accettare supinamente le direttive del partito, romperà con esso all'inizio del 1934.
- La sua tesi di laurea era intitolata “La posizione della biologia in una nuova filosofia della scienza con particolare riguardo alla clinica”.
- MUP fu fondato a Milano il 10-1-1943. Vi aderivano, oltre Basso e Bonfantini, alcuni futuri dirigenti socialisti di spicco come Carlo Andreoni, Lucio Luzzatto, Domenico Viotto.
- Confluirono nel PSIUP: a) Il PSI. Disperso in seguito all'occupazione dell'intera Francia da parte dei nazisti, era stato clandestinamente ricostituito in Italia il 29-7-1942, per iniziativa soprattutto di Giuseppe Romita e di Oreste Lizzadri; b) il MUP; c) l'Unione proletaria (UP) formata da giovani antifascisti romani, come Giuliano Vassalli, Mario Zagari e Tullio Vecchietti.
- La Direzione era così composta: Pietro Nenni (segretario), Sandro Pertini (vicesegretario), Giuseppe Saragat, Rodolfo Morandi, Bruno Buozzi, Emilio Canevari, Giuseppe Romita, Oreste Lizzadri, Nicola Perrotta, Marcello Cirenei, Vannuccio Taralli, Filippo Acciarini, Carmine Mancinelli (ex PSI); Lelio Basso, Carlo Andreoni (vicesegretario), Lucio Luzzatto, Corrado Bonfantini, Roberto Verari, Gianguido Borghese (ex MUP); Giuliano Vassalli, Mario Zagari, Vezio Crisafulli, Tullio Vecchietti (ex UP).
- Ne facevano parte sei partiti: PCI, PSIUP, PdAz, Democrazia del Lavoro, DC, PLI. Il PSIUP vi era rappresentato da Pietro Nenni e Giuseppe Romita. Il 17-10-1943 fu stipulato un nuovo Patto di unità d'azione fra PCI e PSIUP, per il quale firmarono Pietro Nenni, Sandro Pertini e Giuseppe Saragat.
- Pertini era anche rappresentante del PSIUP nella Giunta militare centrale del CLN.
- Le Brigate Matteotti, nella primavera del 1945, quindi alla fine del conflitto, organizzavano circa 20.000 partigiani.
- In ogni regione fu costituito un comando, al quale facevano capo i comandi provinciali. Giornale ufficiale nazionale delle Matteotti fu Il Partigiano, il cui primo numero uscì nel gennaio 1944.
- La sua storia é raccontata nel libro del grande giornalista Giorgio Bocca, partigiano egli stesso, intitolato Una repubblica partigiana (1964) e in uno sceneggiato televisivo diretto da Leandro Castellani intitolato Quaranta giorni di libertà (1974). Uno dei componenti della Giunta era Mario Bonfantini, fratello di Corrado.
- Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), con sede clandestina a Milano, era un'emanazione, per il territorio occupato dai tedeschi, del CLN centrale di Roma.
- Pertini nell'agosto 1944, dopo aver partecipato alla liberazione di Firenze, era stato richiamato a Roma. Tornerà al Nord, attraverso la Francia, nell'ottobre 1944.
- Il PSIUP col suo 20,68 %, si classificò secondo dopo la DC e ottenne 115/556 deputati.
- Contemporaneamente il PSIUP decise di tornare all'antica denominazione di PSI.
- La Direzione del PSLI fu costituita da Faravelli, Saragat, Simonini, Martoni, Castiglioni, Spalla, Mondolfo, Schiavi, Viotto, Guazza, Pietra, Vassalli, Zagari, Bonfantini, Dagnino, M. Matteotti, Valcarenghi, Chignoli, Tolino, Russo, Vera Lombardi; D’Aragona, Corsi, Tremelloni, in qualità di membri del governo; Treves in qualità di membro del Comitato direttivo de “L’Umanità”; Carnevali in rappresentanza del Gruppo parlamentare; Solari in rappresentanza della Federazione Giovanile. La segreteria politica era composta da Faravelli, Simonini e Vassalli. Segretario amministrativo Casati.
- L'Unione dei Socialisti (UdS), con segretario Ivan Matteo Lombardo e vicesegretario Marco Alberto Rollier era sorta , nel corso di un “convegno dei socialisti indipendenti” del 7-8 febbraio 1948, dalla confluenza di tre diverse formazioni politiche: a) il gruppo di estrema destra del PSI di I. M. Lombardo, che aveva lasciato il Partito; b) il gruppo che ruotava intorno alla rivista Europa Socialista e al suo direttore Ignazio Silone; c) Il gruppo di ex azionisti non confluiti nel PSI, denominato “Movimento di Azione Socialista-Giustizia e Libertà”, guidato da Tristano Codignola.
- Per un discorso organico su nascita e vita del PSU si veda: Ferdinando Leonzio Il Partito Socialista Unitario (1949-1951) – 2°, pubblicato dal mensile online La Rivoluzione Democratica del febbraio 2019.
- La prima Direzione del PSU era composta da Ugo Guido Mondolfo (segretario), Tristano Codignola, Matteo Matteotti, Italo Viglianesi (vicesegretari), Amadio, Bonfantini, Borghesi, Carmagnola, Cartia, Cossu, Faravelli, Garosci, Luisetti, Paresce, Pecoraro, Schiano, Silone, Tolino, Vassalli, Vittorelli, Zagari e i capigruppo della Camera (Vigorelli) e del Senato (Romita). Organo del partito era Lotta socialista, con direttore Giuseppe Faravelli. Suoi segretari furono Ugo Guido Mondolfo, Ignazio Silone e Giuseppe Romita.
- Il PSU fu l'unico partito socialista ad essere riconosciuto dal Comisco (Sigla del “Comitato della Conferenza Internazionale Socialista”), costituito nel novembre 1946, che nel 1951 diventerà Internazionale Socialista (IS).
- Della nuova Direzione facevano parte, per la maggioranza, oltre il segretario Giuseppe Romita, Albergo Arnone, Battistini, Colajanni, Cossu, Costa, Di Giovanni, Luisetti, Lupis, Orlandi, Russo, Tanassi; per la minoranza: Bonfantini, Carmagnola, Codignola, Faravelli, M. Matteotti, U.G. Mondolfo, Silone, Zagari.
- La nuova legge assegnava i due terzi dei seggi della Camera al partito o coalizione di partiti che avessero ottenuto almeno il 50 % + 1 dei voti validi.
- L'ala guidata da Tristano Codignola (espulso dal PSDI il 23-12-1952), essenzialmente quella degli ex azionisti, finì per lasciare il PSDI, per poi formare il Movimento di Autonomia Socialista (MAS); quest'ultimo, assieme alla minoranza uscita dal PRI e guidata da Ferruccio Parri, nell'aprile 1953 formò il movimento di Unità Popolare (UP), che avrà una funzione assai importante nell'impedire che alle elezioni politiche del 7-8 giugno 1953 scattasse il meccanismo della legge-truffa.
- Il Psdi ottenne alla Camera il 4,55 % e 22/596 seggi; il PSI il 14,23 % e 84 seggi.
- In Avanti! del 20-1-1959.
- Sul processo di formazione del MUIS e sulla sua azione si veda: Ferdinando Leonzio Il Movimento Unitario di Iniziativa Socialista (1959), pubblicato dal mensile online La Rivoluzione Democratica del marzo 2020.
- I deputati erano: Corrado Bonfantini, Ezio Vigorelli (che si era già dimesso da ministro), Orlando Lucchi, Matteo Matteotti (ex segretario del PSDI), e Pasquale Schiano.
- L'articolo fu ripubblicato dal quotidiano La Stampa del 25 aprile 1979.
- PSI e PSDI si erano riunificati il 30-10-1966 (Costituente Socialista).
Fonte: di Ferdinando Leonzio