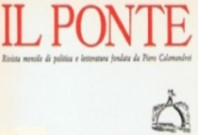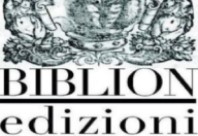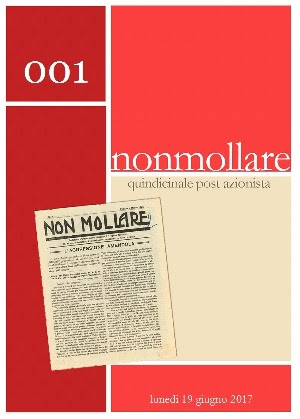AFRICA, FRANCIA, EUROPA. IL PASSATO DURA di Elena Clara Savino
di Elena Clara Savino
20-07-2025 - IL SOCIALISMO NEL MONDO
Mentre assistiamo sgomenti e addolorati ai rivolgimenti mondiali che scardinano alle radici il vecchio mondo e modificano gli equilibri geostrategici dei continenti; mentre il cosiddetto Occidente assiste al crollo del sistema giuridico internazionale basato sui diritti riconosciuti dall'ONU alla sua fondazione nel 1945; mentre due guerre atroci, più delle altre, in Ucraina e in Medio Oriente devastano territori e impoveriscono le nazioni, è in corso in Africa una rivoluzione titanica per liberarsi dal giogo imperialista. I fatti della storia sono legati e il risveglio del panafricanismo, oggi con una connotazione francamente ostile alle potenze europee e agli Stati Uniti, è conseguenza della cattiva gestione dei rapporti che l'Occidente ha intrattenuto con le ex-colonie diventate indipendenti. I rapporti di marca imperiale, con i clichés che li accompagnano – paternalismo, accordi commerciali asimmetrici, controllo della moneta, aiuti umanitari, contratti commerciali leonini, etc. – sono divenuti indigeribili specie rispetto alla Francia, che per tenere in piedi l'Impero ha reiventato un sistema coloniale complesso, ingabbiando ogni settore della vita delle nazioni africane bambine.
Dalla fine della Seconda guerra mondiale, la battaglia nell'Africa francofona per ottenere quello che era stato stabilito dall'ONU, garante del percorso delle ex-colonie verso l'indipendenza, è stata eroica, ma perdente. I primi quindici anni dopo la guerra sono stati segnati da soprusi, inganni, violazioni del diritto, repressioni sanguinolente, poi con il ritorno al potere di Charles de Gaulle nel 1958, il tutto è stato incanalato entro un sistema neo-imperiale che investiva ogni settore della vita pubblica. Le tappe dell'autonomia e la costruzione di Stati democratici nelle ex-colonie francesi sono state ritardate e ostacolate, le soluzioni imposte dalla Francia in continuità con il passato sono andate contro l'indipendenza delle nazioni, il diritto internazionale, la giustizia.
In Francia conoscono bene il termine FrançAfrique, che indica e stigmatizza la corruzione e la violenza esercitata in Africa dall'antico padrone. Con indulgenza, privilegiando gli aspetti istituzionali, possiamo definire la FrançAfrique come un sistema integrato militare, politico e finanziario in un periodo circoscritto, che va grossomodo dalla fine degli anni Cinquanta alle riforme democratiche di fine secolo, e che si trasforma nel tempo senza tuttavia sparire. In concreto la FrançAfrique circoscrive una certa politica della V Repubblica inaugurata da de Gaulle, che ha istituzionalizzato la prevalenza dell'Eliseo negli affari africani, con una certa segretezza e l'utilizzo sovente di mezzi illeciti in contesti specifici. Simbolo e strumento di questa politica è stata la creazione del Secrétariat générale des Affaires Africaines et Malgasches, trasformato poi semplicemente in “cellule Afrique” affidata tra il 1960 e il 1974 a Jacques Foccart, diplomatico e uomo d'affari gollista, descritto sulla stampa francese con toni sulfurei.
I casi eclatanti nel campo dell'illecito sono molti, così come numerosi sono le repressioni e gli assassinii che hanno decapitato quelle che potevano essere le nuove classi dirigenti delle nazioni africane, che avevano il compito immenso di costruire Stati democratici sulle macerie del colonialismo e a partire da indipendenze a sovranità limitata concesse (octroyées) solo nel 1960. La lista dei martiri dell'indipendenza del continente nero (come si diceva una volta) è lunghissima e non la rifarò, ma voglio ricordare almeno la figura, troppo spesso dimenticata, di Sylvanus Olympio, campione del panafricanismo, con un curriculum eccezionale di resistente e primo presidente eletto del Togo indipendente, assassinato nel 1963.
Fino alle soglie del nuovo secolo lo schema disegnato da de Gaulle non è stato messo in discussione, semmai è stato integrato con qualche aggiustamento nei meccanismi pratici per soddisfare gli interessi del portafoglio e lo status di potenza mondiale della V Repubblica, in ogni caso garantito dai trattati di difesa, che hanno costituito la spina dorsale dei rapporti franco-africani. La continuità e la durata della presenza militare francese in Africa sono parsi a qualcuno l'evidente trait d'union fra l'età coloniale e quella postcoloniale. E si può dire che anche la riforma della strategia militare africana, abbozzata all'inizio degli anni duemila sotto la presidenza Sarkozy, si è inserita in una lenta e coerente evoluzione. Gli obiettivi chiariti nel discorso davanti al Parlamento sud-africano a Le Cap il 28 febbraio 2008 erano diversi: trasformare l'assistenza militare in orientamento, formazione, sostegno diplomatico; coinvolgere le architetture regionali presenti già sul terreno; e, soprattutto, fare dell'Europa un partner maggiore negli affari africani. Nicolas Sarkozy inseguiva una dimensione regionale del coinvolgimento bellico della Francia, che doveva rimanere in ogni caso arbitra della situazione. Dal canto suo il resto dell'Europa continuava a tollerare l'egemonia arbitraria dei francesi in Africa.
I meccanismi economico-finanziari facevano da sfondo. Il franco CFA (Colonie Francesi d'Africa) ha imposto regole che hanno impoverito le economie degli Stati interessati e col tempo, per mettere a proprio agio i grandi investitori stranieri, sono stati migliorati i meccanismi finanziari e legali e si è estesa la pratica delle privatizzazioni di società e servizi di interesse nazionale. Negli anni Novanta del '900 sono continuati i finanziamenti del ministero della Cooperazione in aiuto allo sviluppo democratico e civile, accanto ad accordi commerciali e militari che assicuravano rendite e guadagni illeciti a personaggi in bilico tra sfera pubblica e privata. La Francia, per coprire i buchi del suo smisurato bilancio, ha sempre attinto dal bacino africano. I dissesti dell'economia francese dopo la Prima guerra mondiale, quelli seguiti alla crisi del '29 e i costi della ricostruzione dopo il 1945, sono stati pagati in buona parte dai paesi africani. E nei decenni successivi i meccanismi di prelievo delle ricchezze sono stati consolidati, fino alle crisi petrolifere degli anni Settanta e fino alla svalutazione del franco CFA nel 1994.
Il risultato dell'incredibile costruzione economica, finanziaria, militare e diplomatica franco-africana è stata la indipendenza solo formale degli Stati dell'area francofona che hanno continuato ad essere legati politicamente e sfruttati economicamente. Conoscere questo passato e il termine FrançAfrique, il suo contenuto storico e fattuale, è necessario per capire il carattere antifrancese dei rivolgimenti nell'Africa Occidentale Subsahariana e, in particolare, l'appoggio incondizionato dei popoli africani alle giunte militari andate al potere dal 2020 in Mali, Burkina Faso, Niger. Anche i governi democraticamente eletti, come in Senegal, hanno una connotazione antifrancese.
L'analisi storica mette in evidenza una contraddizione eclatante, ossia il doppio binario entro cui si è svolta la vita della V Repubblica: all'interno governata secondo i principi umanitari e costituzionali di una matura democrazia; fuori dai propri confini guidata da interessi nazionali per i quali non vi è mai stata legge alcuna. Il capitolo più controverso della presenza francese in Africa rimane quello militare. Le alleanze di difesa, guidate dalle contingenze di ogni paese, hanno assicurato uno stretto controllo della vecchia potenza sugli orientamenti di vaste aree dell'Africa subsahariana, anche con funzioni di polizia interna agli Stati, e hanno assicurato vantaggi strategici e commerciali enormi (vendita di armi e tecnologia militare, invio di tecnici e personale dalle competenze specifiche, servizi d'intelligence e orientamento, etc.). Il sostegno della Francia alle dittature dell'Africa, garantito da tali accordi militari e di cooperazione, serviva – come esplicitamente detto dal ministro Terrot nel rapporto al Parlamento del 2011 – «alla politica di influenza che il governo francese intende esercitare di fronte alle antiche colonie, in un contesto internazionale teso». Sotto il profilo brutale del do ut des, per i governanti africani la contropartita della vincolante presenza militare francese erano gli aiuti umanitari.
La Francia è andata via via diminuendo i suoi effettivi nelle vecchie colonie e, secondo principi abbozzati già dall'ultimo Mitterrand, ha garantito le sue esigenze con proposte d'intervento multilaterali sotto l'egida dell'ONU e dell'Unione europea. Ma l'europeizzazione dei problemi del continente mai ha significato in Francia una diminuzione dell'influenza. Anzi, sul terreno della «cooperazione alla sicurezza e alla difesa» lo sforzo è stato mantenuto ad un livello elevato. Il rapporto del ministero degli Esteri e della Difesa presentato nel 2010 al Parlamento francese confermava che gli accordi di «partenariato di difesa», un importante passo nel rimaneggiamento della strategia francese, non mettevano in discussione la storica leadership della Francia in Africa. Questo assetto, però, va ormai sbriciolandosi sotto i colpi delle giunte militari salite al potere nel Sahel, che hanno letteralmente intimato ai militari francesi di lasciare i loro territori. Emmanuel Macron sta gestendo male il ritiro della Francia dall'Africa e resiste in modo maldestro all'ondata antifrancese che percorre gli stati francofoni. A Ouagadougou, il 28 novembre 2017, Macron ha lasciato esterrefatta la platea africana affermando che «il franco CFA non è un soggetto per la Francia». Una fracassata simile non si sentiva dai tempi di Jacques Chirac e qualcuno in Africa l'ha definita «imprecisa e caricaturale». Ufficialmente non vi è stata alcuna reazione dei governi africani, ma la questione è bruciante e recentemente vi sono state chiare dichiarazioni di Ibrahim Traoré (militare e presidente del Burkina Faso dal colpo di Stato del 2022), che considera il franco CFA una eredità anacronistica del periodo coloniale e lesiva della sovranità dei paesi che ne sono soggetti.
Macron ancora recentemente ha dato prova della sua cattiva conoscenza del complesso dossier franco-africano con una inconsistente dichiarazione che pretendeva riconoscenza per la civiltà portata dalla Francia, secondo uno dei più vieti stereotipi del colonialismo ottocentesco. Le sue parole, tinte di superiorità e paternalismo, hanno sollevato una forte indignazione e proteste ovunque in Africa. I temi che ha sollevato la dichiarazione di Macron sono molti, ma è almeno necessario sottolineare come ai vertici della Repubblica manca ancora una chiara e consapevole presa di coscienza delle responsabilità immense di una condotta infame, tollerata nel contesto della Guerra fredda dalle potenze del blocco Nato, che hanno fatto della Francia il gendarme in Africa della loro presenza ideale e materiale.
Fonti
Dalla fine della Seconda guerra mondiale, la battaglia nell'Africa francofona per ottenere quello che era stato stabilito dall'ONU, garante del percorso delle ex-colonie verso l'indipendenza, è stata eroica, ma perdente. I primi quindici anni dopo la guerra sono stati segnati da soprusi, inganni, violazioni del diritto, repressioni sanguinolente, poi con il ritorno al potere di Charles de Gaulle nel 1958, il tutto è stato incanalato entro un sistema neo-imperiale che investiva ogni settore della vita pubblica. Le tappe dell'autonomia e la costruzione di Stati democratici nelle ex-colonie francesi sono state ritardate e ostacolate, le soluzioni imposte dalla Francia in continuità con il passato sono andate contro l'indipendenza delle nazioni, il diritto internazionale, la giustizia.
In Francia conoscono bene il termine FrançAfrique, che indica e stigmatizza la corruzione e la violenza esercitata in Africa dall'antico padrone. Con indulgenza, privilegiando gli aspetti istituzionali, possiamo definire la FrançAfrique come un sistema integrato militare, politico e finanziario in un periodo circoscritto, che va grossomodo dalla fine degli anni Cinquanta alle riforme democratiche di fine secolo, e che si trasforma nel tempo senza tuttavia sparire. In concreto la FrançAfrique circoscrive una certa politica della V Repubblica inaugurata da de Gaulle, che ha istituzionalizzato la prevalenza dell'Eliseo negli affari africani, con una certa segretezza e l'utilizzo sovente di mezzi illeciti in contesti specifici. Simbolo e strumento di questa politica è stata la creazione del Secrétariat générale des Affaires Africaines et Malgasches, trasformato poi semplicemente in “cellule Afrique” affidata tra il 1960 e il 1974 a Jacques Foccart, diplomatico e uomo d'affari gollista, descritto sulla stampa francese con toni sulfurei.
I casi eclatanti nel campo dell'illecito sono molti, così come numerosi sono le repressioni e gli assassinii che hanno decapitato quelle che potevano essere le nuove classi dirigenti delle nazioni africane, che avevano il compito immenso di costruire Stati democratici sulle macerie del colonialismo e a partire da indipendenze a sovranità limitata concesse (octroyées) solo nel 1960. La lista dei martiri dell'indipendenza del continente nero (come si diceva una volta) è lunghissima e non la rifarò, ma voglio ricordare almeno la figura, troppo spesso dimenticata, di Sylvanus Olympio, campione del panafricanismo, con un curriculum eccezionale di resistente e primo presidente eletto del Togo indipendente, assassinato nel 1963.
Fino alle soglie del nuovo secolo lo schema disegnato da de Gaulle non è stato messo in discussione, semmai è stato integrato con qualche aggiustamento nei meccanismi pratici per soddisfare gli interessi del portafoglio e lo status di potenza mondiale della V Repubblica, in ogni caso garantito dai trattati di difesa, che hanno costituito la spina dorsale dei rapporti franco-africani. La continuità e la durata della presenza militare francese in Africa sono parsi a qualcuno l'evidente trait d'union fra l'età coloniale e quella postcoloniale. E si può dire che anche la riforma della strategia militare africana, abbozzata all'inizio degli anni duemila sotto la presidenza Sarkozy, si è inserita in una lenta e coerente evoluzione. Gli obiettivi chiariti nel discorso davanti al Parlamento sud-africano a Le Cap il 28 febbraio 2008 erano diversi: trasformare l'assistenza militare in orientamento, formazione, sostegno diplomatico; coinvolgere le architetture regionali presenti già sul terreno; e, soprattutto, fare dell'Europa un partner maggiore negli affari africani. Nicolas Sarkozy inseguiva una dimensione regionale del coinvolgimento bellico della Francia, che doveva rimanere in ogni caso arbitra della situazione. Dal canto suo il resto dell'Europa continuava a tollerare l'egemonia arbitraria dei francesi in Africa.
I meccanismi economico-finanziari facevano da sfondo. Il franco CFA (Colonie Francesi d'Africa) ha imposto regole che hanno impoverito le economie degli Stati interessati e col tempo, per mettere a proprio agio i grandi investitori stranieri, sono stati migliorati i meccanismi finanziari e legali e si è estesa la pratica delle privatizzazioni di società e servizi di interesse nazionale. Negli anni Novanta del '900 sono continuati i finanziamenti del ministero della Cooperazione in aiuto allo sviluppo democratico e civile, accanto ad accordi commerciali e militari che assicuravano rendite e guadagni illeciti a personaggi in bilico tra sfera pubblica e privata. La Francia, per coprire i buchi del suo smisurato bilancio, ha sempre attinto dal bacino africano. I dissesti dell'economia francese dopo la Prima guerra mondiale, quelli seguiti alla crisi del '29 e i costi della ricostruzione dopo il 1945, sono stati pagati in buona parte dai paesi africani. E nei decenni successivi i meccanismi di prelievo delle ricchezze sono stati consolidati, fino alle crisi petrolifere degli anni Settanta e fino alla svalutazione del franco CFA nel 1994.
Il risultato dell'incredibile costruzione economica, finanziaria, militare e diplomatica franco-africana è stata la indipendenza solo formale degli Stati dell'area francofona che hanno continuato ad essere legati politicamente e sfruttati economicamente. Conoscere questo passato e il termine FrançAfrique, il suo contenuto storico e fattuale, è necessario per capire il carattere antifrancese dei rivolgimenti nell'Africa Occidentale Subsahariana e, in particolare, l'appoggio incondizionato dei popoli africani alle giunte militari andate al potere dal 2020 in Mali, Burkina Faso, Niger. Anche i governi democraticamente eletti, come in Senegal, hanno una connotazione antifrancese.
L'analisi storica mette in evidenza una contraddizione eclatante, ossia il doppio binario entro cui si è svolta la vita della V Repubblica: all'interno governata secondo i principi umanitari e costituzionali di una matura democrazia; fuori dai propri confini guidata da interessi nazionali per i quali non vi è mai stata legge alcuna. Il capitolo più controverso della presenza francese in Africa rimane quello militare. Le alleanze di difesa, guidate dalle contingenze di ogni paese, hanno assicurato uno stretto controllo della vecchia potenza sugli orientamenti di vaste aree dell'Africa subsahariana, anche con funzioni di polizia interna agli Stati, e hanno assicurato vantaggi strategici e commerciali enormi (vendita di armi e tecnologia militare, invio di tecnici e personale dalle competenze specifiche, servizi d'intelligence e orientamento, etc.). Il sostegno della Francia alle dittature dell'Africa, garantito da tali accordi militari e di cooperazione, serviva – come esplicitamente detto dal ministro Terrot nel rapporto al Parlamento del 2011 – «alla politica di influenza che il governo francese intende esercitare di fronte alle antiche colonie, in un contesto internazionale teso». Sotto il profilo brutale del do ut des, per i governanti africani la contropartita della vincolante presenza militare francese erano gli aiuti umanitari.
La Francia è andata via via diminuendo i suoi effettivi nelle vecchie colonie e, secondo principi abbozzati già dall'ultimo Mitterrand, ha garantito le sue esigenze con proposte d'intervento multilaterali sotto l'egida dell'ONU e dell'Unione europea. Ma l'europeizzazione dei problemi del continente mai ha significato in Francia una diminuzione dell'influenza. Anzi, sul terreno della «cooperazione alla sicurezza e alla difesa» lo sforzo è stato mantenuto ad un livello elevato. Il rapporto del ministero degli Esteri e della Difesa presentato nel 2010 al Parlamento francese confermava che gli accordi di «partenariato di difesa», un importante passo nel rimaneggiamento della strategia francese, non mettevano in discussione la storica leadership della Francia in Africa. Questo assetto, però, va ormai sbriciolandosi sotto i colpi delle giunte militari salite al potere nel Sahel, che hanno letteralmente intimato ai militari francesi di lasciare i loro territori. Emmanuel Macron sta gestendo male il ritiro della Francia dall'Africa e resiste in modo maldestro all'ondata antifrancese che percorre gli stati francofoni. A Ouagadougou, il 28 novembre 2017, Macron ha lasciato esterrefatta la platea africana affermando che «il franco CFA non è un soggetto per la Francia». Una fracassata simile non si sentiva dai tempi di Jacques Chirac e qualcuno in Africa l'ha definita «imprecisa e caricaturale». Ufficialmente non vi è stata alcuna reazione dei governi africani, ma la questione è bruciante e recentemente vi sono state chiare dichiarazioni di Ibrahim Traoré (militare e presidente del Burkina Faso dal colpo di Stato del 2022), che considera il franco CFA una eredità anacronistica del periodo coloniale e lesiva della sovranità dei paesi che ne sono soggetti.
Macron ancora recentemente ha dato prova della sua cattiva conoscenza del complesso dossier franco-africano con una inconsistente dichiarazione che pretendeva riconoscenza per la civiltà portata dalla Francia, secondo uno dei più vieti stereotipi del colonialismo ottocentesco. Le sue parole, tinte di superiorità e paternalismo, hanno sollevato una forte indignazione e proteste ovunque in Africa. I temi che ha sollevato la dichiarazione di Macron sono molti, ma è almeno necessario sottolineare come ai vertici della Repubblica manca ancora una chiara e consapevole presa di coscienza delle responsabilità immense di una condotta infame, tollerata nel contesto della Guerra fredda dalle potenze del blocco Nato, che hanno fatto della Francia il gendarme in Africa della loro presenza ideale e materiale.
Fonti
- Discours de M. le Président de la République devant le Parlement Sud-Africain, Le Cap, 28 février 2008.
- Rapport au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense et sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense, par Philippe Paul, 7 Juillet 2010.
- Rapport fait au nom de la commission d'affaires étrangère par Michel Terrot (n. 3308-3309-3310), Assemblée Nationale, 5 avril 2011.
- Kako Nubukpo, Franc CFA: les propos de M. Macron sont “déshonorants pour les dirigeants africains”, in «Le Monde», 29 novembre 2017
- Présidentielle française: à quoi ressemblerait la politique africaine d'Emmanuel Macron?, Interview par Marwane Ben Yahmed, in «Jeune Afrique», 5 mai 2017.
(Apparso con lo stesso titolo nella rivista online "Menti in Fuga", il 28 maggio 2025)
Fonte: di Elena Clara Savino