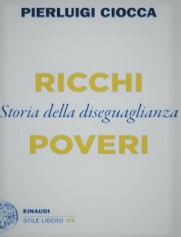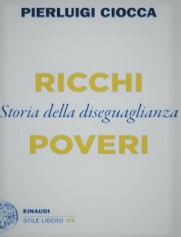“Seguendo il filo della storia millenaria, il libro ricostruisce in sintesi come redditi e patrimoni si ripartiscono e come i termini della diade ricchezza/povertà interagiscono…. Interagiscono secondo un rapporto potere-economia-istituzioni che muta nei due secoli più recenti. Nelle società tribali il potere si identificava con la forza. I forti hanno sempre dominato sui deboli. La ricchezza (il controllo sulle risorse economico-finanziarie) quasi sempre ha contribuito a consolidare il potere. “Le istituzioni hanno in vario modo favorito o contrastato gli scompensi fra ricchi e poveri”.
La povertà oggi si definisce secondo gli indici dello sviluppo umano definiti da una Commissione delle Nazioni Unite. Al di là degli indici di benessere materiale Ciocca tiene presenti le acquisizioni della migliore teoria del benessere materiale e cita i funzionamenti di Sen: ciò che possiamo o non possiamo fare, ciò che possiamo essere o non essere. Rispetto al passato, oggi la relazione ricchezza potere muove dalla ricchezza e non viceversa (31). I secoli diciannovesimo e ventesimo sono quelli dell'industrializzazione e della globalizzazione non governata che ha fatto ipotizzare a molti un ridimensionamento del ruolo dello Stato nazionale – già attaccato frontalmente da Milton Friedman e dalla sua scuola sostenendo che i fallimenti dello Stato sono più gravi di quelli del mercato.
Pur nelle sue dimensioni tascabili, il libro ha un apparato di citazioni, note esplicative e riferimenti bibliografici veramente notevole e soprattutto una mole di dati sulla diseguaglianza relativi ai diversi continenti e a singoli paesi all'interno di essi. È impossibile riassumerli in una breve presentazione e per questo motivo mi limito a presentare e discutere alcune questioni fondamentali di macroeconomia che riguardano il funzionamento del modello capitalistico - oggi egemone a livello globale.
Il tema fondamentale affrontato da Ciocca è, secondo me, il rapporto tra la crescita versus la diseguaglianza (127). Se la diseguaglianza frena la crescita e se questa ammette l'eguaglianza e/o favorisce l'eguaglianza, che fare? Ciocca (128) cita ricerche OCSE secondo cui la diseguaglianza può frenare la crescita e, al contrario, l'eguaglianza la può promuovere. È stato calcolato che la riduzione di un punto dell'indice di Gini può far aumentare la crescita dello 0,8 all'anno per un quinquennio. Cita anche uno studio del FMI che ha confermato la tesi fondamentale secondo cui la riduzione della diseguaglianza è correlata positivamente con una crescita rapida e durevole e che una moderata redistribuzione non esplica effetti negativi sulla crescita. Naturalmente ci sono altre ricerche empiriche che danno esiti meno convergenti con le prime ma non suffragano la tesi opposta di una diseguaglianza che aiuti la crescita.
Opportunamente Ciocca ritiene comprensibile che diverse ricerche empiriche in diversi paesi possano dare esiti non convergenti proprio “perché il legame fra distribuzione e crescita è mediato, nella realtà, da fattori che le statistiche approssimano con difficoltà: fattori politici, sociali, istituzionali come la tassazione e la spesa pubblica, il diritto al lavoro, le strutture proprietarie, ecc. In altre parole, il mercato lasciato a sé stesso non produce necessariamente una distribuzione o un livello di occupazione socialmente accettabili, ma questi malfunzionamenti possono essere corretti da adeguati interventi dell'operatore pubblico ai vari livelli di governo.
Ciocca ribadisce che la crescita resta condizione necessaria e centrale ma non sufficiente. “L'economia di mercato capitalistico si è affermata come “ineguagliata macchina di crescita” ma è affetta da limiti intrinseci, radicati, da negatività di grande momento: è iniqua, instabile, inquinante. Queste tre negatività sono generate dal modus operandi del sistema, connesse da legami reciproci con la sua dinamica”. Non sufficiente per produrre eguaglianza per i suddetti tre motivi fondamentali: l'iniquità, l'instabilità, e l'inquinamento che spiega, in maniera lapidaria, nelle pagine 131-32. Ho già detto della prima e lo ripeto: non c'è garanzia che il mercato produca una distribuzione equa delle risorse. La storia millenaria della diseguaglianza, magistralmente riassunta da Ciocca, ne costituisce prova provata. L'instabilità nasce da fattori di rischio connessi alle aspettative degli operatori privati e al comportamento di quelli pubblici. “se l'investimento è carente vi sarà disoccupazione, se è eccessivo vi sarà inflazione…. L'Economia è esposta all'inflazione se la domanda globale sfugge al controllo, alla deflazione se l'offerta eccede la domanda globale”. Se consideriamo che oggi siamo in fase di accelerata globalizzazione, di finanziarizzazione dell'economia che alimenta fenomeni speculativi anche a livello globale, è chiaro che il lavoro degli imprenditori privati e degli operatori pubblici si è fatto vieppiù complicato e difficile di quanto non fosse ragionando in contesti di economie più o meno chiuse o meno interdipendenti di adesso. Mi permetto di aggiungere un'altra caratteristica negativa che riguarda nello specifico l'Italia. Abbiamo una classe dirigente economica non in grado di svolgere il ruolo che le spetterebbe perché non ha un'appropriata visione della società e dello Stato. Molti suoi componenti non credono al futuro del loro Paese e quelli che hanno successo, non di rado, pensano solo a nascondere i loro guadagni nei paradisi fiscali e a evadere le imposte.
Il terzo fattore di crisi è l'inquinamento che, oltre certi livelli, produce anche il cambiamento climatico. Molte attività produttive producono diseconomie esterne che gli imprenditori non hanno interesse a porvi rimedio. Nell'anno della COP 26 abbiamo visto le difficoltà dei diversi Paesi di cooperare adeguatamente – secondo alcuni c'è mancanza di volontà di ridurre le emissioni di anidride carbonica per via dell'aumento dei costi di produzione che tale misura produrrebbe. Ci sono grossi interessi in gioco difficili da conciliare che spesso non sono combattuti adeguatamente neanche all'interno di singoli paesi. Eppure secondo una stima, citata da Ciocca, basterebbero 2 punti del PIL mondiale all'anno per circa 50 anni per contenere il riscaldamento globale a livelli sostenibili.
Ecco ho ritenuto utile ripetere queste considerazioni di Ciocca per concordare con Lui. Tutti e tre i fattori di crisi del modello capitalistico evocano un ruolo attivo dell'operatore pubblico non solo nella gestione dell'economia ma anche della società. Purtroppo da 40 anni a questa parte nel c.d. mondo occidentale imperversa l'ideologia neoliberista che ha ridimensionato consistentemente il ruolo dello Stato che in Europa si era sviluppato nei c.d. “trenta gloriosi”. Secondo alcuni a questi anni che in alcuni paesi dell'Europa centrale e del Nord avevano visto il fiorire di sistemi avanzati di welfare sono subentrati i c.d. “quaranta vergognosi” dell'egemonia neoliberista che, all'interno dell'UE, ha visto aumentare la disoccupazione, le diseguaglianze, la povertà, la divaricazione tra le regioni centrali e quelle periferiche in nome della stabilità e di un approccio mercantilistico della potenza egemone e dei suoi alleati.
Emblematico il confronto con la crescita cinese nello stesso periodo. Un caso borderline perché l'economia cinese non è programmata rigidamente secondo il vecchio modello sovietico e non è neanche un mercato capitalista di stampo occidentale. Ma è un fatto riconosciuto da molti esperti e analisti che dalla liberalizzazione introdotta da Deng negli anni ‘80 del secolo scorso l'economia cinese è cresciuta a tassi a doppia cifra e che il sistema economico ed istituzionale, in 40 anni, è riuscito a tirare fuori dalla povertà 400 – secondo altri 500- milioni di cinesi.
Sulle diseguaglianze in Italia negli ultimi due anni ha inciso da ultimo anche la pandemia. Riprendo sinteticamente i dati citati da Ciocca p. 142: “in Italia prima della pandemia versava in condizione di povertà assoluta il 7,7% della popolazione. Una tale percentuale – continua Ciocca – risultava la vergogna di un Paese ricco. Ma nel primo anno della pandemia, il 2020, è salita al 9,4% portando il numero dei molto poveri a 5,6 milioni di persone i cui consumi sono scemati rispetto al reddito. Secondo i criteri e gli obiettivi europei si trovano “a rischio povertà” – al di sotto di 850 euro al mese per persona che viva sola – 12 milioni di italiani pari al 20% della popolazione”. È chiaro che il persistere di una simile tendenza minerebbe ulteriormente la coesione sociale per la quale l'Italia si colloca agli ultimi posti nella classifica dei paesi membri dell'Unione. Se la crescita è una condizione necessaria ma non sufficiente per perseguire l'uguaglianza o, quanto meno, ridurre le diseguaglianze più macroscopiche vediamo brevemente quali sono in Italia i principali ostacoli che si frappongono al perseguimento di tale obiettivo. Sono: la bassa produttività, la bassa accumulazione di capitale fisico ed umano; lo stato penoso della nostra pubblica amministrazione centrale e sub-centrale; il livello troppo basso degli investimenti pubblici e, in particolare, di quelli nella ricerca ed innovazione; la lentezza della giustizia; il gap infrastrutturale tra Nord e Sud, la delocalizzazione di molte attività produttive innanzitutto all'interno della UE per cogliere le forti differenze nel costo del lavoro; la presenza di potenti organizzazioni criminali che introducono forti distorsioni nel funzionamento del sistema economico non solo nel Mezzogiorno ma anche la Nord (148), la corruzione diffusa.
Rimediare a questi svantaggi comparati è un compito arduo per qualsiasi governo anche perché in Italia i governi cambiano e sono diverse le strategie di riforma che essi perseguono.